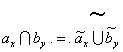Il linguaggio scientifico dei Presocratici
analizzato con lÆideografia di Peano
Salvatore Notarrigo
Preambolo
La lingua naturale Ķ uno strumento essenziale
per risolvere i problemi che lÆuomo deve affrontare nel suo vivere sociale.
Senza di essa non potrebbero esistere nĶ scienza, nĶ poeŁsia, nĶ rapporti
sociali e nemmeno chiacchiere inutili; in una parola, non potrebbe esistere la societÓ. Ma proprio per tale ragione
le lingue naturali, attraverso il loro lungo e conŁtorto sviluppo nel corso
della storia delle singole comunitÓ linguistiche, vanno accumulando ambiguitÓ,
ridondanze, contraddizioni, paradossi.
Da ci“ la necessitÓ di creare gerghi
particolari per determinate attivitÓ che a loro volta ed alla lunga
contribuiscono ad aumentare la confusione nella lingua comune; e non a caso fin
da tempi remoti si tramanda il mito della torre di Babele!
Un particolare gergo, creatosi allÆinterno di
una qualche comunitÓ, pu“ assolvere il compito per cui sÆĶ formato solo finchķ
resta circoscritto a quella comunitÓ ed allo scopo per cui Ķ nato. Ma cosņ
facendo si chiude inesorabilmente allÆinterno di se stesso e muore con il
cambiare delle condizioni al contorno relative alle attivitÓ per il cui scopo
il gergo si era venuto formando; condizioni al contorno che a loro volta si
vanno modificando anche per effetto dello stesso sviluppo sia dellÆattivitÓ che
dello stesso gergo.
La riprova di ci“ Ķ il fatto che tutti i
tentativi di creare una lingua universale, come lÆesperanto o il latino sine
flessione di Peano, ecc., sono miseramente, ma necessariamente, falliti.
Qualche volta il gergo resiste solo perchķ si
Ķ venuto trasformando in un coacervo di dogmi che, pur avendo perso ogni
significato reale, hanno strutturato in qualche modo la comunitÓ che lo usa;
trasformandola alla fine in una setta che continua a scambiarsi messaggi che
ormai risultano incomprensibili ai suoi stessi membri; per cui il gergo assume
la sola funzione di mantenere i rapporti gerarchici che si sono stabiliti
allÆinterno di essa.
Anche nella matematica e nella logica, la cui
essenza proprio consiste nella corretta manipolazione di simboli, si Ķ
verificato il fenomeno prima considerato e nel corso della loro storia Ķ
stato necessario rivoluzionare tutto per conseguire reali progressi; per cui,
come giustamente notava il Peano, la storia della matematica e quella della
logica praticamente coincidono con la storia dei loro simboli.
Ma non necessariamente il cambiamento Ķ
dovuto allÆesigenza di progredire perchķ spesso gli interessi costituiti di
determinati settori della societÓ impongono il cambiamento proprio allo scopo
di impedire una rivoluzione. E non Ķ mai stato facile distinguere la
rivoluzione dalla reazione; anche se ognuno ritiene di essere in grado di
farlo; anche se poi scopre che la sua particolare bipartizione Ķ diversa da
quella degli altri; ma la cosa, in genere, non lo preoccupa minimamente perchķ
Ķ sempre pronto a ritenere che gli altri o sono in malafede o sono dei semplici
imbecilli.1
Solo a poche persone Ķ riservata la capacitÓ
di distinguere senza farsi distogliere da pregiudizi di parte.
Uno dei rari esempi tra questi Ķ
lÆaristocratico Tomasi di Lampedusa il quale fa dire, durante lÆavanzare della
classe borghese, a uno dei suoi aristocratici personaggi che bisognava cambiare
qualche cosa perchķ tutto potesse rimanere come prima!
***
Poichķ il fenomeno di cui stiamo parlando,
cioĶ lÆinstabilitÓ dei gerghi, Ķ, al contrario, estremamente stabile,
necessariamente deve esistere un meccanismo sottostante che lo regola (per
evitare equivoci chiariamo che il termine ōinstabilitÓö viene qui usato nel
senso tecnico della teoria matematica dei sistemi complessi e cioĶ nel senso di
una situazione che per un certo tempo si muove cosņ lentamente da apparire
praticamente ferma finchķ non incontra un punto di ōcatastrofeö che ne cambia
radicalmente lÆaspetto qualitativo).
In generale, per scoprire un meccanismo,
bisogna prima ridurre il fenomeno ai suoi elementi fondamentali ed alle forze
che li sospingono. Per tale ragione, in modo nĶ esaustivo nĶ definitivo,
distingueremo quattro aspetti del linguaggio e due forze contrastanti alle
quali per“ va sempre aggiunto il principio generale dellÆentropia.
Il primo aspetto Ķ rappresentato dal
linguaggio ōpraticoö; questo serve,
in modo (pi∙ o meno) razionale, a risolvere tutti i problemi quotidiani e di
routine. Il suo fondamento Ķ costituito precipuamente dalla regola del provare
e riprovare empiricamente cercando di correggere gli errori con la metodologia
del caso per caso.
La forza che lo spinge Ķ la ōnecessitÓ della sopravvivenzaö.
Ed Ķ la stessa forza che anche lo spinge a
creare un linguaggio pi∙ sintetico ma pi∙ poŁtente, svincolato dallÆempiria e
dal caso per caso. Proprio per questa ragione esso devÆessere astratto e
generale e tuttavia estremamente preciso e quindi capace di affrontare
situazioni nuove, mai prima sperimentate. Questo costituisce il secondo aspetto
e cioĶ il linguaggio ōscientificoö.
Tale forza in avanti automaticamente crea la
sua controreazione (la ōnecessitÓ del proŁgressoö):
infatti lÆestrema precisione del linguaggio scientifico crea una specie di
prigione che impedisce qualsiasi evoluzione. A ci“ contribuiscono le Vestali
che presto o tardi, magari proprio quando esso ha perduto ogni sua funzione, si
costituiscono a custodi delle regole del linguaggio che perci“ da funzionali
diventano ferree. Per uscire fuori dalla prigione occorre volare via spaziando
con estrema audacia nel regno dellÆignoto o comunque del non ancora ben noto.
E cosņ si viene a creare il linguaggio ōpoeticoö, terzo degli aspetti
sopramenzionati.
Dallo scontro di queste due forze uguali e
contrarie si genera il quarto aspetto del linguaggio e cioĶ quello delle ōchiacchiere inutiliö.
Queste non contribuiscono menomamente al
progresso ma lo ostacolano; e non conŁtribuiscono alla sua precisione ma ne
aumentano la confusione e servono solo ad erigere la torre di Babele.
La causa di ci“ Ķ il principio generale dellÆōentropiaö: la necessitÓ della precisione, inŁsieme ai veri scienziati, tende a produrre il
fenomeno negativo delle Vestali o falsi
scienziati; dÆaltronde, la necessitÓ
del progresso porta seco, insieme ai veri
poeti, gli istrioni o falsi poeti.
Vestali ed istrioni vengono, spesso a loro
insaputa, rimescolati ed usati dalla necessitÓ della pratica che, nel frattempo trasformatasi in interessi costituiti, sfruttando le spinte contrastanti dei
microinteressi individuali o corporativi diventa la sola legge imperante.
E, allo stesso modo di come si verifica in
termodinamica statistica, la legge del caso trasforma un sistema deterministico
ma reversibile in un sistema ancora deterministico ma apparentemente casuale ed
irreversibile. Venendosi cosņ a confermare il principio generale dellÆentropia
secondo il quale i sistemi isolati devono marciare inesorabilmente dallÆordine
verso il disordine.
E tuttavia le chiacchiere inutili hanno una grande funzione sociale in quanto,
anche se ōin sķö non significano niente, servono ad unire i simili con i simili;
creando cosņ le varie chiese, o corporazioni, o consorterie.
Attraverso queste, molte ōCHIACCHIERE
INUTILIö vengono pomposamente ribatŁtezzate ōLA SCIENZAö e ōLA POESIAö.
Di tanto in tanto, tuttavia, emergono i geni che, rifacendosi alle conquiste del
pensiero passato, ma ormai sepolto dalle infinite diatribe tra falsi scienziati
e falsi poeti (cumulativaŁmente li chiameremo falsi profeti!), tendono a
procurare qualche avanzamento; ed in minima parte vi riescono lasciando la loro
traccia; anche se, subito dopo, i falsi profeti tendono ad annebbiare tutto di
nuovo (magari abusando del nome degli stessi geni che vengono trasforŁmati, ormai che sono morti e non possono
pi∙ reagire, in santoni)
proclamando il ōnuovoö verbo, che ormai falsato, non si riesce pi∙ a
distinguere da quello ōvecchioö che preesisteva al genio; e, arrogandosi il
diritto di diffondere questo ōnuovoö vangelo e distribuendosi le cariche di
vescovi e di papi, giudicano inappellabilmente di chi tra i fedeli sia un
ortodosso o un eretico.
Per tale scopo i falsi profeti hanno la
necessitÓ di forgiarsi la teoria delle PULCI (cioĶ del ōProgresso Universale
Lineare Continuo Infinitoö); quando, al contrario, la storia rivela un caotico
succedersi di avanzate e retrocessioni che spesso rasentano di nuovo lo zero
assoluto! Ma la teoria del progresso ininterrotto Ķ molto comoda e difficile da
abbandonare; con tale teoria viene permesso infatti ad un moderno, anche se imbecille, di avere sempre ragione su di un antico, anche se un genio; allo stesso
modo dei grandi che pretendono di avere sempre ragione sui bambini, nonostante
la sequenza temporale Ķ, nel nostro caso, invertita.
Notiamo che lÆapparizione dei geni non contraddice lÆanalogia
termodinamica in quanto questÆultima scienza prevede anche situazioni lontane
dallÆequilibrio in cui la riduzione del contenuto entropico del sistema si
ottiene a spese di sorgenti esterne o sfruttando riserve precedentemente
accumulate in una parte di un sistema pi∙ ampio (pensiamo alle riserve di
combustibili della terra come sistema pi∙ ampio della biosfera).
Nel caso del linguaggio scientifico lÆesterno Ķ rappresentato dai contatti
con altre culture e le riserve si
trovano nascoste nelle biblioteche sotto forma di libri che nessuno ha mai
letto perchķ non servono al paradigma dominante
e di tanto in tanto anzi si provvede con qualche incendio ad arrestare
lÆincombente pericolo della scienza (questa volta scritta in minuscolo!) che
farebbe sgonfiare tutti i palloni che a forza erano stati gonfiati.
Si dice che il califfo Omar, ritenuto
lÆennesimo incendiario della biblioteca di AlessanŁdria, abbia detto per
spiegare (naturalmente non per giustificare!) il suo operato: Se i vostri libri
dicono le stesse cose che dico io allora sono inutili; se dicono cose diverse
allora sono dannosi.
***
Nelle discussioni sulla scienza e quindi sul
suo linguaggio si sono fatte molte chiacchiere, data la sua enorme rilevanza
sociale. Ai nostri fini menzioneremo solo due problemi sui quali lungamente si
Ķ dibattuto.
Il primo riguarda la nascita della scienza,
il secondo la sua evoluzione. Per entrambi si sono sostenute tesi contrapposte.
Nasce la scienza dalle esigenze pratiche e dal perfezionaŁmento del lavoro
tecnico o non piuttosto dalle religioni e dai miti?
La prima tesi viene prevalentemente sostenuta
da coloro che si mettono in posizione critica nei confronti del sistema; per
costoro gli attori del processo di creazione della scienza sono ovviamente i
lavoratori; da questi si formano i tecnici e da questi, a loro volta, emergono
gli scienziati. La formazione dei sacerdoti o bramini della scienza sono un
fatto involutivo dovuto a cause sociali esterne. I sostenitori di tale tesi
tendono a rispondere al problema dellÆevoluzione della scienza ricorrendo a
cause ōesterneö e cioĶ alla struttura sociale.
La seconda tesi viene sostenuta
principalmente dagli apologeti del sistema; naturalmente per costoro la scienza
nasce dal mito e dalla religione; gli attori del processo sono i sacerdoti che
hanno il tempo sufficiente per occuparsi di cose che vanno oltre le necessitÓ
immediate. Il problema dellÆevoluzione della scienza viene quindi risolto
ricorrendo alla dinamica ōinternaö della scienza che trascende i mutamenti
delle strutture sociali. Se una societÓ viene distrutta o si autodistrugge, la
scienza, come anima immortale, si trasferisce altrove e continua a crescere
indisturbata.
Ma non sono solo questi ultimi a sostenere
quella che abbiamo chiamato la teoria delle PULCI, anche i primi la sostengono.
Entrambi per sostenerla sono costretti a muŁtilare la scienza: i primi,
identificando praticamente la scienza con la tecnica, guardano allÆaccumularsi
delle conoscenze tecniche e trascurano quasi totalmente, almeno nei fatti, gli
elementi teorici che sotto il nome di ideologia
vengono semplicemente derisi; spesso buttando via il bambino insieme
allÆacqua sporca. Stranamente, poi, lÆidentificazione della scienza con la
tecnica viene invece diffusa tra le masse proprio dai detentori del potere
economico dopo averne operato solo una piccola, ma non neutrale e non senza
conseguenze, sostituzione: il lavoro viene sostituito con la grande industria
come motore delle conoscenze scientifiche.
Gli apologeti del sistema, invece, per
mutilare la scienza sono costretti a mutilare la storia, classificando come
barbari ed incolti tutti i popoli che non stanno dentro il paradigma,
inventandosi capziose provenienze culturali; come p. es. gli ōeuropeiö hanno
fatto con la cultura greca: tagliando completamente fuori tutte le filosofie
medioevali da cui pi∙ propriamente la nostra cultura immediatamente deriva e
gettando un diretto ma impossibile ponte verso la scienza greca.
La nostra idea Ķ che entrambe queste tesi
siano parziali e adialettiche.
Come si verifica in tutti i sistemi
complessi, e la cosa ha una spiegazione matematica, si hanno consecutivi rami
evolutivi, qualitativamente diversi, e intervallati da punti di diŁramazione
con caratteristiche catastrofiche tali da annullare quasi tutto quello a cui
preceŁdentemente si era dato il nome di scienza. In ogni punto di diramazione
si aprono altri rami possibili, che il futuro potrebbe in teoria percorrere,
diversi tra loro dal punto di vista qualiŁtativo; lÆimboccare lÆuno o lÆaltro
ramo dipende da fattori ōesterniö quasi esclusivamente di natura economica e
sociale.
A partire da tale punto di instabilitÓ,
superata la fase iniziale, in cui ogni volta si riparte praticamnente da zero,
il sistema socio-economico-culturale si stabilizza; anche sviluppando
meccanismi di autoprotezione, e procede con unÆinflessibile logica ōinternaö
fino a che le forze entropiche non lo distruggeranno di nuovo quando si sarÓ
raggiunto il prossimo pulito di diramazione.
In questo scritto vogliamo, in un primo
momento, descrivere lÆevoluzione del linguagŁgio scientifico tra due successivi
punti catastrofici e per concretezza il materiale empirico lo prenderemo dalla
storia dellÆevoluzione del pensiero scientifico nato, quasi contemporaneaŁmente,
nella Ionia e nellÆItalia di alcuni millenni fÓ. Questo per due ragioni: lÆuna
Ķ che tale periodo storico Ķ abbastanza lontano nel tempo, riducendo cosņ la
probabilitÓ (anche se non la possibilitÓ!) di lasciarci coinvolgere
completamente nelle passioni ideologiche; lÆaltra ragione Ķ che questo periodo
della storia della cultura Ķ sufficientemente documentato per poterne azzardare
una descrizione teorica.
Per fare questo, senza incorrere nel sempre
presente pericolo delle chiacchiere
inutili sarÓ prima necessario costruirsi gli strumenti adatti.
Anche se tali strumenti sono stati usati,
spesso con grande maestria, fin dai tempi di Pitagora e, molto probabilmente
anche prima, il loro perfezionamento e la riflessione su di essi Ķ opera molto
recente e quasi esclusivamente dovuta a Peano ed alla sua scuola.
A tal riguardo potrebbe apparire strano il
fatto che tale scuola sia oggi quasi completaŁmente dimenticata ed al suo posto
si sia affermata una sua derivazione distorta ed assurda (come andremo notando
nel seguito) iniziata dal Russell; ma alla luce delle considerazioni precedenti
il fatto, pi∙ che strano, appare invece assolutamente naturale e difficilmente
si sarebbe potuto immaginare il contrario (vedi in proposito lÆarticolo di
Boscarino in questo stesso numero dei Quaderni che sarÓ indicato nel seguito
colla sigla PF).
LÆideografia di Peano
Dal momento che, oggi, lÆideografia di Peano
Ķ praticamente sconosciuta ed i simboli da lui inventati vengono usati con
significati del tutto diversi o, comunque, distorti e poichķ essa avrÓ un ruolo
fondamentale per sviluppare il nostro discorso, questa sezione ad essa dedicata
assumerÓ, necessariamente, una forma piuttosto didascalica.
Dal punto di vista filosofico, i contributi
fondamentali di Peano alla scienza della logica (non considerando i molti ed
importantissimi contributi da lui apportati dal punto di vista pi∙
specificatamente tecnico) sono due: la distinzione tra i diversi significati
che si nasconŁdono sotto lÆunico termine rappresentato nella lingua comune dal
verbo ōessereö ed il chiariŁmento
concettuale dei termini fondamentali e del significato di quello che oggi si
chiama un ōsistema deduttivoö.
Cercheremo di capire, in questa sezione,
lÆessenza di tali contributi straordinari ed estremamente fecondi.
Consideriamo le seguenti ōproposizioniö della lingua italiana:
1)Ā Mongibello ĶĀ lÆEtna.
2)Ā Il mais ĶĀ granoturco.
3)Ā LÆEtna ĶĀ il vulcano pitņ alto.
4)Ā Socrate ĶĀ mortale.
5)Ā Socrate ĶĀ un uomo.
6)Ā Aristotele ĶĀ un uomo.
7)Ā LÆuomo ĶĀ mortale.
8)Ā Il cane Ķ un animale.
9)Ā Qualcosa ķ mortale.
10) Qualcuno ķ mortale.
Secondo la logica grammaticale, le dieci
proposizioni sono tutte della forma: soggetto,
copula, predicato.
Al contrario, i loro ōsignificati realiö (cioĶ quello che effettivamente significano,
indipenŁdentemente dalla forma nella quale sono state espresse) sono tutti
diversi.
Tuttavia, dal punto di vista della ōlogicaö, alcune hanno ōsignificato formaleö (cioĶ la forma
logica in cui sono espresse, indipendentemente dal loro, eventuale, significato reale) identico ed altre, invece,
diverso:
Nella 1), i ōterminiö a sinistra e a destra della copula sono entramnbi degli ōindividuiö 2
Nella lingua italiana gli individui sono, generalmente,
rappresentati da nomi propri (propri ad un solo e ben determinato individuo).
Nella 2), i ōterminiö a sinistra e a destra della copula sono entrambi delle ōproprietÓö.
Nella lingua italiana le proprietÓ sono, generalmente, rappresentate da nomi comuni (comuni
a pi∙ individui).
E, tuttavia, le 1) e 2) hanno qualcosa in
comune che li distingue formalmente dalle altre. Infatti, in entrambe, si
intende dire che i due termini a
sinistra e a destra della copula, anche se diversi tra loro, hanno ōidenticoö significato (reale); in altre parole,
sono due nomi diversi per la stessa cosa; il che implica che lÆun termine si pu“ sostituire allÆaltro, e
viceversa, in ogni contesto in cui compaiano; purchķ detti termini intendano
riferirsi ai loro significati e non ai ōsegniö stessi.
Per esempio, se dico ōmais ha quattro lettereö non posso sostituire al termine ōmaisöĀ
il termine ōgranoturcoö. E
non posso sostituire ōmaisö a ōgranoturcoö nella proposizione:
ōgranoturco ĶĀ una parola composta dalle due parole grano e
turcoö.
Possiamo convenire di scrivere, al posto
della copula, il ōsegnoö ō =ö
e cosņ le 1) e 2) diventano:
Mongibello = Etna
Āmais = granoturco
secondo lo ōschema di proposizioneö:
(F1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
= b,
da leggere: ōaö Ķ identico a ōbö;
ovvero ōaö significa ōbö; dove ōaö e ōbö sono due ōsimboliö che
rappresentano due termini generici. CioĶ termini dotati di un significato (e di
uno solo) ma che non ci interessa di sapere perchķ noi siamo interessati solo
alla relazione che li lega, denotata dal segno ō=ö.
Nelle 3), 4), 5), 6), invece, a sinistra ci
sta un individuo e a destra una proprietÓ. Questo basterebbe a dirci che
la copula, in questo caso, non pu“ significare lÆidentitÓ dei due termini. Di
fatto, in queste proposizioni, si vuole intendere che a sinistra della copula
ci sta un individuo che ha la proprietÓ nominata a destra.
Converremo, in questo caso, di indicare la
copula semplicemente con il segno ō╬ö e scrivere:
Etna ╬ vulcano pi∙
alto
Socrate ╬ mortale
Socrate ╬ uomo
Aristotele ╬ uomo.
Secondo lo schema:
(F2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╬ b,
da leggere: ōaö ĶĀ un ōböÆ ovvero: lÆindividuo ōaö ha la proprietÓ ōbö.
Nelle 7) e 8), a sinistra e a destra della
copula ci sono due proprietÓ, come nella 2), ma i due termini non sono
reciprocamente sostituibili in quanto il primo esprime un concetto che Ķ parte
del secondo; o, in altre parole, la prima proprietÓ implica la seconda ma non
viceversa.
Per questÆaltro significato del verbo essere,
useremno il segno ō╔ö secondo
lo schema:
(F3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╔ b,
che leggeremo: la proprietÓ ōaö
implica la proprietÓ ōbö, ovvero la
proprietÓ ōaö include la proprietÓ ōbö o, ancora: gli individui che hanno la proprietÓ ōaö sono inclusi tra gli individui
che hanno la proprietÓ ōbö.3
Infine, nelle 9) e 10), a sinistra della
copula ci sono degli individui e a destra delle proprietÓ, come nelle 3), 4),
5) e 6), ma lÆindividuo non Ķ rappresentato da un nome proprio ma da un pronome
indefinito che, quindi, indica un individuo generico e le proposizioni, pi∙ che
asserire qualcosa sugli individui, asseriscono qualcosa sulle proprietÓ stesse.
In particolare, con la 9) si asserisce che la
proprietÓ ōmortaleö non Ķ una
proprietÓ assurda, cioĶ senza individui che la possano avere; ma, al contrario,
non Ķ affatto impossibile lÆesistenza di individui che hanno la proprietÓ di
essere mortali.
Con la 10) si vuole dire la stessa cosa, solo
che, nellÆaccezione comune, il termine ōqualcunoö,
a differenza di ōqualcosaö, vuole
indicare un ōuomoö; per cui la 10) si
potrebbe esprimere con, ōqualcosa Ķ uomo
e mortaleö. Se indichiamno con il segno ō∩ö la congiunzione ōeö, si pu“ formare la ōproprietÓ compostaö: uomo ∩ mortale e la 10) si riconduce allo schema 9) che possiamo simbolizzare con:
(F4)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ $ a ,
dove ōaö rappresenta una
proprietÓ (eventualmente, anche composta),
ed il segno ō$ö indica che possono esistere individui che hanno
tale proprietÓ.
La (F4)
si pu“ leggere: vi sono degli ōaö o,
anche, vi Ķ almeno un ½a╗, ecc.
Le (F1), (F2), (F3), (F4) individuano quattro significati diversi del verbo
essere che Ķ necessario distinguere formalmente in un sistema deduttivo per evitare conclusioni assurde a partire da
determinate premesse.
Pu“ essere talvolta utile esprimere anche le (F1),
(F3), (F4) sotto la forma della (F2), cioe: soggetto, copula, predicato.
Ci“ si pu“ ottenere stipulando opportune
convenzioni:
Se conveniamo di indicare con il segno ōιö la proprietÓ di essere ōidentico aö qualcosa, allora formalmente le (F1) ed (F2) si possono esprimere con la ōformulaö:
(F1Æ)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╬ ι b,
che si pu“ leggere: ōaö Ķ
identico a ōbö (cioĶ, ōaö ha la
proprietÓ di essere identico a ōbö).
Intendendo, quindi, che i termini logici ō=ö e ō╬ ι ö hanno lo stesso
significato. CioĶ il segno ō=ö Ķ unÆabbreviazione dei due segni accostati ō╬ö e ōι ö.
CioĶ:
(A1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ =Ā Ā.=.Ā ╬ ι
Notiamo che nella (A1) i due segniĀ ō = öĀ eĀ ō.
= .öĀ hanno lo stesso significato reale ma un diverso significato formale, in quanto il primo
appartiene al linguaggio simbolico che si ha intenzione di costruire (ōlinguaggio
oggettoö); mentre il secondo appartiene al
linguaggio che, necessariamente, dobbiamo usare per costruire il primo (ōmetalinguaggioö).
Se conveniamo di indicare con il segno ō ß ö la proprietÓ di implicare la proprietÓ ōbö (quindi ō ßb ö Ķ
una ōproprietÓ di proprietÓö)
, possiamo scrivere:4
(F3Æ)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╬ ßbĀĀ .
Si pu“, quindi, asserire:
(A2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ╔Ā Ā.=.Ā ╬ ßĀ .
Nella (F3Æ),
la proprietÓ ōaö assume la funzione
logica di ōindividuoö rispetto alla
proprietÓ di secondo livello ō ßb öĀ .
Quindi se ne deduce che i concetti di individuo e di proprietÓ, tranne casi particolari, hanno valore relativo e non
assoluto; cioĶ se un termine ha il ruolo di proprietÓ
in una determinata proposizione essa pu“ assumere il ruolo di individuo in unÆaltra, come in: Socrate ╬ mortale e mortale ╬ proprietÓ.
Anche la (F4)
pu“ essere messa nella forma (F2); per
far ci“ conviene introdurre la ōproprietÓ
assurdaö che non pu“ essere posseduta da alcun individuo e rappresentata
dal segno ō┘ö.
Con lÆuso di tale segno si pu“ esprimere
lÆidea che una data proprietÓ ōaö Ķ
assurda o contraddittoria scrivendo:
(F5)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a = ┘
che per la decoposizione dellÆidentitÓ si pu“ scrivere:
(F6)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╬ ι ┘
che si pu“ anche leggere: non
possono esistere individui che possiedono la proprietÓ ōaö.
Se conveniamo di usare il segno ō ~ ö
per negare una proprietÓ, cioĶ per indicare la proprietÓ complementare della
proprietÓ data, (nel nostro caso, la ōι ┘ö, cioĶ la proprietÓ di essere identica alla proprietÓ assurda) potremo scrivere:
(A3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ $ aĀ Ā.=.Ā a ╬ ~ ι
┘Ā .
cioĶ: dire che vi sono degli ōaö
Ķ la stessa cosa che dire che la proprietÓ ōaö non Ķ identica alla proprietÓ
assurda.
╚ importante
notare che lÆidea di ōesistenzaö in
logica coincide con lÆidea di ōesistenza
possibileö. Altri significati del termine sono propri delle scienze
empiriche e devono essere descritti e menzionati esplicitamente come
particolari proprietÓ di determinati individui.
Notiamo, ancora, che la distinzione tra i
significati del verbo essere espressi
dai due termini logici ō╬ö e ō╔ö Ķ di estrema importanza;
in quanto, oltre ai diversi significati reali, i due segni hanno proprietÓ
formali molto diverse tra loro.
Infatti consideriamo le due proposizioni seguenti:
0a) Socrate Ķ mortale,
0b) gli italiani sono dotti.
Il verbo essere nelle due frasi precedenti ha
un significato logico diverso come si
pu“ subito mostrare.
Notiamo prima che, tra gli innumerevoli
altri, ci sono due modi diversi per negare le due frasi:
1a) non vero che Socrate Ķ
mortale,
2a) Socrate Ķ immortale (= non mortale);
1b) non vero che gli italiani
sono dotti,
2b) gli italiani sono ignoranti (= non dotti).
Le proposizioni
1a) e 2a) hanno ovviamente lo stesso significato
(a meno che non si cambi il significato di immortale riferendosi, come spesso si usa, non allÆuomo ma alla sua
opera od al suo nome); mentre, altrettanto ovviamente, le 1b) e 2b) hanno significato diverso.
La 1b) ci dice che possono esserci degli
italiani che sono ignoranti ma non nega che ci possano essere degli italiani
dotti; la 2b) invece nega esplicitamuente anche questa seconda possibilitÓ.
Spesso per evitare ambiguitÓ si preferisce dire al posto della 1b): non vero che tutti gli italiani sono
ignoranti.
Tutto questo ci fa vedere che il verbo essere, nei due casi 0a) e 0b), assume signifiŁcato diverso; infatti non Ķ
possibile pensare che ammesso, per ipotesi assurda, che abbia lo stesso significato si debba comportare in modo
diverso quando le due proposizioni vengano
sottoposte alle stesse possibili operazioni
di negazione.
Esprimeremo le frasi precedenti in modo pi∙
preciso con:
0aÆ) Socrate ╬ mortale,
0bÆ) italiano ╔ dotto,
1aÆ) Socrate ~
╬ mortale,
2aÆ) Socrate ╬ ~ mortale,
1bÆ) italiano ~ ╔ dotto,
2bÆ) italiano ╔ ~ dotto.
Abbiamo abbreviato con i segni ō~ ╬öĀ
eĀ ō~ ╔ö la negazione delle relazioni5 ō╬ö e
ō ╔ö rispettivamente (il che
equivale a negare le proposizioni stesse
nella loro globalitÓ); e con i segni ō╬ ~ö e ō╔ ~ö la negazione dei soli
termini di destra della proposizione, cioĶ
mortale e dotto rispettivamente.
Si pu“ quindi scrivere in modo generale ed
astratto, cioĶ formale:
~ ╬Ā .=.Ā ╬ ~
CioĶ:
i segni ō ~ ╬ öĀĀĀ eĀĀĀ
ō ╬ ~ ö hanno lo stesso significato.
E, dÆaltra parte:
~ ( ~ ╔Ā .=.Ā ╔ ~ )Ā .
Le parentesi servono solo ad indicare che il
primo ō~ö si riferisce a tutta la proposizione,
compresa tra le due parentesi, retta daĀĀ
ō.=. öĀĀ .
Si pu“ evitare lÆuso delle parentesi
scrivendo:
~ ╔Ā . ~ =.Ā ╔ ~Ā ;
o, pi∙ semplicemente, abbreviando:Ā
ō ~ = öĀ con il segno ō╣ö :
~ ╔ĀĀ . ╣ .ĀĀ ╔ ~ĀĀĀ .
CioĶ le ultime tre, con segni diversi, dicono
tutte che:
non Ķ vero che ō ~ ╔öĀĀ eĀĀ ō ╔ ~ öĀ hanno
lo stesso significato
o equivalentemente:
ō ~ ╔öĀĀ .non significa.Ā ō ╔ ~ öĀ .
Pu“ risultare utile fare anche le
abbreviazioni ōŽö al posto di ō ~ ╬ öĀĀ eĀ ō![]() öĀĀ al posto di ō~ ╔ö scrivendo:
öĀĀ al posto di ō~ ╔ö scrivendo:
Ž Ā.=.Ā ~ ╬ Ā.=. ╬ ~
ed invece si avra:
![]() Ā.=.Ā ~ ╔ . ╣
. ╔ ~ĀĀĀ
Ā.=.Ā ~ ╔ . ╣
. ╔ ~ĀĀĀ
In matematica si dice brevemente che la coppia di segni ō~öĀ e ō╬ö gode della proprietÓ commutativa mentre per la
coppia ō~öĀ e ō ╔ö tale proprietÓ non vale.
UnÆaltra importante diversitÓ formale tra i
segni ō╬ö e ō╔ö si pu“ notare dai seguenti
esempi:
dalle asserzioni
ōlÆuomo Ķ mortaleö
e
ōogni mortale Ķ un essere viventeö
segue necessariamente lÆasserzione:
ōlÆuomo ķ un essere viventeö
(sillogismo).
O, detto in modo pi∙ preciso:
ōuomo ╔
mortaleö e ōmortale ╔
essere viventeö implicano: ōuomo ╔ essere
viventeö.
O, in simboli:Ā ō(a ╔ b) ∩ (b ╔ c )Ā .╔. (a ╔ c)ö ;
LÆuso di ō╔ö tra proposizioni,
col significato di implica (come
quello che nellÆultima formula sta tra i due punti), invece che tra proprietÓ, sarÓ chiarito in seguito.
I matematici dicono che la relazione ō╔ö gode della proprietÓ transitiva. ProprietÓ che
invece non vale per la relazione ō╬ö; infatti da ōSocrate Ķ mortaleö e ōmortale Ķ una proprietÓö non segue che ōSocrate ķ una proprietÓö o in scrittura
pi∙ precisa: da ōSocrate ╬ mortaleö
e ōmortale ╬ proprietÓö
non segue ōSocrate ╬ proprietÓö.
Ancora, banalmente: mentre ō╔ö gode della proprietÓ riflessiva, p.es.: ōuomo ╔ uomoö; non avrebbe alcun senso dire
ōuomo ╬ uomoö o ōSocrate ╬ Socrateö;
tuttavia potrebbe avere senso dire: ōun
uomo╬ uomoö: perchķ con il termine ōun uomoö si
vuole intendere un individuo generico
del concetto di ōuomoö, cioĶ, che ha
la proprietÓ di essere ōuomoö.
***
In un ōsistema
deduttivoö si deve distinguere tra ōtermini
primitiviö di cui giÓ se ne supŁpone noto il ōsignificato realeö, e ōtermini
derivatiö di cui, invece, se ne dÓ una ōdefinizione
nominaleö, a partire dai termini
primitivi, mediante lÆuso dei vari ōtermini
logiciö.
Una definizione
nominale non dice niente sui significati
reali dei termini definiti, almeno direttamente. Essa si riferisce solo ai
nomi.
La forma pi∙ usuale Ķ:
(F7)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
. = . b,
dove ōaö Ķ il nuovo termine
(o complesso di termini) da definire e ōbö Ķ il complesso di termini, di
significato giÓ noto, che danno il ōsignificato
formaleö di ōaö e,
indirettamente, anche il suo significato
reale a partire da quello proprio di ōbö.
Un esempio Ķ:
pentagono . =. poligono con cinque angoli.
Dove si suppone noto il significato reale di
tutti i termini a destra dellÆidentitÓ e si intende introdurre il nuovo termine
ōpentagonoö come semplice abbreviazione
dei termini a destra di ō . = . öĀ .
Il ōsignificato
realeö dei termini primitivi (o allÆoccorrenza, come ulteriore
schiarimento, anche di quelli derivati) si pu“ dare solo mediante una ōdescrizioneö, eventualmente corredata
da opportuni esempi.
Anche se Ķ praticamente impossibile
circoscrivere il significato di un termine, mediante una descrizione, in modo da ridurre a zero ogni ambiguitÓ, tuttavia,
nella pratica scientifica, si riesce a ridurre le ambiguitÓ a limiti pi∙ che
soddisfacenti.
Del resto, in modo del tutto spontaneo,
quando un linguaggio scientifico si viene forŁmando, i suoi utenti, anche se
nel parlare comune attribuiscono significati diversi ai singoli termini,
devono, allÆinterno del contesto della loro formalizzazione mettersi necessariamente
dÆaccordo per restringerne il significato al loro nucleo comune; fermo restando
che fuori dal contesto ognuno pu“ dare ad essi il significato che pi∙ gli
aggrada purchķ non affermi in questo caso di fare affermazioni scientifiche.
Senza che per questo si debba svalutare il
linguaggio non scientifico; e questo non solo perchķ, come giÓ detto nel Preambolo, si annullerebbe il valore
della poesia la quale si basa essenzialmente sullÆambiguitÓ dei termini (il cui
scopo Ķ quello di suggerire, attraverso i canali dellÆemotivitÓ, significati
pregnanti sul piano esistenziale) ma anche perchķ il linguagŁgio scientifico Ķ
troppo restrittivo e, usato indiscriminatamente, verrebbe a costituire una
prigione e si trasformerebbe nel contrario della scienza stessa impedendo
qualsiasi reale proŁgresso scientifico. Una parola di moda che comprende anche
questo fenomeno di sociologia della scienza Ķ ōparadigmaö.
Si pu“ quindi dire che il linguaggio
scientifico serve per capire ed il linguaggio poetico serve per progredire; ma,
dialetticamente, non si pu“ progredire senza prima avere capito e non si pu“
capire senza tentare di progredire. Ecco perchķ i veri scienziati sono anche in
parte poeti ed i veri poeti sono anche in parte scienziati. Non a caso i grandi
scienziati del nostro lontano passato scrivevano la loro scienza in versi
poetici come Parmenide ed Empedocle, per citare solo quelli di cui ci sono
pervenuti ampi frammenti.
***
Dopo che si siano definiti i vari termini e
se ne sia ristretto il significato in modo da ridurre le ambiguitÓ al minimo
possibile, Ķ bene, anche se non strettamente necessario, inventare per essi dei
simboli adatti creando cosņ unöÆideografiaö
cioĶ una corrispondenza biunivoca tra lÆidea
che si vuole rappresentare ed il segno
introdotto.
Il procedimento che abbiamo descritto per
restringere il significato dei termini del diŁscorso costituisce, appunto, la descrizione del termine. Esso Ķ lÆunico
modo possibile per assegnare al termine un significato
reale (nel seguito, spesso, lo indicheremo semplicemnente con significato) in quanto distinto
dallÆeventuale suo significato formale (nel
seguito, spesso, indicheremo questÆultimo semplicemente con definizione). Appunto per questo,
spesso, la deŁscrizione viene anche
chiamata definizione reale del termine,
da distinguersi dalla definizione
nominale che fa astrazione dal significato
reale e ne dÓ invece il significato
formale (vedi PF).
Poichķ il segno, che viene formalmente
introdotto per designare il termine, di cui se ne sia giÓ data la descrizione, Ķ in generale diverso dai
pi∙ o meno corrispondenti termini del linguaggio comune sarÓ pi∙ facile evitare
gli usuali slittamenti semantici che conducono a paralogismi ed a paradossi. Ed
Ķ per la stessa ragione che la corrispondenza tra idee e segni deve essere
biunivoca (cioĶ ad ogni segno deve corrispondere un solo termine e viceversa);
per cui nel linguaggio veramente scientifico non dovrebbero ammettersi nĶ omonimi nķ sinonimi; a meno di utili e non ambigue eccezioni, come quando Ś
per quanto riguarda i sinonimi Śpossa risultare utile lÆintroduzione di un
nuovo segno che stia come semplice abbreviazione di una pi∙ lunga sequenza di
segni precedentementi introdotti, in tal caso si parla appunto di definizione nominale; come nellÆesempio
citato: ōpentagono = poligono con cinque angoliö o per quanto riguarda gli
omonimi Ś lÆassegnare lo stesso segno a relazioni ed operazioni che siano
correlate da una corrispondenza tra insiemi diversi di oggetti (cioĶ nei casi
in cui i matematici parlano di isomorfismo
o, pi∙ generalmente, di omomorfismo),
finchķ non sorgano pericoli di ambiguitÓ.
Anche una macchina, che sia in grado di
riconoscere i segni che corrispondono alle lettere dellÆalfabeto, pu“ essere in
grado di sostituire alla parola ōpentagonoö
tutte le parole che lo definiscono (che stanno a destra del segno ō=ö) e
viceversa; e ci“ anche se non conosce menomamente il significato reale delle parole che tratta. Del resto Ķ proprio per
questo che un computer riesce a fare tutte quelle belle cose che tutti sanno, nonostante
non capisca niente dei significati reali delle ōparoleö che elabora! Tuttavia tale ōmacchinaö funziona molto meglio di qualsiasi uomo per quanto
riguarda i significati formali appunto perchķ non Ķ condizionato dai
significati reali e bada solo alle regole di trasformazione che sono state
memorizzate una volta per tutte nel suo programma e per di pi∙ Ķ di gran lunga
pi∙ veloce!
Il linguaggio del calcolatore, quello della
logica formale e della matematica hanno questo in comune, cioĶ quello di realizzare
il sogno di Leibniz attuato compiutamente dal Peano, di poter decidere ogni
diatriba semplicemente dicendo ōcalculemusö
e procedendo formalmente alle necessarie logiche deduzioni a partire dalle
definizioni formali (cioĶ nominali) date
e dagli assiomi anchÆessi formalizzati ed esplicitamente presupposti.6
Tuttavia non Ķ da pensare che il calcolatore
possa fare della matematica o stabilire gli assiomi della logica; non fossÆaltro
perchķ non ne capisce i significati reali; esso pu“ solo effettuare dei
calcoli, una volta che il matematico e/o il logico gli abbiano fornito
definizioni, assiomi e regole di trasformazione; ed Ķ per questo che non
sbaglia! (naturalmente limitatamente al suo compito abbastanza ristretto che,
per lÆappunto, consiste in quello di ōcalcolareö
o, pi∙ generalmente, di ōelaborareö).
Il matematico ed il logico invece possono
sbagliare perchķ non Ķ facile individuare tali inputs per il calcolatore non essendo
facile liberarsi da pregiudizi metafisici o di ogni alŁtra natura; a parte
lÆosservazione banale che quello dei logici e dei matematici Ķ (o almeno
dovrebbe essere) un lavoro creativo e non di semplice elaborazione. Ne consegue
che il calcoŁlatore pu“ fare quasi tutto, anche dimostrare teoremi, ma non pu“
sostituire il matematico; e pu“ fare
financo le poesie ma non certamente potrÓ fare mai il poeta! Naturalmente finchķ non si voglia ridefinire il ruolo di
matematici e poeti come spesso avviene e ci“ capita, e non di rado, anche a
tali medesimi attori come si desume leggendo certe loro enunciazioni o
guardando a certe loro pratiche.
***
Esempi di definizioni
reali sono appunto quelli che abbiamo dato ōdescrivendoö il terŁmine definizione
nominale e quelli che andremo facendo per descrivere il termine stesso di definizione reale. In modo pi∙ formale,
possiamo ōdescriverleö cosņ:
Supponiamo di voler descrivere un termimie che chiameremo ōxö,
supponiamo che ōaö, ōbö, ōcö, ōdö, ōeö,
ōfö, ecc., siano delle proprietÓ di
cui, anche se in modo non privo di ambiguitÓ, ne conosciamo giÓ il significato;
allora cominciamo a precisare che: ōxö e un ōaö o un ōbö ed Ķ anche un ōcö ma pu“ essere anche un ōdö o un ōeö ma non Ķ un ōfö. E
cosņ seguitando, in modo pi∙ o meno analogo, usando le particelle ōķ unö, ōeö, ōoö, ōnonö, ... , o altre
particelle che abbiano la stessa funzione, cioĶ quella di connettivi operanti
tra le varie proprietÓ di partenza; e
adducendo, eventualmente, opportuni esempi.
Ma giÓ possiamo notare che le particelle: ōĶ
unö, ōedö, ōoö, ōmaö, ōnonö ecc.
sono anchÆesse dotate di una notevole dose di ambiguitÓ. Infatti, quando usiamo
la disgiunzione ōoö inserita tra le proprietÓ ōdö ed ōeö, la dobbiamo intendere in senso inclusivo o in senso esclusivo?
o, in altre parole, intendiamo riferirci ad una qualunque delle tre
possibilitÓ, per ōxö, di essere: un ōdö
senza essere un ōeö, un ōeö senza essere un ōdö o, anche, un ōdö e
nello stesso tempo pure un ōeö? oppure
vogliamo escludere lÆultima possibilitÓ cioĶ che ōxö possa avere
entramnbe le proprietÓ ōdö ed ōeö insieme?
E la stessa congiunzione ōeö (o ōedö)
che significa?
Spesso nella lingua comune la si usa col
sigmiificato della ōoö inclusiva, come
quando al botteghino del teatro incontriamo un cartello con su scritto: Riduzione per militari e studenti.
Certamente si vuole dire che per avere la riduzione bisogna essere o militari o studenti o entrambe le cose; e non certo che bisogna essere contemporaneamente sia militari che studenti, cioĶ studenti che fanno il militare o militari che sono studenti.
DellÆambiguitÓ di ō Ķ un öĀ
abbiamo giÓ detto.
Allora per evitare ambiguitÓ scriveremo un
segno speciale per ogni possibile significato, evitando i pericoli
dellÆomonimia; p.es:
ōUö per la disgiunzione
inclusiva,
ō∩ö per la congiunzione,
ō~ö
per la negazione, ecc.
Poi, potremmo scoprire che i segni introdotti non sono tutti
indipendenti e che alcuni di essi si possono definire, questa volta nominalmente, come combinazioni degli
altri; p.es. la disgiunzione esclusiva si
pu“ rendere con la formula: ō(d ∩ ~ e) U (~
d ∩ e)ö; cioĶ: ōdö e non ōeö o non ōdö ed ōeö. Risparmiandoci,
in questo modo, lÆintroduzione di un nuovo segno.
(Per ragioni puramente estetiche nella presentazione grafica delle formule
scriveremo qualche volta, ō![]() ö al
posto di ō~aö; per cui la
formula precedente diventa ō
ö al
posto di ō~aö; per cui la
formula precedente diventa ō![]() ö).
ö).
Daremo ora alcuni significati reali di termini che useremo in seguito; altri (spesso
in nota) li daremo al momento opportuno, a meno che non emergano chiaramente
dal conŁtesto. Ovviamente, assumeremo noti (almeno approssimativamente) i
significati delle parole che useremo per ōdescriverliö.
Il risultato finale potrebbe risultare diverso da quello a cui siamo
abituati. Ma poco male, se abbiamo guadagnato in precisione potremo
sopportarne il sacrificio. Naturalmente, se Ķ alla precisione che siamo
interessati! Ma purtroppo senza precisione semantica non si pu“ ōdedurreö un bel niente ma si potrÓ fare
solamente una gran confusione.
Chiameremo ōsegnoö un singolo atto della percezione sensibile,
indipendentemente dal fatto che tale atto abbia per noi umi significato o meno;
quindi anche uno scarabocchio o un rumore qualsiasi sarÓ per noi un ōsegnoö. (Nel dizionario tale
significato Ķ incluso tra i possibili ma non Ķ il solo e nemmeno quello
originario o etimologico).
Chiameremo ōtermineö un segno che
invece abbia per noi un significato ben definito come: Socrate, uomo, animale,
ōuö, ecc. Quindi, secondo le superiori descrizioni, tutti i ōterminiö sono ōsegniö, ma non tutti i ōsegniö sono ōterminiö.
Chiameremo ōsimboloö un segno dotato sņ di significato ma non
fissato; cioĶ si suppone che il segno abbia
un significato ma non ci interessa di conoscerlo. Come nellÆoperazione formale ōd
ĀU eö in cui si suppone che i simboli ōdö ed ōeö abbiano un significato ma non ci interessa di conoscerlo perchķ
noi siamo interessati, invece, solo alla loro relazione formale individuata dal
termine ōUö.
Spesso si indicano con i segni ōcostanteö e ōvariabileö
i significati che noi invece abbiamo attribuito ai segni ōtermineö e ōsimboloö. Noi
lo eviteremo perchķ si sono dimostrati ambigui. Non siamo sicuri che la nostra scelta
potrÓ risultare migliore ma, al momento, la giudichiamo tale. Sarebbe bene
inventare dei segni del tutto nuovi e convenzionali, ma quasi sempre, come giÓ
adombrato nel Preambolo, una
precisione eccessiva riduce la facilitÓ di comprensione immediata e questo,
alla fine, potrebbe provocare lÆeffetto opposto.
Per tutti i termini che abbiamo descritto,
comunque, la confusione Ķ, attualmente, massima anche nel linguaggio della
logica, per non parlare degli altri linguaggi scientifici; quindi non cÆĶ soverchio
pericolo nellÆusare un nome con un significato particolare, purchķ
convenientemente ōdescrittoö.
Useremo il termine ōproprietaö come sinonimo di ōpredicatoö,
di ōnome comuneö, di ōattributoö, di ōaggettivoö, ecc.
Useremo, invece, il termine ōindividuoö come sinonimo di ōcosaö, di ōoggettoö, di ōnome proprioö,
ecc.
Naturalmente con lÆintesa che i termini
precedenti devono essere usati nei significati appropriati, cioĶ quando i
termini sopraelencati rappresentino effettivamente dei sinonimi, quindi, devono
essere usati con quel significato che Ķ lÆintersezione di tutte quelle proprieta alle quali nella lingua comune
si fa riferimento usando tali termini, come abbiamo chiarito nel descrivere le ōdescrizioniö.7
Come giÓ detto, questo Ķ lÆunico modo con cui si pu“ restringere il significato di un dato termine, data lÆambiguitÓ del linguaggio naturale.
Abbiamo chiamato tale processo la descrizione o definizione reale del termine.
Per esempio, come notava il Padoa, illustre
collaboratore di Peano, non potremo mai ottenere il significato reale del termine ōsignificaö
mediante una sua possibile definizione
nominale perchķ dovremmo scrivere:
significaĀ .significa.Ā (un certo complesso di segni).
E, una volta trovato tale complesso di segni
che definisce la parola ōsignificaö, ne avremmo giÓ dovuto conoscere il
significato per poterlo riferire alla seconda apparizione di ōsignificaö. In altre parole, il
formalismo della logica non si occupa di significati
ma solo di relazioni formali tra termini dotati di significato. Anche se
molti sembrano pensare esattamente il contrario e cioĶ che si occupi del
significato di relazioni formali tra termini senza significato!
Abbiamo scritto delle frasi come:
a)ĀĀĀ Socrate ╬ mortale,ĀĀ uomo ╔ mortale, mais = granoturco,
ma anche delle formule come
b)ĀĀĀ x ╬ a ,ĀĀ x ╔ a ,ĀĀ x Ā= aĀ .
Nelle a) compaiono oltre ai termini logici ō╬, ╔, =ö Āanche i termini extralogiciōSocrate, uomo, mortale,
mais, granoturcoö.
Queste sono proposizioni con un valore semantico ben definito e non fanno parte
della logica.
Le formule b) invece sono proprie della
logica la quale tratta solo schemi
formali che stanno per proposizioni arbitrarie.
Quando sarÓ necessario essere pi∙ precisi li chiameremo schemi di proposizioni invece che proposizioni. Peano li chiama proposizioni
condizionali per distinguerle dalle prime che chiama proposizioni categoriche. La terminologia attuale Ķ varia.
Quindi, negli schemi di proposizioni, ōoltreö ai termini logici compaiono ōsoloö dei simboli, che non hanno significato definito, espressi usualmente
con singole lettere minuscole dellÆalfabeto (possibilmente dotate di indici);
ma tali simboli non sono senza significato; chķ uno necessariamente lo devono
avere anche se al formalismo della logica non interessa conoscerlo; gli basta
sapere che uno (ed uno solo!) ce lÆabbiano. Tali simboli, come giÓ detto,
vengono chiamati (tradizionalmente ma non molto opportunamente) variabili.
Il nome variabile
Ķ poco opportuno perchķ, preso alla lettera, potrebbe significare che noi
potremmo effettuare, lungo il corso dÆun ragionamento, degli slittamenti
semantici per cui dalla formula sillogistica: ōa ╔ bö e ōb ╔ cö implica ōa ╔ cö, potremmo
concludere assurdamente: Elisei ╔ venti e venti ╔ numero implica Elisei ╔ numero; cioĶ dal momento che gli Elisei sono venti e venti Ķ un numero ne segue
che gli Elisei sono un numero!
Anche formule del tipo ōx ╬ numeroö o simili, cioĶ quelle in cui compaia un qualunque termine extralogico, non fanno parte della logica anche se possono
fare parte di altre scienze formalizzate come lÆaritmetica. Nei libri di
logica, di tradizione russelliana che poi sono la stragrande maggioranza,
questa regola non viene osservata arrivando a conclusioni paradosŁsali, perchķ
si mantiene lÆillusione che tutto, ed in particolare lÆaritmetica, sia
riducibile a logica; identificando la logica con la metafisica, come Ķ chiarito
in PF.
Non Ķ necessario nemmeno menzionare
(nellÆassiomatizzazione della logica) i termini proprietÓ ed individuo e
non interessa nemmeno conoscerne il significato, ammesso che ne abbiano alcuno
oltre quello formale.
Il decidere se hanno un significato non
puramente formale non Ķ una questione di facile soluzione essendo un problema
di metafisica.
Non stiamo usando tale ultimo termine nel suo
senso deteriore ma semplicemente per dire che la questione non Ķ risolvibile nķ
con la logica, nķ empiricamente; ma che bisogna necessariamente ricorrerre a
postulati preliminari di ordine teoretico dei quali, nel costituire qualunque
scienza, logica compresa, non si pu“ fare assolutamente a meno.
Ci“ costituisce la pi∙ grande costernazione
dei neopositivisti che, pur di non ammetŁtere questa banale veritÓ, finiscono
con lo scambiare la peggiore metafisica con le scienze, empiriche o formali che
esse siano.8
***
Dal punto di vista puramente ōformaleö, cioĶ puramente ōlogicoö, possiamo (meglio ōdobbiamoö) fare finta di non conoscere il significato che tali termini hanno
nel linguaggio comune e dire che Ķ una ōproprietÓö
qualunque cosa che venga rappresentata da un ōsegnoö, qualunque ne sia il suo significato (purchķ ne abbia uno e
uno solo!), che stia a ōdestraö di ō╬ö, ed
Ķ invece un ōindividuoö ci“ che Ķ
rappresentato da un ōsegnoö, qualunque
ne sia il significato, che stia a ōsinistraö di ō╬ö.
Se non si osserva la regola che le lettere
minuscole dellÆalfabeto, che abbiamo usato come simboli per generici ma determinati termini, debbano avere uno (e uno solo) significato (per cui di
fatto sono ōcostantiö!)
si potrÓ facilmente arrivare alle pi∙ assurde conclusioni come quelle giÓ
menzionate o di altro tipo; p.es. si potrebbe dedurre, dallÆosservazione che il
cane abbaia e che il cane Ķ un sostantivo maschile, la veritÓ (!?) che il
sostantivo maschile debba necessariamente abbaiare!
Se vogliamo esplicitamente asserire che ōaö rappresenta una proprietÓ scriveremno ōa ╬ Cö; dove
ora ōCö, al contrario di ōaö, non Ķ un simbolo arbitrario (nel qual caso avrebbe un significato variabile, nel particolare senso che il
significato del simbolo varierebbe da una proposizione
allÆaltra per cui bisognerÓ fissarlo di volta in volta in ogni singola proposizione). Invece ōCö Ķ un termine che ha sempre un significato costante nel senso che resterÓ invariato in tutto il nostro
discorso.
Quindi intendererno sempre: ōC =
proprietÓö (si pu“ dire che ōCö Ķ il nome comune dei nomi comuni!).
Allo stesso modo scriveremo ōa ╬ Iö se
voglianmo dire che ōaö rappresenta un
individuo, quindi ōI =
individuoö .
Nella formalizzazione della logica pura (intendendo con tale
locuzione lÆinsieme dei simŁboli, degli assiomi e dei teoremi pertinenti ad
essa, con lÆesclusione quindi della metalogica cioĶ del linguaggio con cui si parla
di essa) non Ķ necessario usare i termini ōCö
e ōIö, bastando la convenzione
metalinguistica che deriva dallo stare il simbolo a ōdestraö o a ōsinistraö del
segno ō╬ö, come giÓ detto.
Nel caso che la logica venga usata come metalinguaggio
per la costruzione di altri linguaggi scientifici (p.es., la matematica, nel
qual caso le formule di logica funzioneranno da metamatematica) pu“ risultare utile (anche se non necessario:
infatti Ķ sempre possibile introdurre apposite convenzioni nellÆuso dei segni
per evitarlo) menzionare lÆipotesi che un dato simbolo indichi una proprietÓ,
scrivendo: ōa ╬Cö ; questo
bisognerÓ farlo, in ogni caso, quando ci sia pericolo di ambiguitÓ sul
significato logico del simbolo ōaö.
***
Faremo ancora finta di non sapere il
significato della parola ōproprietÓö ma
affermerŁemo che se ōaö e ōbö sono simboli che denotano proprietÓ,
allora anche lÆoperazione:9 ō![]() ö Ķ una proprietÓ.
ö Ķ una proprietÓ.
Questo Ķ un esempio di quelle che si dicono definizioni ricorsive cioĶ: si elencano
prima gli oggetti elementari che
possiedono la proprietÓ da definire
(in questo caso, le proprietÓ elementari sono
rappresentate dai simboli semplici ōaö,
ōbö) e poi si dÓ una regola per definire gli oggetti composti (nel nostro caso, le proprietÓ composte sono quelle del tipo ō![]() ö). Con ci“ ovviamente non si dÓ il
significato reale del termine definito ricorsivamente (nel nostro caso, il
termine proprietÓ), che invece
dobbiamo giÓ possedere, ma soltanto quello formale; quindi le definizioni
ricorsive sono definizioni nominali anche
se non ne hanno la forma esplicita che abbiamo descritto sopra.
ö). Con ci“ ovviamente non si dÓ il
significato reale del termine definito ricorsivamente (nel nostro caso, il
termine proprietÓ), che invece
dobbiamo giÓ possedere, ma soltanto quello formale; quindi le definizioni
ricorsive sono definizioni nominali anche
se non ne hanno la forma esplicita che abbiamo descritto sopra.
Possiamo simbolizzare quanto detto con la
formula:
(M1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() ĀĀ ,
ĀĀ ,
cioĶ
se ōaöĀ e ōbö sono proprietÓ lo Ķ anche ō![]() öĀ e viceversa.
öĀ e viceversa.
Dal punto di vista puramente formale non Ķ necessario sapere il
significato reale di ō![]() ö (fermo restando il suo significato formale di operazione che date due proprietÓ ne produce una terza); ma se
ne pu“ dare una definizione reale (= descrizione) dicendo che ō
ö (fermo restando il suo significato formale di operazione che date due proprietÓ ne produce una terza); ma se
ne pu“ dare una definizione reale (= descrizione) dicendo che ō![]() ö significa la proprietÓ
complementare della proprietÓ intersezione
di ōaö e ōbö, cioĶ la proprietÓ di
non essere ōaö e ōbö contemporaneamente.
ö significa la proprietÓ
complementare della proprietÓ intersezione
di ōaö e ōbö, cioĶ la proprietÓ di
non essere ōaö e ōbö contemporaneamente.
In modo pi∙ formale: se qualcosa, p. es.: ōxö,
ha la proprietÓ ō![]() ö allora necessariaŁmente ōxö non ha la proprietÓ intersezione di ōaö e ōbö, cioĶ o non ha la proprietÓ
ōaö o non ha la ōbö; o, ancora, ōxö
non pu“ essere ōaö e ōbö nello stesso tempo.
ö allora necessariaŁmente ōxö non ha la proprietÓ intersezione di ōaö e ōbö, cioĶ o non ha la proprietÓ
ōaö o non ha la ōbö; o, ancora, ōxö
non pu“ essere ōaö e ōbö nello stesso tempo.
***
Per il significato che abbiamo dato al segno ōιö,
possiamo convenire che ōιaö significa il ōconcettoö determinato completamente
dalla proprietÓ ōaö. CioĶ: ō
ιa .=. concetto di aö.
Notiamo che, dal momento che si ha sempre ōa = aö
e quindi ōa ╬ ιaö, ōaö ha la funzione di individuo
nei confronti della proprietÓ ōιaö. In questa funzione
diremo che ōaö Ķ lÆōintensioneö del concetto ōιaö o, che Ķ lo stesso, ōaö Ķ lÆintensione del concetto di ōaö. Ma, naturalmente, la
forma simbolica Ķ pi∙ perspicua di qualunque adattamento, pi∙ o meno forzato,
della lingua comune.
Nel caso che ōaö sia un termine che rappresenti un individuo realmente (e non solo formalmente,
cioĶ nel caso che il termine sia un nome
proprio, come, p. es., Socrate) diremo che ōaö Ķ lÆindividuo e ōιaö
Ķ lÆōideaö di ōaö (Peano usava il
nome elemento per essa, ma oggi tale
nome viene usato come sinonimo di individuo).
Per esempio se uomo Ķ una proprietÓ, ι uomo Ķ il concetto di uomo. E
uomo Ķ lÆintenzione del concetto di uomo. Se Socrate Ķ un individuo ι Socrate Ķ lÆidea di Socrate.
Notiamo che ōιö si pu“
considerare come un ōoperatoreö che
applicato ad un individuo ne produce
la sua idea e applicato ad una proprietÓ ne produce il suo concetto.
NellÆipotesi che, nel seguito, possa servire
introdurremo lÆōoperatore inversoö di
ōιaö
che fa passare dal concetto alla
sua intensione (o dallÆidea allÆindividuo corrispondente). Lo
indicheremo con ōjö
Per esempio, se ōbö Ķ il concetto di uomo, ōj bö Ķ
la proprietÓ uomo. Se ōbö Ķ lÆidea di Socrate, ōjbö Ķ
lÆindividuo Socrate.
Ne segue che: ōj ιa = aö e ōι
j a = aö qualunque cosa sia ōaö.
Converremo, ancora, che se ōaö Ķ la proprietÓ che definisce il concetto ōι aö allora ōßaö ne
denota la sua ōcomprensioneö.
Intenderemo, invece, con il termine ōestensioneö il gruppo di individui dei quali possiamo affermare
che sono degli ōaö; lÆestensione di ōιaö
differisce dallÆintensione di ōιaö
e la indicheremo, se dovesse servire, con ōext aö; ma vedremo che in un linguaggio scientifico tale segno non
Ķ necessario.10
Per le convenzioni fatte, le proposizioni elementari si possono tutte
ricondurre alla forma ōx ╬ aö, che allÆoccorrenza, abbrevieremo con il segno ōaxö, cioĶ:
(A4)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ax
Ā.=.Ā x ╬ aĀĀĀĀ
Per gli assiomi elencati in Appendice
anche le proposizioni composte (cioĶ
quelle formate analogamente alle proprietÓ
composte) possono essere poste sotto tale forma. Per cui se conveniamo di
abbreviare il termine proposizione con
ōPö possiamo scrivere:
(M2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ x ╬ aĀ . ╔ .Ā x ╬ I Ā∩ a ╬ C Ā∩ (x ╬ a) ╬ P,
cioĶ: la formula ōx ╬ aö
implica che ōxö Ķ un individuo, ōaö Ķ una proprietÓ e ōx ╬ aö Ķ una proposizione.
Notiamo che nella (A4), il segno ōx ╬ö assume
il ruolo di un ōoperatoreö che, asseŁgnato
un determinato individuo ōxö, ci fa passare da una data proprietÓ alla corrispondente proposizione relativa ad ōxö.
In tale ruolo lo indicheremo con ō╬xö.
Possiamo, invece, assegnare al segno ō'xö il ruolo di ōoperatore inversoö che fa passare dalla
proposizione relativa a ōxö
alla corrispettiva proprietÓ.
Per cui si avrÓ:
(A5)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ax
Ā.=.Ā ╬xĀ aĀ
,ĀĀ
(A6)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
Ā.=.Ā 'xĀ ax
Operando sui due membri delle due identitÓ, rispettivamente, con ō'xöĀ e ō╬xö, si
ottiene:
'x ax = 'x ╬xĀ a Ā=Ā aĀ Ā,
╬xĀ a Ā= ╬x 'x ax = axĀĀĀ Ā;
questo significa che i due operatori ō'x ╬xöĀ e ō╬x 'xö ĀĀoperando,
rispettivamente, su di una proprietÓ e
su di una proposizione le lasciano inalterate;
tale proprietÓ pu“ risultare utile nelle deduzioni.
Infatti, lo scopo principale di un ōsistema deduttivoö Ķ quello di dedurre
da proposizioni ritenute come vere altre proposizioni valide, in modo
assolutamente meccanico mediante pochissime regole deduttive.
Le proposizioni che si assumono come vere si
dicono ōassiomiö,
quelle dedotte dagli assiomi,
mediante le regole deduttive, si dicono ōteoremiö.
Tuttavia, Ķ importante osservare che la
distinzione tra termini primitivi e termini derivati, da un lato, e definizioni nominali, assiomi e teoremi dallÆaltro, ha un valore
relativo e non assoluto. La scelta di cosa assumere come primitivo o come
derivato Ķ assolutamente arbitraria e dipende solo dalla volontÓ di chi
costruisce il sistema deduttivo.
Tale scelta non dipende nķ da una necessitÓ
pratica, nķ teorica, ma solo da condizionaŁmenti esterni dettati da valutazioni
soggettive, quali: considerazioni estetiche, ricerca di semplicitÓ, adeguamento
a particolari concezioni del mondo o, anche e non ultime, ragioni economiche,
ecc.
Per esempio, nellÆindustria dei calcolatori
si sceglie (in questo caso, ōfisicamenteö,
nel processo di produzione dei chip di silicio) lÆoperazione che abbiamo
indicato con il simbolo ō![]() ö (la chiameremo ōoperazione nandö, abbreviazione dellÆinglese not and) come operaŁzione primitiva, a
partire dalla quale costruire le altre operazioni logiche, perchķ si riducono
notevolmente i costi di produzione dei circuiti integrati.
ö (la chiameremo ōoperazione nandö, abbreviazione dellÆinglese not and) come operaŁzione primitiva, a
partire dalla quale costruire le altre operazioni logiche, perchķ si riducono
notevolmente i costi di produzione dei circuiti integrati.
La ricerca della ōsemplicitÓö Ķ solo un mito, sia perchķ Ķ un concetto difficile da
definire, sia perchĶ una volta definitolo in un caso particolare non sarÓ pi∙
adatto in un altro caso.
Al contrario, il costo unitario di un
determinato circuito integrato (e quindi il magŁgiore o minore profitto da
ricavare dalla sua vendita), per il bene o per il male, Ķ invece oggettivamente
determinabile!
Il Peano, giustamente, non si preoccupa gran
chķ di stabilire un sistema assiomatizzato al massimo grado, convinto comÆĶ
che, in un linguaggio scientifico, da qualunque punto si parta, si debba
necessariamente arrivare allo stesso risultato; purchķ non si scambino pseudoŁproblemi
di natura puramente verbalistica per problemi effettivi che concernono i
concetti e le idee (vedi comunque PF).
Tuttavia il suo collaboratore A. Padoa
stabilisce un sistema deduttivo in cui, come termini primitivi di tutta la
logica, si assumono solo tre termini; e precisamente quelli da noi indicati con
ō =, ∩ e 'xö; a partire dai quali vengono
definiti nominalmente tutti gli altri.11
In generale, nei vari campi della scienza,
non Ķ nemmeno unÆimpresa semplice, ma, in qualche caso, richiede il lavoro di
molti anni da parte di provetti matematici, il verificare se una data proposizione data come assioma non possa essere, invece,
dimostrata come teorema a partire
dagli altri assiomi.
In Appendice
viene dato un possibile sistema di termini
primitivi, di definizioni nominali e
di assiomi per la logica.
Qui ci limiteremo a notare che a partire
dallÆoperazione ō~ö si possono definire nomiŁnalmente tutti gli altri connettivi logici che
servono a formare tutte le altre proprietÓ parŁtendo da quelle elementari.
Per esempio la ōproprietÓ complementareö di una data proprietÓ ōaö si pu“ definire mediante la:
(P1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
LÆōunioneö di due proprietÓ con:
(P2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
LÆōintersezioneö con
(P3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
Si Ķ soliti sottindendere il segno di intersezione con la definizione:
Ā(P4)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
Con tale abbreviaziomie si realizza una consistenza simbolica con il
segno originario ō~ö; infatti, operando sui due membri della (P4) con ō~ö si ottiene: ō![]() ö.
ö.
Per realizzare un migliore aspetto
tipografico delle formule useremo, talvolta, la conŁvenzione di negare solo
lÆoperazione invece che lÆintera proposizione, p. es.: ō![]() ö e ō
ö e ō![]() ö.
ö.
Per la stessa ragione useremo, a volte, le
convenzioni: ō ~ aĀ . = .Ā
~ (a)Ā . = .Ā Ń ö .
Il significato reale dei segni introdotti mediante definizione nominale potrebbe desumersi a partire da quello dei
segni primitivi.12
Possiamo asserire gli ovvi ōassiomiö seguenti:
Ā(P5)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
cioĶ: facendo il complemento del
complemento si riottiene la proprietÓ di partenza.
(P6)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]()
che esprime la proprietÓ commutativa dellÆoperazione
retta da ō~ö.
(P7)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() ,
,
con lÆabreviazione:
(P8)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() .
.
Le (P7) e (P8) esprimono la proprietÓ associativa dellÆoperazione
retta da ō∩ö.
(P9)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() ,
,
che esprime la proprietÓ
distributiva di ō∩ö rispetto a ōUö (il segno ō∩ö,
per la convenzione (P4), Ķ sottinteso
nellÆultima formula).
(P10)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() ĀĀ ,
ĀĀ ,
cioĶ: la proprietÓ ōaŃö Ķ
assurda. O, in altre parole, non Ķ
possibile che qualcosa sia ōaöĀ e
ōnon-aö nello stesso tempo.13
Per le definizioni
e gli assiomi dati, si possono
assumere tre sole regole deduttive, che
appelleremo:
D1. Regola
di sostituzione tra simboli di segno uguale.
D2. Regola di sostituzione tra simboli di segno diverso.
La D1. ha origine dal significato del termine
ōsimboloö che, stando per un ōgenericoö
termine, permette di sostituire, in una data proposizione, un determinato simbolo
con un qualsiasi altro simbolo; purchķ:
a simboli di eguale nome si
sostituiscano altri simboli che,
corrispondentemente ed uniformemente,Ā
siano ancora di eguale nome;ĀĀĀ
cosņ,ĀĀ per esempio,ĀĀĀĀ la (P9)ĀĀ siĀ
pu“Ā scrivereĀĀĀ ancheĀ
ōx (y U z) . = . xy U xzö con identico
significato. Ma non Ķ lecita la sostituzione ōx (y U z) .
= . xb U xzö perchķ, se si cambia il nome di ōbö con ōyö, la sostituzione deve essere effettuata in tutti
i posti in cui compaia il simbolo ōbö nellÆintera
proposizione. Ci“ in quanto,
allÆinterno di ogni singola proposizione (o
in una catena deduttiva), il simbolo ha
significato ōcostanteö, anche se Ķ ōvariabileö da una proposizione allÆaltra.
La D2. ha origine dalla proprietÓ del segno ō=ö,
che dÓ, identicamente, lo stesso signifiŁcato ai termini a destra e a sinistra
di esso. Seguendo il Padoa, la chiameremo: la proprietÓ sostitutiva del segno ō=ö.
Infatti, se quello che sta a destra di ō=ö significa la stessa
cosa di quello che sta a sinistra (e viceversa) ne segue che se si asserisce: ōa = bö,
si pu“ sostituire ōaö in
qualunque formula compaia ōbö, e
viceversa. Per di pi∙, qualunque operatore
sia definito su ōaö, lo si pu“
applicare anche su ōbö senza alterare
lÆidentitÓ.
Esprimendo quanto detto con una formula:
D3. Se
ōωö Ķ un operatore che ha senso applicare al termine simbolizzato da ōxö
allora:
x = y . ╔ . ω x = ω yĀ ,
anzi, se ōωö ammette un
inverso allora il segno ō╔ö si
pu“ sostituire nellÆultima formula con il segno ō=ö.
Per la proprietÓ
sostitutiva del segno ō=ö
non Ķ necessario, per questa seconda regola deduttiva, operare la sostituzione
del simbolo in tutti i posti in cui
esso compaia, dato che il simbolo che
si va a sostituire ha lo stesso significato di quello che lo sostituisce
(infatti sono sinonimi). Solo ragioni
di convenienza, a fini deduttivi, ci
suggeriscono dove e quando operare la sostituzione.
Dalla proprietÓ
sostitutiva del segno ō=ö
vengono fuori immediatamente le proprietÓ caratteristiche dellÆidentitÓ e cioĶ le proprietÓ: riflessiva, simmetrica e
transitiva. E cioĶ:
(I1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a =
a
(I2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a = bĀ . = .Ā b =
a
(I3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ (a = b) ∩ (b =
c) ĀĀ. = .Ā (a = c)
***
A partire dalle (P1) - (P10), mediante le regole deduttive D1., D2., D3., si possono dedurre molti teoremi sulle proprietÓ.14
Se si introduce lÆassioma:
(P11)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
a ╔ bĀ . = .Ā ab =
a ,
la comprensione di un
concetto diventa una struttura ordinata dalla relazione ō╔ö.15
Una struttura analoga si verrÓ a generare
anche per le proposizioni, a partire
dallÆassioma del metalinguaggio (analogo di M1):
(M3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ ![]() ĀĀ ,
ĀĀ ,
se si assumono assiomi analoghi ai (P1)
- (P10) (vedi Appendice).
Qui notiamo solo che, ovviamente,
lÆoperazione di complementazione diventa
la ōnegazioneö.
LÆunione diventa la ōdisgiunzione inclusivaö.
LÆintersezione
diventa la ōcongiunzioneö.
LÆassioma (P5)
diventa lÆasserzione metalinguistica che ōdue negazioni affermanoö.
Valgono, analogamente, le proprietÓ: commutativa, associativa e
distributiva.
LÆinclusione tra proprietÓ diventa lÆōimplicazioneö
tra proposizioni (detta anche
segno di ōdeduzioneö).
Anche qui vale il fortissimo assioma:16
(Q11)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ax ╔ byĀ . = .Ā axby
= ax .
Nel caso che tutte le proposizioni si
riferiscano ad un solo individuo ōxö, si instaura un perfetto
isomorfismo tra le due strutture formali relative alle proprietÓ e alle corrispettive proposizioni
riguardanti il detto individuo; ci“ si ottiene formalmente con lÆassioma:
(C1)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
(ab)xĀ . = .Ā axbx
.
Un altro importante assioma e:
(C2)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ x╬aĀ . =
.Ā ι x ╬ ßa . = .Ā i x ╔ a
che permette di dimostrare unÆaltra forma di sillogismo relativo alle
asserzioni singolari:
(C3)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ
ax ∩ (a ╔ b)Ā . ╔ .Ā bxĀĀ .
Un altro ovvio assioma, che come il (C2)
permette il collegamento tra proprietÓ di un livello a quelle di livello
superiore, Ķ:
(C4)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╬ ßbĀĀ . = .ĀĀ ßa ╬ ßßbĀ
che, ovviamente, si pu“ scrivere anche:
(C4Æ)ĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀĀ a
╔ bĀĀĀ . = .ĀĀĀ
ßaĀ ╔Ā ßbĀ
Parentesi
epistemologica
Fin dal tempo in cui lÆuomo ha cominciato a
riflettere su se stesso e sulla realtÓ che lo circonda, egli ha coltivato due
superbe illusioni; da un lato, quella di scrivere un libro, simile a quello
delle fantastiche invenzioni di Borges, in cui vi fossero elencate tutte le
propoŁsizioni della conoscenza universale ricavate da unÆinfinita sequenza di
osservazioni empiriche. Questo, e solo questo, avrebbe costituito ½LA SCIENZA╗
e, per sapere qualsiasi cosa relaŁtiva allÆuniverso fisico e mentale, sarebbe
bastato consultare questo immenso vocabolario, dovendosi solo conoscere
lÆordine in cui le conoscenze furono disposte.
Da questa illusione, nasce lÆidea dellÆōuomo dottoö come magazzino di informazioni varie, benchķ sconnesse, che ancora dura ai nostri giorni e, anzi, si rafforza per via dellÆinfinita congerie di informazioni su presunti risultati di scienze confuse, diffuse, profuse dagli odierni mezzi di informazione di massa.
Dalla stessa illusione
nascono le innumerevoli filosofie che, sotto diversi nomi, si rifanno alla
concezione empirista della realtÓ.
Ma, non appena si cominci a stendere tale libro, anche nelle dimensioni le pi∙ ridotte, ci si accorge subito che non Ķ per nulla facile trovare lÆordinamento pi∙ razionale affinchķ esso risulti di facile consultazione. Si scopre che Ķ indispensabile un criterio di classificazione.
Nasce cosņ la tassonomia e le sue strutture astratte
che, ora, vengono identificate con ōLA SCIENZAö.
Ci“, a un certo punto, crea
la seconda superba illusione, secondo la quale, un bel giorno, lÆuomo sarÓ in
grado di possedere unÆunica e breve formula magica a partire dalla quale, senza
nemmeno pi∙ consultare il risultato degli esperimenti, si potranno dedurre
tutte le conoscenze dellÆuniverso. Questo crea il mito dellÆōuomo coltoö che,
seduto a tavolino con la pipa in bocca, alla stregua di Ercole Poirot, da pochi
indizi ricrea presente, passato e futuro.
La stessa illusione dÓ
origine alle pratiche magiche ed a tutte quelle filosofie che sotto vari nomi
si rifanno alla concezione idealista della
realtÓ.
Si potrebbe pensare che chi
coltiva la prima illusione non possa coltivare la seconda e viceversa. Ma ci“
non Ķ vero perchĶ lÆuna illusione Ķ conseguenza dellÆaltra, come appunto gli empiristi logici stanno a dimostrare,
non solamente, guardando al nome con cui si qualificano!
Ora ci occuperemo un momento
degli effetti della cattiva filosofia di cui alla citazione di Engels in nota8.
Quando ci si voglia occupare
scientificamente di un determinato campo
di ricerca bisogna necessariamente delimitarlo.
Gli epistemologi di
orientamento empirista pensano che, intanto, bisogna partire dai fatti, cioĶ dal dato empirico. Altri
obbiettano che ci“ Ķ praticamente impossibile dal momento che in nessuna
scienza esiste il dato empirico in astratto ma solo una ben particolare
selezione di dati. E per fare tale selezione preventiva noi dobbiamo essere giÓ
in possesso di una teoria anche se in una forma ancora rudimentale.
La pi∙ rozza forma di teoria
deve partire da alcune proprietÓ che,
allÆinizio, saranno necessariamente vaghe e non ben definite ma che possono
permettere una prima classifiŁcazione. Qui siamo ancora in una fase puramente
tassonomica o, per usare la terminologia di Bunge,17 in una fase protoscientifica.
Dal momento che ci“ sembra
ovvio e banale cÆĶ da chiedersi come mai gli empiristi trascurano questo ōfattoö, visto che si appellano ai ōfattiö.
Inseguendo le loro
argomentazioni ci si accorge che essi usano il termine fatto nellÆaccezione della lingua comune, la quale porta a
confondere gli elementi teorici con gli elementi fattuali.
Il sostantivo fatto Ķ omonimo del participio passato
del verbo fare. Ma, nellÆaccezione comune, il sostantivo, da tale participio
derivato, assume i significati relativi a tutti i tempi del participio:
presente, passato e futuro.
Per cui, usualmente, molti
considerano un fatto il contenuto
semantico della propoŁsizione: chiunque
cada dalla finestra finisce a terra.
╚ ovvio che questa non si
riferisce al passato, come in sono caduto
dalla finestra e sono finito a terra che, effettivamente, si riferisce ad
un ōfattoö; ma, piuttosto,
rappresenta un fuŁturo ipotetico ed ha la struttura di una legge fisica che, in
ogni caso, contiene elementi teorici e, come minimo, presuppone il postulato
metafisico induttivista che se una
correlazione tra due fatti si Ķ
sempre verificata in passato deve continuare
a verificarsi in futuro.
Intanto, la proposizione
precedente si deve, correttamente, porre nella forma se qualcuno cade dalla finestra, allora egli finisce a terra ovvero
x ╬ a ╔ x ╬ b, dove
ōxö Ķ il qualcuno, ōaö Ķ la
proprietÓ di cadere dalla finestra e ōbö
quella di finire a terra.
Pi∙ semplicemente possiamo
scrivere a ╔ b, dal
momento che, in ogni discorso teorico si fa lÆipotesi forte che la legge vale
qualunque sia lÆindividuo ōxö, per cui la proprietÓ coincide con la sua estensione,
ipotesi questa che dovrÓ mantenersi fino a prova contraria, altrimenti
sarebbe difficile fare qualsiasi deduzione che non sia banale.
Per la fisica, la precedente
proposizione Ķ vera ma Ķ ellittica e la si dovrebbe completare con un sistema
deduttivo di proposizioni del tipo:
1) Tutti i corpi soggetti alla
forza di gravitÓ sono accelerati lungo la direzione della forza stessa.
Questo Ķ un principio fisico
che, nella teoria, assume il ruolo di assioma;
il che Ķ un modo per dire che Ķ una proposizione primitiva, cioĶ
indimostrabile (e nemmeno verifņcabile, visto che noi possiamo sperimentare
solo sotto certe particolari condizioni mentre il principio Ķ espresso in forma
universale).
2) Sulla terra cÆĶ un campo di
forze di gravitÓ diretto dallÆalto verso il basso.
Anche questo Ķ un assioma.
3) x Ķ soggetto alla
forza di gravitÓ della terra ed Ķ libero di cadere perchķ la finestra Ķ situata
in alto rispetto alla superficie della terra.
Questa Ķ una condizione
iniziale. Nella teoria assume il ruolo di ipotesi, eventualmente da verificare
empiricamente, da assumere anchÆessa come proposizione primitiva.
4) x finisce a terra per 1), 2),
3) e per le leggi del movimento.
Risultato verificabile
empiricamente. Nella teoria Ķ un teorema.
Ma questa Ķ solo una rozza
semplificazione che serve solo a dare lÆidea della complessitÓ di una
descrizione scientifica del fenomeno considerato.
A questo punto qualcuno
potrebbe pensare che la descrizione scientifica complica inutilŁmente le cose
solo per dire, nķ pi∙ nķ meno, quello che, non solo giÓ sapevano, ma che,
addiritŁtura era assolutamente necessario sapere per avere una pur minima
legittimitÓ nellÆasserire i princņpi fisici da cui si tira la conclusione.
Ci“ Ķ tremendamente vero!
Ma la spiegazione
scientifica non ha lo scopo di dedurre cose banali da cose banali (come spesso
appare dopo avere letto i pi∙ famosi libri di epistemologia!). Ma il suo scopo
Ķ quello di dedurre, rigorosamente, da cose assolutanmemņte banali, o ritenute
tali, cose di gran lunga pi∙ complicate come, p. es., dedurre lÆistante preciso
in cui un missile (lanciato dalla terra da un certo posto e in un certo
istante) raggiungerÓ il pianeta Marte ed in quale preciso punto.
La previsione risulterÓ pi∙
interessante se quello che si deduce Ķ paradossale, perchķ questo imporrÓ la
scelta tra le ipotesi di partenza e le conclusioni finali o, quanto meno, una
reinterpretazione della teoria; non potendosi, almeno logicamente, mantenere
due propoŁsizioni contradittorie.
E qui si capisce a che serve
la logica!
Essa non ci pu“ dire niente
sulla veritÓ delle ipotesi e degli assiomi, nķ su quella delle conclusioni!
Ma ci pu“ dire se ipotesi,
assiomi e conclusioni siano contradittori o compatibili. E ci“ Ķ molto
importante per la scienza.
La logica non Ķ la scienza
della VERIT└ ma, semplicemente, un piccolo insieme di regole di deduzione.
Anzi, non Ķ nemmeno una scienza ma una precondizione di ogni scienza!
Allora, come giÓ sapevano
gli antichi, nella scienza non si parte dai fatti
ma dalle proprietÓ, (o dai concetti che Ķ lo stesso) che una volta
astratte dallÆesperienza sono gli individui
della nostra comprensione e gli elementi della nostra teoria.
La comprensione Ķ un insieme strutturato di proprietÓ; Ķ unÆalgebra di Boole, come giÓ detto
nella sezione precedente.
Quanto detto vale anche per
una scienza puramente empirica, cioĶ priva di qualunque forma di teoria la quale
possa assumere ōa prioriö i suoi elementi
costitutivi.
Infatti, per la costituzione
di un linguaggio scientifico si parte (consciamente o inconsciamente) da un
insieme non strutturato di proprietÓ, che chiameremo i generatori dellÆalgebra (sottinderemo: della comprensione); essa delimita il campo di ricerca.
Tutte le altre proprietÓ del
campo di ricerca, elementi compresi,
possono essere generate, appunto, da tali generatori
mediante lÆoperazione tra
proprietÓ, nand, che abbiamo indicato
con il simbolo ![]() .
.
Potrebbe sembrare, a prima
vista, che partendo da un numero finito di proprietÓ si possa generare tutta
unÆinfinitÓ di altre proprietÓ, per effetto di successive e ripetute
applicazioni dellÆoperazione nand.
Ma ci“ non Ķ vero, in quanto
gli assiomi che sono stati dati nella sezione precedente limitano enormemente
il numero delle proprietÓ semanticamente differenti. Si dimostra, infatti, che
se si parte da n generatori si
possono ottenere solo N Ż 2n
proprietÓ atomiche, cioĶ proprietÓ,
mutuamente incompatibili, mediante le quali si pu“ generare tutta lÆalgebra
della comprensione, che conterrÓ
esattamente 2N proprietÓ,
comprese la proprietÓ assurda, che
abbiamo indicato con ![]() , e la sua complementare, che indicheremo con
, e la sua complementare, che indicheremo con ![]() Āe che chiameremo la ōproprietÓ banaleö, cioĶ quella
proprietÓ posseduta da tutti gli individui
che costituiscono il campo di
ricerca.
Āe che chiameremo la ōproprietÓ banaleö, cioĶ quella
proprietÓ posseduta da tutti gli individui
che costituiscono il campo di
ricerca.
Faremo il postulato che le
proprietÓ della comprensione, cosņ
generata, costituiscano tutte e sole le proprietÓ possedute dagli individui del
campo di ricerca.
Tra le proprietÓ generate,
alcune hanno unÆimportanza maggiore delle altre; per cui risulta utile
introdurre, mediante definizione nominale,
dei segni particolari per esse.
Il massimo numero di
proprietÓ atomiche, N = 2n, si otterrÓ
solo quando capiti che si siano scelti i generatori tutti indipendenti tra loro
di modo che, presi due qualunque di essi, p.es. ōaö e ōbö, si abbiano
certamente individui che posseggono contemporaneamente entrambe le proprietÓ,
cioĶ, quando si possa certamente asserire: $ ab.
Ne segue che, se con
Aristotele, pensassimo di definire la sostanza
o essenza
(ούσία) come la proprietÓ dellÆesistenza delle
cose (facendo astrazione da ogni altra proprietÓ), si avrebbe n = 0,
N =
20 = 1 e la comprensione avrebbe solo 2N=
21 = 2 proprietÓ e cioĶ solo la proprietÓ assurda e la proprietÓ
banale, come Parmenide cercava di far capire agli empiristi che
precedettero lÆempirista Aristotele. Ma ci“ lo esamineremo pi∙ dettagliatamente
in seguito.
***
Ma, per potere entrare nei
dettagli della scienza degli antichi, Ķ necessario chiarire alcune questioni
metodologiche.
Solo pochissimi frammenti ci
sono pervenuti dei cosiddetti presocratici.
Quasi tutto quello che
sappiamo, o che crediamo di sapere, ci proviene dai dossografi.
Si potrebbe pensare che con
un minuzioso lavoro filologico si possa ricostruire, in qualche modo, il loro
pensiero. Questa, in ogni caso, Ķ lÆopinione generale. Ma noi pensiamo che la
filologia non Ķ di nessuno aiuto in questa impresa. La riprova di ci“ Ķ che ci
sono tanti Parmenidi e tanti Democriti per quanti filologi ci siano.
Escludiamo, ovviamente, dal
novero dei filologi tutti quelli che hanno seguito (o che seguono) un ben
determinato paradigma. Chķ, per i ben noti meccanismi della carriera
accademica, non aggiungono niente di nuovo.
╚ per la forza del paradigma
aristotelico che molti dossografi sembrano dire la stessa cosa. Di fatto, non
fanno altro, per lo pi∙, che pestare e ripestare le opinioni di Aristotele, con
la convinzione, che ancora perdura, che il pensiero di Aristotele, ritenuto il
pi∙ grande scienziato del passato, fosse pi∙ maturo dei suoi predecessori.
Questo in omaggio a quella che abbiamo chiamato la teoria delle PULCI.
Se si abbandona questa
teoria si potrebbe pervenire alla conclusione che Aristotele rappresenta un
profondo arretramento nel processo di costruzione del linguaggio scientifico.
Ma se neghiamo valore ai
dossografi e al loro progenitore Aristotele come potremo procedere?
Semplicemente sostituendo la
logica (come chiarita da Peano) alle speculazioni metaŁfisiche che cercano
supporto nella filologia.
GiÓ lo stesso Peano aveva ricostruito, con i
suoi ōsimboliö, lÆopera di Euclide;
nella convinzione (che Ķ anche la nostra) che, da qualunque punto si parta, se
si procede coerentemente e senza ambiguitÓ, il risultato deve necessariamente
essere lo stesso, se le ipotesi di partenza sono le stesse.
Ma quali erano le ipotesi
dei ōpresocraticiö?
Questo ce lo faremo dire
dallo stesso Aristotele, che nel criticarli, le ha enunziate, anche se
malamente illuminate, allÆombra del suo paradigma.
Quindi per studiare i
presocratici saremo costretti a partire da Aristotele; ma non dalle sue conclusioni,
bensņ da unÆanalisi logica del suo paradigma.
***
Accettando le conclusioni di
Max M³ller,18 Peano notava che
le categorie grammaticali derivano da Aristotele, il quale elenca dieci categorie logiche in corrispondenza con
le parti del discorso della grammatica greca. Lo stesso M³ller osservava che la
classificazione dei vocaboli nella lingua semita e in quella cinese era ben
diversa.
Questo significava, per
Peano, che altro sono le proprietÓ reali dei nomi e altra cosa le proprietÓ
formali, in quanto derivanti esclusivamente dalla tradizione linguistica.19
A partire da questo possiamo
concludere alcune cose ovvie.
Si dice spesso che
Aristotele Ķ da considerare il padre della logica. Peano, in pi∙ di
unÆoccasione, nota che la logica di Aristotele Ķ di nessun uso per la
matematica. La diversitÓ concettuale, del resto, salta immediatamente agli
occhi.
DÆaltra parte, le conquiste
nel campo della matematica dei presocratici sono immense. Si pensi ad Eudosso e
Democrito che godevano la profonda ammirazione di Archimede.20
Ovviamente, non si pu“ fare
matematica senza logica; e, del resto, tra le opere di Democrito, elencate da
Diogene Laerzio tra gli scritti di fisica, vi figura Logica o Canone in tre
libri.21
Se ne pu“ semplicemente
concludere che la logica di Aristotele Ķ la logica del senso comune e quella di
Democrito doveva necessariamente essere quella della matematica.
***
Quale dovrebbe essere la
logica della scienza in generale?
Per Democrito non ci sarebbe
potuto essere alcun dubbio, visto che per lui la scienza era una e non era
divisa in branche e sottobranche di specialisti che, secondo lÆaforisma di
Bernard Show, sono coloro che sanno tutto su nulla.
Oggi, la risposta non sembra
cosņ ovvia, anche a causa della confusione epistemologica di marca russelliana,
ancora imperante! (si veda PF).
╚ utile entrare, per un
momento, in qualche dettaglio per capire la profonda differenza tra le
metafisiche che si nascondono sotto dei simboli apparentemente uguali e per
vedere come lo scontro tra queste due contrapposte metafisiche non Ķ diverso da
quello che ciclicamente si Ķ verificato nel corso della storia.
Come viene chiarito in PF,
tale differenza si manifesta nellÆinterpretazione estensionale del termine
classe nellÆuna concezione del mondo contrapposta a quella intensionale
dellÆaltra.
Al senso comune appare che
gli oggetti immediati della nostra percezione siano le ōcoseö in quanto ōindividuiö.
Da esse noi formeremmo gli aggregati di cose. Successivamente, avendo dato
un nome allÆaggregato, raggiungeremmo la ōclasseö.
Se cosņ fosse non avremmo
nemmeno bisogno di nominare le proprietÓ.
Infatti nella logica empirista il ruolo delle classi risulta del tutto marginale ed il
ruolo primario viene assunto dalle proposizioni categoriche.
Per esempio, Russell (vedi
PF) concede qualche ruolo alle intensioni
solo per parlare dei numeri transfiniti, che per altro, nessuna applicazione
trovano nelle scienze.
Saltando, cosņ, con un solo
incredibile balzo, dalle banalitÓ della logica del senso comune agli
iperuranici meandri dellÆinfinito.
Tuttavia, una tale filosofia
ha un profondo fascino; perchĶ conforta gli sciocchi che si sentono a loro agio
nel linguaggio atavicamente acquisito e pretendono di stupire il mondo con i
supposti paradossi della matematica. Allo stesso modo di Aristotele che
pretendeva di superare quelle che egli chiamava le aporie di Zenone; le quali,
invece, come vedremo, erano dei semplici teoremi. Il paradosso nasceva solo al
confronto con le difettose premesse aristoteliche.
Uno potrebbe, ingenuamente,
pensare che, quando si incontrano dei paradossi, vuol dire che i significati
degli assiomi di partenza (essendo libere creazioni dellÆintelletto umano!)
siano contraddittori; ma i falsi profeti concludono diversamente; ipotizzando,
inconsciamente o esplicitamente, che i loro assiomi e relativi significati
siano leggi imposteci dalla natura; per cui bisogna abituarsi a convivere con
paradossi ed aporie, cercando di arrangiarsi a fare il meglio che si pu“
acciocchķ non diano soverchio fastidio quando dal mondo iperuŁraneo del
pensiero astratto si voglia fare il tentativo di applicarle a situazioni
concrete o pseudoconcrete.
Per assaporarne, in seguito,
le analogie coi discorsi degli antichi, esaminiamo il paradosso centrale dei
logici moderni che Ķ, appunto, quello che va sotto il nome di ōparadosso di Russellö
e che deriva, sostanzialmente (senza tenere conto delle infinite chiacchiere
inutili) dal dogma che la matematica si occupa solo di estensioni e dalla
conseguente identificazione del termine classe
con il termine aggregato. (Per
capire come Russell doveva, necessarianmente, arrivare al paradosso basta
leggere la confusa ed incomprensibile distinzione tra classe, concetto e concetto-classe
nellÆintero capitolo dedicato a tale questione nel suo The principles of mathematics, dove con argomenti non dissimili da
quelli medioevali, riferentisi al sesso degli angeli, si critica, anche a
sproposito, la chiara e precisa impostazione di Peano; vedi, comunque, PF).
Per Peano, al contrario, la logica non Ķ una scienza a sķ sulla
quale esercitarsi con lÆalta matematica, per poi applicarla ad astruse
questioni metafisiche (nel senso deteriore di tale termine) ma Ķ un semplice
strumento per il chiarimento dei concetti della matematica; la quale, a sua
volta, non serve per costruire castelli di carta della pi∙ inutile astrazione,
ma costruisce le sue strutture formali a partire da modelli che idealizzano le
concrete operazioni della scienza empirica.22
Per Russell, la matematica Ķ
quella scienza che non deve sapere nemmeno di che cosa tratta, secondo un
paradossale aforisma russelliano. Ma nonostante ci“, egli procede imŁpunemente
a matematizzare la logica.
LÆobiezione, pi∙ ovvia, a
una tale impostazione Ķ quella di notare, banalmente, che fare della matematica
sulla logica che, a sua volta, deve servire a fondare la matematica, equivale a
porsi lÆirresolubile problema di sapere se Ķ nato prima lÆuovo o la gallina;
come tutte le successive chiacchiere inutili sul sovrumano problema dei fondamenti
della matematica stanno a dimostrare. Infatti, la conclusione a cui
giungono i superlogici che si
autodefiniscono metamatematici Ķ la
contradittoria asserzione che, da un lato, la matematica non si pu“ fondare
sulla logica (vedi le varie interpretazioni del famigerato teorema di Goedel) e
che, dÆaltro lato, la matematica Ķ riducibile ai concetti della logica.
Ma vediamo di capire
lÆessenza del tremendo ed esiziale paradosso
di Russell.
Se, come abbiamo convenuto,
scriviamo ōa e Cö per dire che ōaö Ķ una
classe, dove ōaö e un simbolo che pu“ assumere qualunque
valore semantico (ovviamente tra i termini che denotano una classe), possiamo
pensare di essere liberi di attribuire ad ōaö
il particolare valore ōCö, scrivendo
ōC╬Cö.
Se interpretiamo ōCö come sinonimo di mucchio, cioĶ estensionalmente, e, ancora arŁbitrariamente, ipotizziamo di essere
liberi di creare astrattamente dei mucchi
con la sola potenza del nostro pensiero, possiamo pensare, che oltre a ōCö, ci siano altri mucchi per i quali si possa scrivere ōa ╬ aö (pressappoco come quel fantastico mucchio di spaghetti che
contiene la pentola che li contiene; infatti basterÓ ribattezzare la pentola con il pi∙ pomposo nome di insieme degli spaghetti che contiene se
stesso!) chiamiamo tali chimerici mucchi:
insiemi
chiusi.
Ovviamente ci sono anche
banalissimi insiemi che fra i loro
membri non contengono lo stesso insieme che li deve contenere, chiamiamoli: insiemi aperti.
Immaginiamo ora, sempre con
lÆinfinita potenza del nostro pensiero, di compiere un ultimo atto di creazione
e generiamo Eva dalla costola di Adamo inventandoci lÆinsieme di tutti gli insiemi aperti che chiameremo ōRö.
Nasce un tremendo problema
che assomiglia al problema di Wiener il quale si chiede se, essendo Dio
onnipotente, possa creare un masso cosņ pesante, ma cosņ pesante, che Egli
stesso non possa sollevare. Il problema o non ha soluzione perchķ mal posto o
conduce ad una contraddizione che viene a negare lÆonnipotenza di Dio. Infatti
o Ķ in grado di creare il masso e allora non potrÓ sollevarlo o non ne sarÓ in
grado. In ogni caso, non sarebbe onnipotente.
Non dissimile il problema di
Russell: Ķ R chiuso o aperto?!
Se Ķ chiuso dovrÓ aversi R ╬ R. Ma R era lÆinsieme
degli aperti e, quindi, R Ž R, per
definizione.
Se Ķ aperto dovrÓ aversi R Ž R ma
allora dal momemmto che R Ķ aperto
dovrÓ essere contenuto in R che Ķ
lÆinsieme degli aperti e quindi R ╬ R.
Allora, o la questione Ķ mal
posta o il pensiero astratto non Ķ
onnipotente. Noi pensiamo che entrambe le ipotesi siano vere!
Ma forse che, da questa
patente contraddizione, Russell ed i ōlogiciö posteriori concludono che ci deve
essere qualcosa di marcio sotto? No!, al contrario, pensano che sia un brutto
scherzo della natura stessa della
logica e quindi ricorrono a delle pezze per salvare il salvabile e, cosņ
Russell si inventa la famigerata ed inutilmente complessa teoria dei tipi che complicherebbe enormemente la
vita ai matematici che, infatti, lÆhanno sempre rifiutata.
Tuttavia, questi ultimni o
fanno limita di niente, forse tacitamente assumendo che la questione Ķ malposta,
o ricorrono ad una semanticamente non chiarita distinzione tra insieme e classe aggiungendo un, praticamente inutile, postulato secondo il
quale, affinchķ qualcosa sia un insieme non
basta che ci siano degli individui che vi appartengano ma deve esistere, anche,
un non meglio specificato ente a cui lÆinsieme stesso deve appartenere; con
divertenti conseguenze quando le astratte formule si volessero interpretare
semanticamente.
Infatti, a causa dello
stesso errore che porta ai paradossi, Whitehead e Russell, insieme ad altri
posteriori assiomatizzatori, giungono a definire lÆinsieme vuoto come lÆinsieme di quegli individui per cui valga la
proposizione ōx ╣ xö e la classe universale viene
definita come la classe di quegli individui per cui valga la proposizione ōx
= xö.
Analizzando le precedenti definizioni con lÆideografia di Peano se ne pu“ misurare facilŁmente la loro assurditÓ.
Per quanto riguarda la
classe universale: usando il precedentemente introdotto simbolo per la
formazione di classi a partire dalle proposizioni, si ha ō'x (x
= x)ö
e per la decomŁposizione diĀĀ ō = ö : ō'x ╬x ι xö che, per la proprietÓ giÓ menzionata dellÆoperatore 'x ╬x , si riduce semplicemente a ōι xö. Per cui la classe universale si riduce a quella che
abbiamo chiamato lÆidea di ō xö che, in ogni caso, Ķ una
classe con un solo individuo.
Ma, essendo ō xö un simbolo generico senza
significato definito, si conclude che la classe
universale Ķ la proprietÓ di nessun individuo determinato e quindi la proprietÓ assurda.
Allo stesso modo, per lÆinsieme vuoto si ha: ō'x (x
╣ x)ö
e quindi ō'x ╬x ~ ι xö e, alla fine, ~ ι x ; in conclusione: la proprietÓ complementare delle cose
che non hanno significato e quindi, se volessimo insistere sullÆinterpretazione
estensionale, la proprietÓ di tutte le cose che significano qualcosa; per cui
lÆinsieme ōvuotoö viene ad essere ōpienoö zeppo!
E si potrebbe continuare,
con divertimento, a volontÓ!
Nella formulazione di Peano,
tali assurditÓ non possono mai presentarsi; infatti: non ha senso scrivereĀ ō x ╬ xöĀĀ (come in molte altre
rinomate assiomatizzazioni si scrive!)ĀĀ
maĀ soloĀ ō x ╬ ßxöĀĀĀ oĀ ō x ╬ ι xöĀ qualunque cosa sia ōxö,
in particolare anche ōCö.
Per cui, al massimo,
potremmo ottenere solo le banali asserzioni ōCĀ ╔ Cö o ōC = Cö che sono,
ovviamente, sempre vere e ci dicono: nel primo caso che la classe Ķ una sottoclasse del termine classe o, in altre parole, che il termine classe Ķ un membro della
comprensione del concetto di classe; come, dÆaltra parte, vale per qualsiasi
altro termine!
Nel secondo caso avremo che
la classe Ķ identica alla classe o, in altre, parole che il
termine classe Ķ un membro del concetto di classe.
Tutte queste frasi sono modi
pi∙ precisi, anche se inutili e banali, di enunciare lÆambigua affermazione del
linguaggio comune che una classe Ķ una classe!
Come sempre, i paradossi
derivano da una ben povera teoria! Ma la gente sembra deliziarsi con i
paradossi e ne va costantemente alla ricerca in ogni campo della SCIENZA
(naturalmente di quella scritta a caratteri maiuscoli!).
***
La confusione
epistemologica, a nostro giudizio, pu“ essere portata avanti solo per un
profondo malinteso sul ruolo della matematica nella scienza.
CÆĶ, intanto, unÆimportante
distinzione che bisogna fare entro le scienze particolari a cui la logica si
applica, distinguendo tra quelle formali,
come la matematica, quando si astrae da qualunque applicazione concreta, e
quelle empiriche in cui la matematica
Ķ nientÆaltro che il mezzo per organizzare ogni discorso.
Nel primo caso si ha
solamente una struttura formale non interpretata. Nel secondo caso, oltre alla
prima, che spesso si dice la teoria, si
ha anche tutta una serie di affermazioni riguardanti i dati empirici, cioĶ esperimenti,
osservazioni empiriche, e loro
risultati fattuali, i cui termini sono dotati di significato non formale,
ma operazionale.
Il collegamento tra le due
parti del linguaggio viene operato mediante un processo di interpretazione di natura solamente e, necessariamente, metafisica
(cioĶ non dimostrabile formalmente,
nĶ verificabile empiricamente) che
consiste nello stabilire opportune relazioni tra termini definiti operazionalmente e termimui definiti teoricamente.
Solo allora i teoremi
dedotti dalle ipotesi teoriche potranno essere falsificati empiriŁcamente se, per di pi∙, si stabilisce un limite
di accettabilitÓ, tenuto conto che, in ogni esperimento reale, siamo costretti
a un processo di idealizzazione per
cui, solo statisticamente, si possono
trarne conclusioni intorno allÆaccordo tra teoria ed esperimento.23
Gli stessi termini operazionalmente definiti presuppongono
elementi teorici, anche se non formalizzati, provenienti dal, generalmente
inconscio, processo di concretizzazione o
ipostatizzazione degli enti astratti (cioĶ che sono stati ōastrattiö dal caotico mondo delle
sensazioni).
A maggior ragione, gli
assiomi della teoria (che, ovviamente, non sono direttamente collegati ai
termini del linguaggio empirico) sono astrazioni;
ma, in questo caso, Ķ pi∙ opŁportuno dire idealizzazioni, intendendo con questÆultimo termine il processo per
cui, da determinate proprietÓ precedentemente astratte dal mondo sensibile
(anche se nei contesti i pi∙ disparati), a partire dalla ripetuta applicazione
dellÆoperazione tra proprietÓ che abŁbiamo indicato con ![]() , si generano altre
proprietÓ che definiscono una nuova idea generale, che non fa parte delle cose osservabili.
, si generano altre
proprietÓ che definiscono una nuova idea generale, che non fa parte delle cose osservabili.
Un esempio si ha in
meccanica classica dove si definisce il concetto di punto materiale, mediante le proprietÓ astratte di essere senza
dimensioni fisiche e, tuttavia, dotato di massa. DopodichĶ si attribuisce agli
individui di tale classe astratta anche la proprietÓ dellÆesistenza; quindi concretizzandola.24
Dal momento che i termini
della teoria rappresentano idealizzazioni e che, quindi, gli individui sono
definiti a partire dalle proprietÓ, e non viceversa (anche gli enti, cosiddetti,
sensibili sono, anche se spesso inconsciamente, definiti per proprietÓ!), ne
consegue che tali termini, per parlare propriamente, non avrebbero unÆestensione, se volessimo usare tale termine nellÆaccezione degli
empinisti, nella quale si mantiene lÆillusione che vi siano oggetti che
ōesistonoö in quanto sensorialmente percepiti. Quando invece in realtÓ si
assume ipostaticamente che esistono realmente
proprio perchķ creati indipendentemente dai nostri sensi e cioĶ al di lÓ
del caos sensoriale.
Ragione per cui, nel
linguaggio teorico, assumiamo (o, facciamo
la convenzione, come dice Peano) che lÆestensione
coincida con lÆintensione. Per
cui la classe si pu“ far coincidere
con la proprietÓ che la definisce.
Ma se tale identificazione,
tra intensione ed estensione, va bene nel linguaggio
teorico di una scienza empirica, non va per niente bene in un linguaggio
puramente tassonomico.
Infatti, senza la
convenzione ōext a = aö, possiamo solo scrivere: ōa ╔ ext aö (ma non viceversa) e non
saremmo pi∙ autorizzati a generare tutta lÆalgebra della comprensione e, al massimo, potremmo pervenire a una struttura
formale meno forte (esattamente si perverrebbe a quello che i matematici
chiamano un reticolo non distributivo).
Per vederne la ragione,
esaminiamo la scoperta giÓ attribuita ai Pitagorici (PR p. 131)25 che la stella
del mattino e la stella della sera sono
termini diversi per lo stesso oggetto.
Le proprietÓ che i due
termini descrivono sono diverse e non pu“ sussistere nessuna relazione di
inclusione tra di esse.
Empiricamente niente potremo
dire su una loro eventuale relazione; al massimo potremmo osservare determinate
correlazioni tra certe particolari osservazioni.
LÆasserzione della loro
equivalenza estensionale pu“ derivare solo da una teoria fisica sulla
costituzione del sistema solare che creerebbe un altro concetto (di ancora
diversa inŁtensione): il pianeta Venere.
A questo punto, non saremmo
in grado di stabilire nessuna relazione di inclusione tra le tre proprietÓ
diverse. Avremo bisogno di tutta una, piuttosto complessa, teoria che leghi il
moto dei pianeti alle nostre osservazioni empiriche; e, quindi (come minimo) di
una qualche teoria della luce.
LÆalgebra di Boole di questo
sistema teorico sarebbe davvero troppo vasta. Ma senza di questa non potremmo
scrivere nessuna relazione logica fra le tre proprietÓ.
Ma, naturalmente, la scienza
teorica procede per altre vie. CioĶ introducendo altre relazioni oltre a quelle
puramente logiche e che, invece, sono specifiche delle varie scienze
particolari (mediante le cosiddette definizioni
per astrazione Ś vedi PF).
Da ci“ risulta chiaro che il
mito empirista Ķ assolutamente vacuo.
Cosņ come lo Ķ quello del
razionalismo estremo; il quale viene derivato dal primo meŁdiante lÆillusione
di poter trovare una regoletta universale che spiega tutto anche a costo di
partire da strutture meno forti (come in meccanica quantistica) dellÆalgebra
della comprenŁsione e che si limitino a rispondere solo sul risultato di possibili
misure.
Da questa osservazione, la
fisica moderna, dentro il paradigma della meccanica quanŁtistica, conclude che
bisogna rinunciare a costruire lÆalgebra di Boole, accontentandosi di un
reticolo non distributivo; al quale, arbitrariamente, si attribuisce la
proprietÓ di modularitÓ debole. Ci“
semplicemente allo scopo di salvare il mito empirista.
Ma se si rinuncia alla
SCIENZA UNIVERSALE, si possono ben spiegare le nostre osservazioni empiriche
con ōmodelliö parziali
nellÆestensione ma strutturalmente completi.
Solo allora Ķ possibile e,
anzi, necessario identificare lÆintensione di un concetto con la sua
estensione, se si vuole ōdedurreö qualcosa.
Ma ci“, certamente, non
potrÓ essere possibile nella matematica, quando la si voglia considerare come
un puro gioco astratto di simboli, nel qual caso, parlare di estensione non
avrebbe molto senso, potendosi essa riformulare in modo da non nominare
assolutamente gli individui.
Ma, piuttosto, nella ōteoriaö delle scienze empiriche.
Vedremo che questa era la
filosofia degli antichi scienziati che vengono qualificati come Italici.
IlĀ linguaggio scientifico dei preso cratici.
Essere e Non-essere.
LÆintreccio tra le due
contrastanti metafisiche di cui alla sezione precedente Ķ molto antico.
P.es., Diogene Laerzio nel
Proemio alle sue Vite dei Filosofi divide
i filosofi antichi in due principali tradizioni: la Ionica che fa capo a Talete e lÆItalica
originatasi da Pitagora.
Non sembra che il criterio
di classificazione di Diogeime fosse geografico in quanto molti tra gli Ionici
non erano della Ionia, nĶ tutti gli Italici erano dellÆItalia. Tale
ripartizione Ķ molto antica e si fa risalire a Sozione.
Infatti tra gli Ionici
oltre, ovviamente, a Talete, Anassimandro, Anassimene e AnasŁsagora, vengono
annoverati anche Socrate, Platone e Aristotele. E tra gli Italici troviamo
oltre a Pitagora, Empedocle, Archita, Filolao, Parmenide e Zenone, anche
Eudosso, SenoŁfane, Leucippo, Democrito, Protagora ed Epicuro.
╚ probabile che la
bipartizione avesse a che fare, invece, con il differente dogma centrale che
ognuna delle due tradizioni assumeva. Esso si riferiva alle due possibili
alternative per lÆinterpretazione del termine realtÓ.
Nella tradizione ionica la
realtÓ inizialmente viene, sostanzialmente, identificata con il dato dei sensi;
la conoscenza della realtÓ quindi Ķ data immediatamente e la ragione umana pu“
solo limitarsi a classificare le sue esperienze, la matematica non Ķ adatta per
la comŁprensione della complessitÓ del reale come concluderÓ Aristotele (Metaf. 995a 15-20): ōNĶ, dÆaltra parte, si deve pretendere lÆuso
di un esatto linguaggio matematico indistintamente in ogni settore di ricerca,
ma soltanto nel caso che si studino enti immateriali. Perci“ un tale modo di
esprimersi non si addice allÆindagine sulla natura, giacchķ ogni ente naturale
non Ķ certanmente privo di materia.ö
Nella tradizione italica,
viceversa, il dato sensoriale Ķ solo apparenza;
la realtÓ in quanto essenza Ķ una
ricostruzione razionale accessibile solo mediante lo strumento matematico.
LÆimperativo per ogni
scienza era stato posto da Solone: ōTestimonia
le cose invisibili con quelle visibili.ö
Come possiamo interpretare
questa esortazione?
Dato per scontato che le ōle cose visibiliö, cioĶ le sensazioni,
sono il dato di partenza di qualunque processo conoscitivo, non possiamo
fermarci ad esse se vogliamo fare scienza.
Le sensazioni sono
semplicemente Caos. Fare scienza
significa, quanto meno, dare un ordine alle sensazioni, farne un Cosmos.
Non si pu“ nemmeno
riflettere sulle sensazioni senza individuarne alcune, che abbiano un certo
grado di stabilitÓ, dando un nome ad
esse. Ma questo Ķ solo il principio della scienza.
La scienza deve anche essere
in grado di spiegare per essere in grado di prevedere, quindi bisogna cercare ōle cose invisibiliö, cioĶ le
connessioni intime tra le cose visibili.
╚ da queste che bisogna
partire, non dai sensi.
Ma queste connessioni non
possono essere arbitrarie, devono essere ōtestimoniateö,
cioĶ verificate dai nostri sensi.
Quindi le sensazioni sono il
punto di arrivo della scienza non il punto di partenza, al contrario di quello
che pensano Aristotele e Mach (per citare alcuni dei pi∙ illustri empiristi).
Ma come son fatte le cose
invisibili?
Somigliano, forse, allÆaria dello ōIonicoö Anassimene, che secondo quanto riferisce IpŁpolito (PR p.
109): ōquandÆĶ tutta uniforme, sfugge
alla vista, mentre si mostra col freddo e col caldo, con lÆumido e il
movimento. E si muove sempre perchķ, se non si muovesse, tutto quel che si
trasforma non si trasformerebbeģ Sicchķ i contrari fondamentali per la
generazione sono il caldo e il freddoö ?
O non somigliano, piuttosto,
alla monade dellÆōItalicoö Pitagora;
che, secondo quanto riferisce Diogene Laerzio (DL VIII, 25)26: ōĶ principio
di tutte le cose; dalla monade nasce la diade infinita, che sottosta come
materia alla monade che Ķ causa; dalla monade e dalla diade infinita nascono i
numeri; dai numeri i punti; da questi le linee, da cui le figure piane; dalle
figure piane le figure solide; da queste i corpi sensibili, i cui elementi sono quattro: fuoco, acqua, terra,
aria che mutano e si volgono per il tutto, e da questo risulta il cosmo
animato, intelligente, rotondo, che contiene al centro la terra anchÆessa
rotonda e abitataö ?
La contrapposizione Ķ netta.
Gli Ionici, seguono una tradizione molto antica che si pu“ far risalire alle
prime civiltÓ neolitiche. Essa sfocerÓ in quelle che oggi vengono matematizŁzate
sotto il nome di teorie di campo.
Infatti Aristotele dice (PR
p. 89): ōritennero che i soli principi di tutte le cose fossero di
specie materiale, perchķ ci“ da cui tutte le cose hanno lÆessere, da cui
originariamente derivano e in
cui alla fine si risolvono, pur rimanendo la sostanza ma cambiando nelle sue
qualitÓ, questo essi dicono che Ķ lÆelemento, questo il principio delle cose e
perci“ ritengono che niente si produce e niente si distrugge, poichķ una
sostanza siffatta si conserva sempreģ Talete, il fondatore di tale forma di
filosofia, dice che Ķ lÆacqua.ö E Simplicio (PR p. 90) aggiunge che Talete
era spinto ōa tale conclusione dallÆesame
sensoriale dei fenomeni.ö
Quindi per gli Ionici la realtÓ non Ķ altro che una determinata materia sensibile che, in qualche modo trasformandosi, dÓ origine al mondo.
Ma tuttavia,
dialetticamente, tra i primi Ionici si ammetteva ancora un principio uniŁtario
allo stesso modo degli Italici. Infatti Simplicio (PR p. 90) dice: ōAltri supposero un elemento solo e questo dissero illimite per grandezza, come
Talete a proposito dellÆacqua.ö Ed Aezio (PR p. 90): ōTalete ed i suoi discepoli
dicevano che uno Ķ il cosmo.ö E cÆĶ anche il tentativo da parte di
Anassimandro di pensare il principio come indeterminato fisicaŁmente,
introducendo il termine di infinito; ma
secondo Aristotele (PR p. 100) ōĶ chiaro
che lÆinfinito Ķ causa come materia, che la sua essenza Ķ privazione e che il sostrato in sķ Ķ ci“ che Ķ continuo e sensibile. E tutti gli
altri [pensatori], si vede chiaramente, utilizzano lÆinfinito come materia.ö Simplicio (PR p. 109)
precisa che ōBisogna sapere che altro Ķ lÆinfinito e il limitato quanto al numero, il che Ķ proprio di
coloro che ammettono molteplicitÓ di princņpi, altro lÆinfinito e il limitato
quanto a grandezza, il che ... conviene
ad Anassimandro e ad Anassimene, i quali ammettono sņ un unico
elemento, ma infinito per grandezza.ö Ma nello stesso tempo parlano,
secondo Teofrasto (PR p. 109), di rarefazione
e condensazione.
Questo Ķ un punto che sarÓ
soggetto alla critica che muovono gli Italici, come vedremo.
Questi, come giÓ detto,
seguono la tradizione pitagorica che vuole spiegare le cose del mondo non
ricorrendo ai dati sensibili (i quali necessitano di spiegazione essi stessi)
ma allÆaritmetica e alla geometria.
Proclo (PR p. 118) ci fa
sapere che ōdopo Talete si ricorda come
studioso della geometria Mamerco, fratello del poeta Stesicoro [della cittÓ siciliota di Imera] e dopo costoro si dedic“ allo studio della
geometria e le diede forma di educazione liberale Pitagora, ricercandone i principi primi e investigandone i
teoremi concettualmente e teoreticamente: per primo egli tratt“ poi
dellÆirrazionale e trov“ la struttura delle figure cosmiche.ö
Ma anche qui cÆĶ un elemento
dialettico, se dobbiamo credere a Diogene Laerzio, il quale, parlando di
Pitagora (DL VIII, 14), dice che fu ōil
primo ad introdurre in Grecia misure e
pesi, come dice Aristosseno.ö
IlĀ discorso dei Pitagorici Ķ molto pi∙ astratto e di pi∙ difficile
comprensione di quello degli Ionici, specialmente per chi non ha confidenza con
la matematica e soprattutto con le applicazioni di essa al mondo fisico. I
travisamenti di Aristotele ne sono lÆesempio pi∙ lampante.
Ma giÓ, allÆinterno stesso
della tradizione pitagorica, avviene una profonda divisione (PR p.ĀĀĀĀ 124) tra esoterici (o matematici, o
Pitagorici) da una parte ed essoterici (o acusmatici, o Pitagoristi) dallÆaltra;
che in seguito si trasformerÓ anche in una contrapposizione politica (se pur
non sia stato esattamnente il contrario e cioĶ che la contrapposizione
ideologica fosse il risultato di quella politica!)27
Vediamo di interpretare le
parole, sopra riportate, con le quali Diogene Laerzio descrive la filosofia di
Pitagora.
Facciamo lÆipotesi che si
abbia:
monade =Ā ι
Āuno
che, nel linguaggio comune, viene espressa
con: la monade Ķ lÆuno; ma che pi∙
precisamente si dovrebbe esprimere con: la
monade Ķ identica al concetto di uno, se interpretiamo uno come una proprietÓ che diversi individui possono possedere o,
invece, (secondo la distinzione terminologica che abbiamo, a suo tempo,
introdotta): la monade Ķ identica
allÆidea di Uno, se, al contrario, pensassimo che Uno sia il nome proprio di qualche individuo esistente, magari nel
mondo iperuraneo. La nostra ideografia non Ķ in grado di distinguere tra le due
possibili interpretazioni che corrispondono a due diverse metafisiche. Ma dal
momento che la proprietÓ uno si dice
di ogni individuo, vale la prima interpretazione e, se Uno esiste, ovviamente Uno ╣ uno e
non serve ripetere il ritornello di Aristotele, che uno si dice in molti sensi, se si vogliono evitare le
contraddizioni.
Del resto, questa era la
polemica che gli Eleati portavano avanti contro i rozzi predeŁcessori di
Aristotele.
Notiamo, tuttavia, che si
pu“ porre, senza inconvenienti Uno . =
. ιĀ uno;Ā
ma, in tal caso, bisognerÓ scrivere ōUno . = . monadeö e ōmonade ╬ Monadeö, con la conseguenza che ci sarebbero infiniti mondi iperuranei.
Ma, naturalmente, in ogni
caso si avrÓ:
uno ╬ monade ,
cioĶ: uno
Ķ una monade che, senza la distinzione logica che abbiamo chiarito, sembra
che dica la stessa cosa di: la monade
ĶĀ lÆuno.
I dossografi non sono in
grado di afferrare la differenza tra individuo ed elemento (tra άτομον e μονάς)
per cui riportano (vedi PR p. 489): ōArchita
e Filolao chiamano indiffeŁrentemente lÆuno anche monade e la monade uno.ö
Molto probabilmente, invece,
i due Pitagorici menzionati volevano mettere in evidenza la diversitÓ formale
tra la proprietÓ e lÆelemento che ne Ķ il suo concetto.
Ma i dossografi sono ormai
sotto la cappa del vocabolario antiscientifico creato da Aristotele il quale,
anche se in qualche modo aveva intuito la profonda differenza della semantica
pitagorica rispetto a quella degli Ionici, non riesce a liberarsi dal concreto
sensibile e dalla sua logica grammaticale; dice infatti nella Metafisica (PR p. 520): ōI principi e gli elementi di cui si servono
i filosofi che sono detti Pitagorici, sono assai lontani da quelli dei
fisiologi. E la causa Ķ in questo, che essi non li hanno presi dalle cose
sensibili; gli enti matematici infatti, se si eccettuano quelli che riguardano
lÆastronomia, sono senza movimento.ö
La concezione degli enti
matematici di Aristotele oggi appare infantile, se confrontata a quella dei
Pitagorici che andava criticando; per cui egli si sorprende che i Pitagorici li
potessero applicare allÆindagine sulla natura ed allo studio delle cose percepibili. E si chiede stupefatto in
che senso si deve intendere che il numero e le proprietÓ dei numeri sono causa
delle cose che sono.
Per capire cosa mai i
Pitagorici intendevano dire, useremo le notazioni di Peano.
Indichiamo comņ ō xö
un individuo che appunto Ķ uno e indivisibile come lÆ άτομον dei greci.
Con indivisibile dobbiamo
intendere lÆoggetto pensato come indiviso, cioĶ in quanto individuo anche se, per altri aspetti, pu“ essere divisibile
allÆinfinito.
Si pensi al termine ōrettaö: possiamo pensare la retta come
individuo indivisibile comŁponente di uno spazio fatto di rette o come insieme
di punti e quindi divisibile allÆinfinito.
Nel linguaggio formale
bisognerÓ usare due simboli diversi per i due concetti se, nel contesto in cui
se ne parla, servono entrambi: se ōPö Ķ la
proprietÓ ōpuntoö, ō ßP ö sarÓ
la comprensione di ōPö e cioĶ la proprietÓ ōinsieme di puntiö. CioĶ: ōP . = . puntoö e ō ßPĀ .
= .
Āinsieme di puntiö.
Supponiamo che ōR . = . rettaö. Sarebbe errato scrivere: ōR ╔ Pö in quanto si avrebbe per sillogismo (nella sua forma singolare) ōx
╬ R . ╔ . x ╬ Pö, cioĶ, se ō xö Ķ una retta
allora ōxö Ķ un punto.
Bensņ, dobbiamo scrivere: ōR ╔ ßPö, che
dÓ origine a: ōx ╬ R . ╔ . x ╬ ßPö
(ovvero: ōx ╬ R . ╔ . x ╔ Pö), cioĶ se ōxö Ķ una retta allora x Ķ un insieme di punti.
Ma, nello stesso tempo,
avremo: ōι x ╬ ßR . ╔ . ι
x ╬ ßßPö cioĶ,
ōι xö Ķ il concetto di una data retta ōxö; ōxö, invece, Ķ una
tra le proprietÓ possibili degli insiemi di punti, cioĶ della comprensione del concetto insieme di punti, e, a sua volta, il
concetto insieme di punti Ķ la comprensione del concetto punto.
Nel linguaggio ordinario,
con il termine ōrettaö si intendono
entrambe le cose e non si possono evitare le contraddizioni.
Allo stesso modo, se
scriviamo: x ╬ monade avremo x = uno;
ma se scriviamo: ι x
╬ monade
(monade=elemento=concetto di essere uno), dobbiamo intendere ι x . = . uno e quindi: x ╬ ι x . = . x ╬ uno e, ancora: x = x . = . x ╬ uno. CioĶ, se qualcosa Ķ una monade essa Ķ lÆuno e, invece, quella
cosa di cui predichiamo che Ķ una, Ķ sempre uguale a se stessa e viceversa.
Di nessun concetto (o idea) noi possiamo predicare che non Ķ uno;
perchķ arriveremmo alla conclusione assurda che ōx ╣ xö. Quindi se qualcosa Ķ un concetto
o unÆidea, allora Ķ una.
Ma, dal momento che la vera
realtÓ, lÆessenza delle cose tutte, sono i concetti, allora se qualcosa ōĶö allora
essa Ķ una. E, allo stesso tempo, ōunoö sarÓ
molti, anzi infinito, essendo che infiniti sono gli individui dellÆestensione
del suo concetto. Asserzione che verrÓ, poi, ribadita dagli Eleati.
Tale asserzione esprime il
fatto ovvio che qualsiasi idea o concetto Ķ uno, financo il concetto di pluralitÓ.
E, viceversa, qualsiasi proprietÓ che non sia unÆidea singolare Ķ molti, come
la stessa proprietÓ di essere uno.
Abbiamo convenuto che uno Ķ una proprietÓ, infatti, non esiste
alcun individuo di cui ōUnoö sia il nome proprio.
Ma una volta che ci siamo
formati il concetto di uno, per
contrapposizione logica, acŁquistiamo anche il concetto di non-uno, che pu“ essere o semplice molteplicitÓ, cioĶ numero, o
lÆinfinito cioĶ il non numerabile (nel senso che non Ķ possibile assegnargli un
numero Śne viene che i numeri
interi, essendo infiniti, non sono numerabili; contrariamente alla definizione
odierna, originatasi dalle ipotesi di Cantor) ottenendo cosņ la ōdiadeö, cioĶ la coppia (uno;non-uno) che perci“ viene detta ōinfinitaö dai Pitagorici, in quanto
ogni cosa Ķ uno o non-uno.
Quindi la ōdiadeö non Ķ lÆidea di due.
Tuttavia gli individui della
diade sono due; ma tali due individui sono proprietÓ comŁplementari delle cose
tutte.
Lo stesso vale per qualsiasi
altra proprietÓ. In altre parole, tutte le volte che introduŁciamo una nuova
proprietÓ, se essa non Ķ la proprietÓ
assurda (il non-essere) o la proprietÓ banale (lÆessere), allora
esisteranno individui che hanno la proprietÓ complementare. Quindi tutto il
mondo viene generato (logicamente) dalle
coppie di contrari di cui i Pitagorici ne fanno un lungo elenco a scopo
esemplificativo.
Ma non tutte le proprietÓ
sono attribuibili allÆuno in quanto individuo della monade perchĶ molte altre
proprietÓ sono attribuibili solo agli individui che hanno la proprietÓ di
essere uno o non-uno, che sono tutti gli individui del mondo (fisico o logico
che esso sia).
Ma se limitiamo il campo di ricerca, identificando la diade
con la totalitÓ delle cose che sono nello spazio (la monade coinciderÓ, in
questo caso, con il concetto di punto), avremmo:
diade
=(punto;non-punto) e gli individui elementari sarebbero solo gli indivisibili punti.
Con ci“ abbiamo creato
unÆaltra diade di enti contrapposti e cioĶ la contrapposizione concreto-astratto; per cui lÆindividuo, in quanto pensato come
essere concreto, ōsottostÓ come materia
alla monade che Ķ causaö ovvero elemento,
(o anche: principio, forma, idea,
essenza, sostanza, ecc, che sono gli svariati termini con i quali, nel
fluire dellÆentropia durante il corso dei secoli, si Ķ tradotto il termine
greco αιτία o
gli altri termini con i quali Aristotele crede di spiegare il predetto
termine).
Che questa nostra
interpretazione possa essere la pi∙ corretta (necessitÓ logica a parte) viene
confermato da certe parole dello stesso Aristotele, lÓ dove dice (PR p.
512-13): ōAl tempo di costoro [Leucippo e
Democrito], si dedicarono alle matematiche e per primi le fecero progredire quelli che
son detti Pitagorici. Questi, dediti a tale studio, credetterro che i principi delle matematiche
fossero anche principi di tutte le cose che sono [notiamo che i princņpi
delle matematiche sono princņpi ōlogiciö].
Or poichķ principi delle matematiche sono i numeri [questa ci sembra una
personale opinione di Aristotele; infatti, per i Pitagorici non cÆĶ differenza
fra numeri e rapporti tra grandezze; e tutte le cose del mondo hanno grandezze
fisiche; e solo mediante queste le descriviamo! infatti i Pitagorici:] vedevano espresse dai numeri [perfino] le
proprietÓ e i rapporti degli accordi armonici ... hanno pensato che due sono le cause i Pitagorici, ma essi hanno in pi∙
pensato, e in questo Ķ la loro singolaritÓ, che il
limitato e lÆinfinito e lÆuno non siano attributi degli
altri enti, come il fuoco e
la terra e qualunque altra cosa
simile a questi, ma che lo stesso illimitato e lo
stesso uno siano la sostanza delle cose che da essi sono predicate [infatti
fuoco ╬ unoĀĀ uno ╬ predicato
= essenza = causa = elemento = sostanza = ...] ... di numeri compongono lÆintero cielo; ma non di numeri formati da unitÓ
senza grandezza, chķ essi attribuiscono grandezza alle unitÓ. ... Dicendo che sostanza Ķ
lÆunitÓ, e non la cosa di cui si dice che Ķ una,
Platone Ķ dÆaccordo coi Pitagorici; e ancora
sÆaccorda con essi quando dice che i numeri sono causa dellÆessere delle altre cose [cioĶ sono proprietÓ delle
cose che sono]. Suo proprio Ķ invece
lÆaver sostituito la diade allÆinfinito concepito come uno, e aver creduto che
lÆinfinito consti del grande e
del piccolo [infatti, per i
Pitagorici, lÆinfinito Ķ qualunque cosa sia diverso dal niente, dallÆuno e dal
molti, indipendentemente dal fatto che sia grande o piccolo, i punti di un
granellino di sabbia sono infiniti come quelli dellÆintero universo fisico]. Inoltre egli pose i numeri fuori delle cose
percepibili, mentre essi dicono che le cose stesse sono numeri [infatti, p.
es., gli occhi dellÆuomo ōsonoö 2 e
gli occhi sono cose!
Se ne diamo unÆaltra interpretazione, bisognerÓ pensare che i Pitagorici
fossero dei deficienti! ma questo proprio non sembra!], e non pongono nel mezzo gli enti matematici [da Platone
indebitamente ipostatizzati!]. Questo, il
porre, diversamente da quanto fanno i Pitagorici, lÆuno e i numeri fuori delle
cose, e introdurre le specie egli potĶ fare perchĶ
nella ricerca si serviva della dialettica, che i filosofi precedenti non
conoscevanoö.
Con il significato odierno
di dialettica diremmo che i filosofi precedenti erano dialettici, mentre
Platone era assolutamente adialettico, a meno che per dialettica non si intenda
la possibilitÓ di asserire contemporaneamente due asserzioni contraddittorie,
come spesso viene intesa.
Ma come mai dai ōnumeriö nascono i ōpuntiö?
Questo ce lo faremo spiegare
dal pitagorico Archita (PR p. 491): ōSÆio
mi trovassi allÆestremitÓ dello spazio, ad esempio nel cielo delle stelle
fisse, potrei tendere la mano o un bastoncino fuori di quella? o non potrei?ö
Se consideriamo come unitÓ
di misura il bastoncino (o la mano, in tal caso parleremmo di un ōpalmoö), con
lÆesempio di Archita avremmo generato la serie dei numeri interi e al limite lÆinfinito. La domanda di
Archita non Ķ altro che un modo di enunciare il principio di induzione
matematica cosņ come formalizzato da Peano. Ma il bastoncino lo possiamo
dividere in sottomultipli sempre pi∙ piccoli e al limite, otterremmo i ōpuntiö.
╚ divertente, a questo
proposito, osservare lÆincapacitÓ di Aristotele di pensare i numeri come
riferibili alle grandezze fisiche; al pi∙, ed ovviamente sbagliando, identifica
lÆunitÓ con il punto (PR p. 516): ōAnche
i Pitagorici pensano che il numero sia dÆun modo solo, e cioĶ [numero]
matematico ...Di numeri infatti
compongono lÆintero cielo; ma non di numeri senza grandezza, chķ essi
attribuiscono grandezza alle unitÓö e pi∙ oltre, avendo stabilito, invece,
che almeno le unitÓ non possono avere grandezza essendo indivisibili (non si
capisce perchĶ!), si chiede attonito: ōcomÆĶ
possibile che una grandezza sia composta da indivisibili? E tuttavia il numero
Ķ formato da unitÓ. Essi invece dicono che il numero Ķ le cose che sono, o
almeno applicano i loro teoremi ai corpi, come se i numeri fossero corpiö.
Ma per Pitagora di punti si compongono le ōlineeö e di queste le ōfigure pianeö e di queste, a loro
volta, le ōfigure solideö.
Ed in che altro modo
potremmo descrivere i ōcorpi sensibiliö se non con questi
strumenti matematici?
Forse che ōfuoco, acqua, terra, ariaö non sono
corpi sensibili?
E tuttavia essi assumono
forme geometriche ed hanno grandezza!
BasterÓ aggiungere il
movimento per ottenere il ōcosmo animato
e intelligenteö. IntelŁligente perchķ concepito dalla nostra intelligenza.
Tale filosofia Ķ stata in
seguito praticata da Democrito e da Archimede ed Ķ stata esplicitamente
enunciata da Galileo asserendo che la natura Ķ un libro aperto ma che i suoi
caratteri sono figure geometriche.
Ma ecco il concetto
centrale: il ōcosmo animatoö creato
dallÆintelligenza, la quale si contrappone al caos informe delle sensazioni.
Il concetto di ordine Ķ
fondamentale per il cosmo; nella lingua greca i due concetti hanno lo stesso
nome. Aezio (PR p. 131) dice: ōPitagora
fu il primo a chiamare cosmo la sfera delle cose tutte, per lÆordine che esiste
in essa.ö
╚ molto probabile che il
concetto di ordine derivasse da quello di legge
scritta che dalla sfera sociale veniva estesa alla sfera naturale. Nella Storia del mondo antico della Cambridge
University Press, lo storico P.N. Ure, in relazione al fatto che le prime
legislazioni scritte nel mondo di lingua greca si devono ai legislatori
pitagorici Zeleuco di Locri e Caronda di Catania, scrive: ōNelle comunitÓ di fondazione relativamente recente della Magna Grecia
e della Sicilia le costumanze inveterate erano indubbiamente considerate meno
sacrosante che nella madrepatria, circostanza che pu“ spiegare il ruolo
eminente che queste regioni ebbero nel mutamento importantissimo rappresentato
dallÆintroduzione di codici scritti.ö
Che le cose nella mente di
Pitagora fossero legate assieme Ķ testimoniato da Diogene Laerzio il quale
riferisce che egli scrisse tre libri: DellÆeducazione,
Del governo delle cittÓ, Della natura.
Ma questo della natura non Ķ
un ordine statico in quanto il cosmo Ķ animato, cioĶ dotato di movimento.
Questa semplice idea rende logicamente impossibile la concezione del mondo
propria degli Ionici la quale, a sentire Teofrasto (PR p. 138), fu anche
ripresa dallÆex pitagorico Ippaso (il quale sembra che abbia organizzato una
rivolta politica allÆinterno delle cittÓ rette dai Pitagorici): ōAnche Ippaso di Metaponto ed Eraclito di
Efeso dissero che lÆuno Ķ mosso e limitato, ma pensarono come fuoco il
principio, e dissero che dal fuoco nascono le cose per condensazione e per
rarefazione, e che in esso poi le cose si dissolvono, perchķ questa sola Ķ per
essi la natura che fa da sostrato.ö
Ma per capire come tale
assunzione sia in assoluto contrasto con le teorie pitagoriche bisognerÓ
seguire la linea consequenziale del pensiero degli Italici emergente dal poema Sulla Natura scritto da Parmenide (PR p.
271):
ōOrbene io ti dir“ e tu ascolta attentamente le mie parole,
quali vie di ricerca sono le sole pensabili:
lÆuna dice che Ķ e che non Ķ possibile che non sia,
Ķ il sentiero della Persuasione (giacchĶ questa tien dietro alla
VeritÓ);
lÆaltra dice che non Ķ e che non Ķ possibile che non sia,
questa io ti dichiaro che Ķ un sentiero del tutto inindagabile:
perchķ il non essere nķ lo puoi pensare (non Ķ infatti possibile),
nķ lo puoi esprimere.ö
Prima di riportare questi
versi Sesto Empirico premette: (PR p. 268) ōIl
suo [di Senofane] discepolo Parmenide condann“ il discorso di opinione, cioĶ
quello costituito di rappresentazioni non salde, e pose come criterio il
discorso scientifico, cioĶ quello che non pu“ essere rovesciato, rifiutando
ogni credibilitÓ alle sensazioni.ö E Simplicio (PR p. 269) dice: ōQuesti uomini posero una duplice ipostasi:
lÆuna ci“ che realmente Ķ, lÆintelligibile; lÆaltra ci“ che diviene, il
sensibile, che non credettero di chiamare essere assoluto, ma essere apparente.
Ragione per cui dicono che dellÆessere cÆĶ veritÓ di ci“ che diviene opinione.ö
Mettiamo le affermazioni di
Parmenide in simboli: Nella via della Persuasione e della VeritÓ (oggi diremmo
della Logica) se asseriamo ō $aö dobbiamo
asserire necessariamente ōa ╣ ┘ö ; e non possiamo asserire ō
~$aö e
nello stesso tempo ōa ╣ ┘ö.
Se, dÆaltra parte, astraiamo
da qualsiasi proprietÓ ōaö, come in
seguito penserÓ di poter fare Aristotele introducendo il suo multiforme e
perci“ ambiguo concetto di ούσία
, ci ridurremmo alla ōproprietÓ
banaleö posseduta da tutte le cose e alla sua complementare, la ōproprietÓ assurdaö che nessuna cosa
(nemmeno puramente ideale) pu“ possedere, come si Ķ visto nelle sezioni
precedenti.
Ed infatti il poema
parmenideo continua:
ōBisogna che il dire e il pensare sia lÆessere: Ķ dato infatti essere,
mentre nulla non Ķ; che Ķ quanto ti ho costretto ad ammettere.
Da questa prima via di ricerca infatti ti allontano,
eppoi inoltre da quella per la quale mortali che nulla sanno
vanno errando, gente dalla doppia testa. PerchĶ Ķ lÆincapacitÓ che nel
loro
petto dirige lÆerrante mente; ed essi vengono trascinati
insieme sordi e ciechi, istupiditi, gente che non sa decidersi,
da cui lÆessere e il non essere sono ritenuti identici
e non identici, per cui di tutte le cose reversibile Ķ il cammino.ö
Quindi per Parmenide la
descrizione (ōil dire e il pensareö) della
realtÓ coincide con la realtÓ stessa (ōlÆessereö);
il resto Ķ ōnullaö; cioĶ,
1Æingannevole effetto di sensazioni informi (prive di alcuna individuabile
proprietÓ):
ōMa tu da questa via di ricerca allontana il pensiero
nķ lÆabitudine nata dalle molteplici esperienze ti costringa lungo
questa via,
a usar lÆocchio che non vede e lÆudito che rimbomba di suoni illusori
e la lingua, ma giudica col raziocinio la pugnace disamina che io ti
espongo. ...ö
LÆessere, in quanto tale, Ķ
un ente della logica, cioĶ del nostro modo di esprimerci e pertanto non ha
senso dire che ha unÆorigine o una fine; esso
ōEssendo ingenerato ķ anche imperituro,
Ātutto intero, unico, immobile
senza fine.
Non mai era nķ sarÓ, perchķ Ķ ora tuttÆinsieme,
Āuno, continuo. Difatti quale
origine gli vuoi cercare?
Come e donde il suo nascere? Dal non essere non ti permetter“ nķ
di dirlo nķ di pensarlo. Infatti non si pu“ nķ dire nķ pensare
ci“ che non Ķ. E quandÆanche, quale necessitÓ pu“ avere spinto
lui, che comincia dal nulla, a nascere dopo o prima?
Di modo che Ķ necessario o che sia del tutto o che non sia per nulla.
Giammai poi la forza della convinzione verace concederÓ che dallÆessere
alcunchķ altro da lui nasca. Perci“ nķ nascere
nķ perire gli ha permesso la giustizia disciogliendo i leganmi,
ma lo tien fermo. La cosa va giudicata in questi termini;
Ķ o non Ķ. Si Ķ giudicato dunque, come di necessitÓ,
di lasciare andare lÆuna delle due vie
come impensabile e inesprimibile (infatti non Ķ la via vera)
e che lÆaltra invece esiste ed Ķ la via reale.
LÆessere come potrebbe esistere nel futuro?
In che modo mai sarebbe venuto allÆesistenza?
Se fosse venuto allÆesistenza non Ķ e neppure se Ķ per essere nel
futuro.
In tal modo il nascere Ķ spento e non cÆĶ traccia del perire.
Neppure Ķ divisibile, perchĶ Ķ tutto quanto uguale.
Nķ vi Ķ in alcuna parte un pi∙ di essere che possa impedirne la
contiguitÓ,
nķ un di meno, ma Ķ tutto pieno di essere.
Per cui Ķ tutto contiguo: difatti lÆessere Ķ a contatto con lÆessere.ö
Ne consegue che parlare di
un principio materiale, unico, limitato ed in continuo movimento, con
condensazioni e rarefazioni, come fanno Eraclito ed il Pitagorista Ippaso (i
fisici, oggi, chiamerebbero la concezione del mondo di costoro una Teoria di Campo) Ķ unÆassurditÓ, perchĶ
lÆessere se Ķ essere non pu“ che essere limitato, immobile, omogeneo, isotropo
e senza tempo. Tali proprietÓ si possono solo attribuire ad un insieme di punti
indifferenziato; solo quando ne considerassimo anche la proprietÓ della
estensione fisica diventerebbe lo spazio assoluto di Newton, che poi Ķ lo
spazio come modellato dalla geometria.
Infatti lÆessere Ķ
ō... immobile ... senza conoscere nķ principio nķ fine ...
E rimanendo identico nellÆidentico stato,
sta in sķ stesso ...ö.
In quanto lÆessere Ķ un
costrutto logico non ha senso il dire che Ķ illimitato, altrimenti sarebbe ōincompiutoö e ōmanchevoleö; la qual cosa Ķ impossibile perchķ non esistono punti
che non siano punti dellÆessere: ō... infatti la dominatrice NecessitÓ lo tiene nelle strettoie del linmite
che tutto intorno lo cinge ...ö.
Per introdurre il concetto di spazio illimitato abbiamo bisogno di introdurre altre proŁprietÓ oltre a quella primordiale di essere, come giÓ detto.
Senza di queste
ōsaranno tutte soltanto parole ... nascere e perire, essere e non essere, cambiamento di luogo e mutazione del
brillante colore.ö
InĀ assenza di altre proprietÓ non cÆĶ niente che possa cambiare nella sola proprietÓ di essere. E lÆessere
ōĶ compiuto da ogni lato, simile alla massa di ben rotonda sfera ... che egli infatti non sia nķ un p“ pi∙ grande nķ un p“ pi∙
debole qui o lÓ Ķ necessario ... nķ
cÆĶ la possibilitÓ che lÆessere sia
dellÆessere qui pi∙, lÓ meno, perchķ Ķ
del tutto inviolabile.ö.
A questo punto siamo costretti a osservare che se identifichiamo lÆessere con la materia, esso non potrebbe muoversi senza vuoti frapposti, ma allora lÆessere sarebbe e nello stesso tempo non sarebbe; sarebbe uno e, nello stesso tempo, molti. Ma ci“ Ķ contro la logica.
Aristotele crede di superare
la ferrea logica di Parmemmide opponendo che lÆessere si dice in molti sensi.
Ed Ķ vero! Ma Ķ proprio questo che Parmenide vuole superare! cioĶ lÆambiguitÓ
ed i molteplici sensi delle parole della lingua comune, legata al sensibile e
non adatta per un discorso veramente scientifico.
Ma come, a partire dalla
logica di Parmenide, possiamo spiegare lÆapparenza dei sensi?
ōCon ci“ interrompo il mio discorso degno di fede e i miei pensieri
intorno alla veritÓ; da questo punto le opinioni dei mortali impara
a conoscere, ascoltando lÆingannevole andamento delle mie parole.
PerchĶ i mortali furono del parere di nominare due forme,
una delle quali non dovevano Ś e in questo sommo andati errati Ś;
ne contrapposero gli aspetti e vi applicarono note
reciprocamente distinte: da un lato il fuoco etereo
che Ķ dolce e leggerissimo, del tutto identico a se stesso,
ma non identico allÆaltro, e inoltre anche lÆaltro [lo posero] per sķ
con caratteristiche opposte, [come] notte senza luce, di aspetto denso
e pesante.
QuestÆordinamento cosmico, apparente come esso Ķ, io te lo espongo
compiutamente,
cosicchĶ non mai assolutamente qualche opinione dei mortali potrÓ
superarti.ö
A partire da questo punto,
solo pochi sconnessi frammenti ci rimangono della titanica opera parmenidea.
Non ci resta che continuare con la sua ferrea logica.
Per spiegare il mondo dei
sensi, quindi, dobbiamo introdurre altre proprietÓ
che non possono essere di natura logica come quella dellÆessere. In
contrapposto al logico, porremo il materiale.
Allora, tra i punti
dellÆessere ci saranno i punti materiali e
quelli non-materiali cioĶ i punti
dello spazio vuoto di materia; cioĶ,
il ōvuotoö, il quale ōesisteö alla stessa stregua della
materia. Perchķ sia i punti materiali che i punti privi di materia sono punti
dello spazio fisico che coinciderÓ
con lÆessere se gli individui del
nostro campo di ricerca sono solo
essi.
ōQueste cose, benchķ lontane, vedile col pensiero saldamente presenti:
non infatti distaccherai lÆessere dalla sua connessione con lÆessere
nķ quando sia disgregato in ogni senso completamente con cura sistematica
nķ quando sia ricomposto.ö
Si intende nella sua reale
unitÓ di essere pensato; anche se prima o dopo lo possiamo ripensare ōcompletamente disgregatoö come
costituito di punti materiali che si muovono nello spazio geometrico. E questo
Ķ quello che concretamente ha fatto Archimede (vedi rifer. di cui a nota20).
Si pu“ concludere che per
Parmenide una Teoria di Campo Ķ logicamente autoconŁtraddittoria ed Ķ solo
possibile una Teoria di Particelle come sarÓ succesivamente precisata da
Leucippo e Democrito, i quali secondo Diogene Laerzio seguono, appunto, la
tradizione italica.
Ma prima di passare a questi
ultimi giganti, Ķ bene seguire le conseguenze della critica parmenidea alle
concezioni dei fisici dellÆopposta scuola di pensiero, come formalizzate dal
suo discepolo Zenone.
Atomi e vuoto.
Notiamo intanto che, con
lÆimpostazione che abbiamo esposto, cade qualunque divieto per lÆuso della
matematica nella descrizione fisica della realtÓ, sia di tipo aristotelico che,
come abbiamo visto, relega la matematica allo studio di enti privi di materia e
privi di movimento; sia alla proibizione misticheggiante di tipo platonico.28
Anzi, per capire la realtÓ
fisica, in quanto sintesi di materia e movimento, dobbiamo indagare a fondo
sugli enti matematici, che per gli Italici, non sono avulsi dalla realtÓ ma
semplicemente astratti dalle impressioni sensoriali e che, anzi, costituiscono,
ormai, la realtÓ stessa. Per essi non avrebbe alcun senso una matematica chiusa
su se stessa che non si curi di sapere di quali enti concreti si occupi.
Per loro non cÆĶ differenza
tra geometria e fisica. E non Ķ vero che per essi gli asŁsiomi della geometria
siano autoevidenti di per sķ, come la maggior parte dei commentatori moderni
asserisce, attribuendo ai ōGreciö il
modo di ragionare di Aristotele, ma sono semŁplicemente quelli che meglio si
adattano a fungere da mattoni per il sistema deduttivo. Per esempio, non serve,
in questa logica, negare lÆassioma delle parallele per lo spazio fisico, perchķ
la sua asserzione Ķ compatibile con tutte le osservazioni empiriche.
Diogene Laerzio attribuisce
a Zenone la dottrina che ōEsiste un solo
mondo e il vuoto non esisteö; ma molto
probabilmente, nella distorsioime postaristotelica, Diogene confonde il mondo
con lÆessere, cioĶ con la proprietÓ
banale (mentre per Zenone il mondo Ķ lÆessere materiale) e il vuoto con la
privazione di essere, cioĶ con la proprietÓ
assurda (mentre per Zenone il vuoto Ķ lÆessere privo di materia).