La Scienza e la Fede
Salvatore Notarrigo
Alle lezioni di catechismo,
che regolarmente frequentai alla giusta età, avevo imparato che ad ogni bambino
vengono assegnati, anche se invisibili, un angioletto e un diavoletto. L’uno tira
il bambino verso il bene e l’altro, manco a dirlo, verso il male.
Non mi fu detto se tali
esseri fossero presenti anche nell’età adulta. Naturalmente, allora, non mi
son posto questo problema e, dal momento che non li ho mai visti, come San
Tommaso, ho finito per non crederci più.
Ma ora, dopo tanti anni, mi
è capitato di incontrare il mio diavolo. L’angelo, sfortunatamente, non l’ho
ancora visto, però l’ha visto un inventore di cui vi dirò alla fine.
I1 diavolo mi si è
presentato sotto le spoglie di Giuseppe Boscarino, il quale, con la sua
passione per la filosofia della matematica, mi poneva difficili questioni sul
concetto di numero, cercando di capire i moltissimi e non facili discorsi che
Aristotele dedicò all’argomento.
Fin dalle elementari non avevo
mai incontrato grossi problemi con la matematica, almeno per quella che
normalmente si richiede ad uno studente, anche universitario; si trattava,
quasi sempre, di risolvere ben determinati problemi, che come venivano posti mi
parevano di una facilità estrema e non riuscivo a capire le difficoltà che
incontravano molti compagni di scuola e colleghi di università.
Più tardi ho opinato che le
difficoltà di costoro erano da connettere col fatto che essi si ostinavano a
faticare per cercare di memorizzare il libro di testo, forse per quell’assurdo
criterio pedagogico che, fin dalle scuole elementari, costringe i bambini a
mandare a memoria delle poesie di cui non sempre ne è chiaro il senso; ma i
significati, come è noto, a scuola contano poco, contano solo le parole,
specialmente se sono belle, naturalmente, secondo il giudizio dei critici
letterari — invece di limitarsi a intendere i significati delle definizioni a
mezzo di opportuni modelli concreti, i quali, spesso, venivano forniti dal
libro stesso e, altre volte, erano i nomi stessi a suggerirlo; del resto, anche
il droghiere riesce a maneggiare pesi e misure, valutandone i reciproci
rapporti di scambio senza, possibilmente, avere avuto necessità di andare a
scuola o, il più spesso delle volte, avendo già dimenticato tutto quello che a
suo tempo era riuscito a memorizzare al solo scopo di far contenta la maestra e
i genitori.
Le definizioni e le ovvie
regole del calcolo simbolico sono risultate, per lo più, sufficienti anche
nella mia esperienza di ricercatore di fisica; finché non mi son messo in testa
di capire i dettagli matematici delle teorie moderne della fisica, fondate
sulle strutture della meccanica quantistica e della meccanica relativistica. Ma
dopo un po’ ho capito che le mie difficoltà non dipendevano dalla matematica,
ma dalla filosofia associata a tali teorie; per cui, ancora una volta, mi sono
disinteressato dei problemi filosofici connessi con le teorie matematiche, in
quanto tali, cioè astraendo dai loro possibili significati fisici.
Nei miei studi universitari,
per sostenere gli esami ho dovuto, ovviamente, leggere il libro di testo, che
era stato scritto dal titolare della cattedra del mio corso (per la cronaca
dirò che il professore si chiamava Pia Nalli; ancora oggi giudico il suo libro
un capolavoro!), e non ho avuto traumi, in quanto la filosofia, che vi intravedevo
(anche se non esplicitamente espressa), non era in contrasto con il concetto
che mi ero fatto della matematica, cioè di strumento essenziale per lo studio
di problemi concreti (nel mio caso di fisica, principalmente).
Nel corso degli anni mi è
capitato di leggere dei libri sulla filosofia della matematica; mi sono sempre
risultati incomprensibili. Non essendo in grado di decidere se erano problemi
seri o semplici giuochi di parole senza significato, mi riservavo, trovando il
tempo, di studiare in seguito e più attentamente la cosa; ma, in ogni caso,
giudicavo che i problemi, che in tali libri venivano sollevati, non dovevano
essere molto rilevanti; infatti, non mi era mai capitato di imbattermi in tali
sottili questioni, almeno nell’uso concreto che mi era capitato di fare della
matematica.
In genere, nemmeno i
matematici, con i quali mi capitava di chiacchierare su tali questioni,
mostravano forti interessi sulla filosofia della loro scienza e, per quei pochi
che ne parlavano, sembravami che avessero ricavato le loro idee, almeno quelle
espresse, non già dal loro lavoro concreto ma dalle parole dei filosofi della
matematica, i quali ultimi, con altissima probabilità, così almeno io
giudicavo, non avevano mai fatto della matematica e tanto meno mi pareva che
l’avessero mai applicata a un qualche caso concreto.
Strana situazione questa, mi
dicevo, che i matematici debbano apprendere la filosofia della matematica da
coloro che, spesso, non sanno che cosa la matematica sia. Ma oggi non capita
solo ai matematici questo fatto singolare. Nè i fisici vi fanno eccezione.
C’è chi dice che la colpa
sia da imputare alla soverchia specializzazione.
Ricordo un aforisma di
Bernard Show che diceva che lo specialista è colui che sa tutto su nulla; ma,
naturalmente, non è meno grave il sapere nulla su tutto.
Ad ogni modo, ho sempre
pensato che anche l’imperativo della specializzazione deve pur avere la sua
causa.
Ma ora sto cominciando a
parlare come il diavolo! Mi piace dare la colpa a quel diavolo di cui vi ho
parlato sopra; che, magari inconsapevolmente, mi ha spinto a riflettere sugli
ardui problemi che prima avevo sempre rinviato.
Finalmente ho capito che
tali astratti problemi di filosofia della matematica hanno un immensa rilevanza
sulle teorie moderne della fisica; e non solo della fisica.
Ma andiamo con ordine.
Cosa sono i numeri?
Come si legge nell’articolo
di Boscarino, in questo stesso numero di Mondotre, il problema è antico e
sembra ancora non risolto.
Nascono i numeri dalle
operazioni fisiche che compiamo per misurare una grandezza? O, non piuttosto,
è il concetto di grandezza che sgorga dalle operazioni mentali che compiamo con
i numeri? O, ancora, non potrebbe darsi che le due cose siano assolutamente
separate, essendovi tra loro una semplice e casuale analogia formale?
Certo, dopo Cantor,
l’analogia non può essere completa; noi mai possiamo operare fisicamente con
grandezze transfinite; e dopo Robinson ancora peggio, visto che nessuno
potrebbe mai operare concretamente con un infinitesimo attuale.
Non credo che a tali domande
si possa dare una risposta definitiva se, preliminarmente, non si siano
enunciati molto chiaramente gli assunti metafisici da cui si vuole partire.
Tuttavia si può, andando a
ritroso, tentare di capire da quali assunti metafisici siano implicate le
eventuali risposte alle dette domande e quali conseguenze logiche, a loro
volta, implichino tali risposte.
Poi, ovviamente, ognuno sarà
libero di scegliersi la propria metafisica, che più si concili con le personali
esigenze; e sarà libero, anche, di scegliere sistemi metafisici
autocontradittori; tanto i filosofi moderni della matematica, altrimenti
chiamati metamatematici, hanno concluso che non è possibile dimostrare
l’autocontraddittorietà di un sistema deduttivo.
È da lunga pezza che son
finiti i bei tempi di Euclide e di Archimede! Oggi sono i tempi delle
convergenze parallele. Alcuni hanno riso di questa frase pronunciata da un
illustre uomo politico tragicamente scomparso, ma costoro, certamente, non
avevano sentito parlare dell’esistenza delle geometrie non eucidee!
Fin da tempi preistorici gli
uomini hanno misurato lunghezze, masse, aree, volumi, durate temporali, ecc.,
per cui è altamente probabile che i primi termini matematici coniati siano
stati quelli corrispondenti ai concetti di “doppio”
e di “metà” e quindi quelli più
generali di “multiplo” e di “divisore”.
Con l’intensificarsi degli
scambi dei prodotti del lavoro è probabile che abbiano sentito il bisogno di
una qualche “unità di misura”, comune
ad ogni singola specie di grandezza, con la quale erano soliti stimare le
quantità dei beni prodotti; questo, appunto, può far nascere l’esigenza del termine
collettivo “grandezza” e del concetto
più specifico di “grandezze omogenee”, riferito
alla sottoclasse delle grandezze direttamente confrontabili tra loro.
Le operazioni fisiche di
confronto diretto tra una grandezza e l’unità ad essa omogenea sono certamente
diverse, per le diverse grandezze; ma tutte hanno in comune qualcosa; e non
certo perché tale qualcosa è immanente alle proprietà misurate, ma
semplicemente perché, avendo misurato con successo una grandezza, supponiamo la
lunghezza, si è cercato sempre di usare un metodo il più strettamente simile al
primo, anche per le altre grandezze; anzi, nonostante lo sviluppo attuale degli
strumenti di misura e della metrologia stessa, ancora oggi, si tenta sempre,
non solo nei modelli teorici della teoria delle misurazioni ma anche nella
realizzazione pratica degli strumenti di misura, di ricondurre ogni misurazione
di una qualsiasi grandezza a una misura di lunghezza, come, p. es., lo
spostamento di un indice su di una scala graduata. Solo negli ultimissimi
tempi, con la diffusione dei calcolatori automatici digitali, si vanno
sostituendo le scale graduate (compreso il quadrante dell’orologio da polso)
con una rappresentazione visiva delle cifre arabiche in un opportuno quadro di
lettura (display).
Sia con l’antica
rappresentazione analogiea, effettuata mediante le scale graduate, sia, e a
maggior ragione, con la rappresentazione digitale moderna, l’atto di misura di
una qualsiasi grandezza viene ricondotto all’operazione di conteggio dei gradi
della scala, che anche si possono leggere direttamente, senza bisogno di
contarli, quando si sia provvista la scala graduata con delle cifre che ne
riassumano il conteggio, il quale è stato già fatto, una volta per tutte, dal
costruttore dello strumento con una più o meno alta approssimazione numerica;
questa operazione, di riassunto e approssimazione, viene fatta automaticamente
sulla mostra delle cifre nei dispositivi digitali di lettura (display).
Nell’uno, e ancor più
nell’altro metodo di lettura, a lungo andare e con l’abitudine, si viene a
perdere l’idea di grandezza come un continuo, il quale potrebbe, almeno in
teoria, far assumere all’indice della scala una qualunque posizione, anche
intermedia tra i gradi segnati, comunque fitta sia la graduazione stessa; e
così, il numero viene ad assumere un esistenza propria, quasi come un
personaggio pirandelliano che risulta essere più reale del carattere che vuole
rappresentare; e viene anche l’idea che, se potessimo infittire a volontà la
graduazione della scala (o, equivalentemente, il ntunero delle cifre nel
display dei dispositivi digitali di lettura), potremmo far coincidere qualunque
grandezza con un qualche segno della graduazione.
E ciò infatti, in pratica,
si verifica sempre; ma solo perché non siamo in grado di distinguere due segni
quando vengano a trovarsi sufficientemente vicini tra loro.
Ma già i pitagorici sapevano
che ciò è, in generale, impossibile con esattezza assoluta; infatti,
dimostravano che il lato e la diagonale di un quadrato sono “incommensurabili” in questo preciso
senso, cioè: non possono esistere sulla scala due segni, che coincidano
esattamente con gli estremi superiori delle due lunghezze, comunque si
infittisca la graduazione; anche oltre il limite imposto dallo spessore, non
mai nullo, del segno stesso e anche oltre i limiti impostici dal potere
risolutivo finito del nostro occhio, pur provvisto di un potentissimo
microscopio.
A un certo punto della
storia del pensiero astratto il processo di “contare”
viene ad apparire, quindi, come concettualmente antecedente a quello del “misurare”.
Il problema di sapere se,
storicamente e concretamente, gli uomini abbiano imparato prima a contare e
poi a misurare o viceversa, mi sembra un problema di inutile speculazione
metafisica (nel significato deteriore del termine), anche se, dal punto di
vista della “logica”, i due concetti,
in quanto entità astratte, necessariamente, devono nascere insieme; e ciò
proprio a causa della scoperta, di ordine logico, dovuta agli stessi
pitagorici, secondo i quali, ogni qual volta si viene a formare un concetto,
con lo stesso atto del pensiero, si forma contemporaneamente il suo contrario.
Non può esistere, logicamente, il “continuo”
senza il concetto di “discreto” e
viceversa; nè tanto meno può esistere l’analogico senza il digitale e
viceversa. E non ha alcun senso logico il tentare di costruire l’uno per mezzo
dell’altro o viceversa.
Ma, in ogni caso, la
questione sembra irrilevante per la scienza. Quello che conta è il sapere quale
dei due concetti conviene prendere come mattone per costruire un sistema
deduttivo, cioè quale usare come “termine
primitivo”.
Gli antichi avevano deciso
per il continuo e cioè per le grandezze.
I1 modello di grandezza di
Euclide è un segmento di retta (che egli chiama “retta”, tout court, perché,
probabilmente, gli sarebbe sembrato inconcepibile pensare a una retta
indefinita, cioè senza limiti, o estremi che dir si voglia, anche se ogni “retta” può essere prolungata
indefinitamente, senza con ciò cessare, ad ogni prolungamento, di restare
limitata; quindi, per Euclide, è l’operazione del “prolungare” che può essere ripetuta indefinitamente e giammai,
invece, la “retta” potrebbe essere
infinita).
In tale segmento di retta si
possono “segnare” dei punti in
corrispondenza di ogni singola grandezza concreta, cioè individuale. Non a caso
il punto, per Euclide, e anche secondo tutta la tradizione pitagorica, è σημεĩον, cioè “segno”.
Avendo segnato sulla retta
dei punti equidistanti, la misura si riduce a un conteggio di segni. Tale conteggio
può solo fornire un numero intero (un numero decimale è semplicemente un numero
intero camuffato, cioè una particolare rappresentazione di un intero, quando si
sia convenuto di usare la stessa unità di misura per tutte le singole grandezze
della stessa specie, sia maggiori che minori dell’unità stessa).
Noi possiamo esprimere il
risultato di una misura solo mediante un numero intero (possibilmente anche
camuffato da razionale); ma un numero intero non esaurisce la totalità dei
possibili confronti tra una qualsiasi grandezza e la sua unità, il confronto
tra diagonale e lato del quadrato lo dimostra. Il rapporto tra grandezze (λόγος) è un concetto più generale di quello
di numero, in quanto quest’ultimo rappresenta solo l’informazione,
necessariamente approssimata, che possiamo “nominare”.
Ma il fatto che non possiamo
nominare, per mezzo di una sequenza di cifre, un rapporto tra grandezze (come
per esempio il rapporto tra la circonferenza e il suo raggio) non significa che
non ne possiamo ragionare. Casualmente (o forse no!) il termine della lingua
greca che esprime il concetto di “rapporto”
è omonimo del termine che esprime il concetto di “ragione”.
E, perciò, risulta possibile
ad Archimede inventare un sistema di numerazione che possa approssimare, con arbitraria
(ma non infinita) precisione, un qualunque rapporto e, in particolare, quello
che oggi indichiamo con il simbolo π ; o contare il numero dei
granelli di sabbia che avrebbero potuto essere contenuti in un volume pari
all’intero universo eliocentrico di Aristarco, ben noto allo stesso Archimede.
Con Dedekind, come leggiamo
nell’articolo di Boscarino, vengono abolite le grandezze in favore dei numeri,
e così nasce il falso problema di costruire il continuo mediante il discreto,
risolto (a parole) con il “postulare
l’esistenza” di un limite per ogni successione di razionali che costituisca
una “sezione”; limite che, però,
necessariamente, non sempre può far parte dei razionali, ammesso che questi
ultimi possano avere un’“esistenza” propria
in un qualche mondo iperuraneo. Con ciò i nomi ed i simboli diventano più
importanti dei loro significati. Questo giustificherebbe il criterio pedagogico
a cui abbiamo sopra accennato.
E, così, nei moderni libri
di divulgazione della matematica si asserisce, con grande sicumera, che Euclide
ed Archimede furono certamente dei grandi matematici, ma ... non seppero
inventare i numeri reali! A sentire tali parole, i due grandi “scienziati” del
nostro passato (e non semplicemente “matematici” o “geometri” o “fisici” o “ingegneri”,
come spesso, facendo loro torto, vengono chiamati; infatti i due si sono
entrambi occupati di tutte queste materie e non sarebbero stati in grado
nemmeno di capire la distinzione!) si sarebbero messi a ridere dicendo: “Meno male! se l’avessimo fatto saremmo
stati legittimati a sommare
assieme un indice di rifrazione e un angolo poiché entrambi verrebbero ad
essere numeri e i numeri, per definizione, si possono sommare. Ma noi non
vogliamo sommarli perché non vogliamo commettere inutili sciocchezze! Per cui
ci limitiamo a sommare solo le
grandezze fisiche e giammai i loro rapporti”.
Ma che significa “esistere”?
Facilissimo! “esistere” significa “essere”. Sì d’accordo, ma che significa
“essere”? Quando avremo
esaurito i possibili sinonimi elencati nel dizionario ci ritroveremo ancora al
punto di partenza.
Sembra ovvio che non si può
definire tutto; anzi, per essere precisi, non si può definire niente, se con
“definire” si voglia intendere l’acquistare il “significato” di un termine mediante il significato di altri
termini, perché questo comporta un regresso all’infinito, come nel caso del
termine “esistere” o, ancora peggio, per il significato di “significato”.
In logica e in matematica si
danno delle definizioni, ma queste sono puramente “nominali”, cioè sono semplici convenzioni sul come operare con
determinati nomi. Né con la logica, nè con la matematica, si possono acquistare
“significati”; questi possono solo
derivare dalle concrete operazioni che facciamo sulla realtà.
Nonostante ciò i filosofi
della matematica si sono sempre sforzati di definire il numero; ma,
naturalmente, la sola cosa che possono riuscire a fare è quella di descrivere,
con parole più o meno proprie e più o meno significanti, il loro personale concetto,
al quale sono portati a pensare quando odono la parola “numero”; concetto che loro deriva dalle
personali esperienze, necessariamente sempre limitate, e che ardiscono,
arbitrariamente, estendere urbi et orbi, fino a sistemarlo nel mondo iperuraneo,
come già aveva fatto Platone.
Dopo Russell, il quale si è
sforzato di mettere assieme le illusioni di Dedekind e di Cantor con
l’ideografia di Peano, avendo il primo riconosciuto pubblicamente la lezione di
quest’ultimo, in base alla quale non si può parlare di scienza senza un
linguaggio adeguato e non ambiguo, si tenta di definire il numero,
nominalmente, a partire dalla nozione di classe, ritenuta logicamente
antecedente (sembra di essere tornati con questo linguaggio poco significante
ad Aristotele!). La conclusione sarà che il numero è la classe di tutte le
classi, che hanno lo stesso numero di elementi. Nel suo significato, tale
definizione è patentemente circolare, anche se si può, con difficoltà e con
qualche sotterfugio, metterla in simboli senza, apparentemente, ripetere due
volte lo stesso simbolo, una prima volta, nel nome che si vuole definire e, una
seconda volta, nella definizione stessa.
Mi sono dimenticato che
stavamo parlando del termine “esistere”; ma
la parentesi che abbiamo aperto non sarà inutile per meditare su alcuni
possibili suoi significati.
Noi usiamo, spesso, il
termine “esistere” per dire che,
secondo la nostra opinione, qualcosa esiste nello spazio e nel tempo. In questo
senso diciamo che esiste la terra ed esiste la luna. La terra la tocchiamo, la
luna la vediamo e, oggi, sappiamo che qualche astronauta l’ha anche toccata.
Ma, certamente, la terra che tocchiamo e la luna che vediamo non hanno forma
sferica, al massimo la luna ha forma circolare piana, ma non sempre, qualche
volta è falciforme.
Certamente non è questo il
senso con cui la gente pensa che esistano i numeri.
Esistono forse allo stesso
modo dei nostri sogni notturni o delle nostre fantasie diurne?
Nemmeno questo va bene!
Esistono come il fatidico
uomo delle nevi o come la Cina di Marco Polo? Cioè, per sentito dire. No
certamente!
Esistono come Dio o come gli
angeli del paradiso in un mondo diverso dal nostro! cioè per fede. No! E
allora?
Secondo me esistono in senso
“logico”; come astrazione
coerente dalle nostre operazioni fisiche concrete.
L’esistenza logica si può provare quando prima si siano introdotti dei simboli, si siano stabilite, convenzionalmente, le operazioni che possiamo fare con essi, e si sia riusciti a dimostrare che, nel nostro sistema deduttivo, l’esistenza di un qualche ente, definito nominalmente con i detti simboli, non risulti contraddittoria, in base alle convenzioni logico-linguistiche che abbiamo stabilito.
Possiamo dimostrare la non
contraddittorietà del nostro sistema deduttivo? Certamente no! Questo lo
sapevano, senza alcun dubbio, Euclide ed Archimede, e, probabilmente, anche i
matematici Sumeri, e nessuno sentiva il bisogno del teorema di Gödel per
saperlo, ammesso che tale teorema significhi qualcosa!
Noi possiamo, solamente,
accertare empiricamente che i nostri assiomi e le nostre regole deduttive sono
in accordo con qualche sistema concreto e funzionante.
Solo allora, l’esistenza
logica, in qualche modo, diventa anche esistenza fisica; non nel senso di
esistenza nello spazio e nel tempo o in qualche altro possibile mondo, ma nel
senso che i nostri oggetti matematici corrispondono a precise e ripetibili
operazioni fisiche, che possiamo effettivamente compiere sulla realtà e non
solo sui simboli, i quali ultimi sono solo le larve delle cose. E queste ultime
sono “cose” non perché le
tocchiamo e le vediamo, ma perché le abbiamo ricostruito razionalmente nella
nostra mente. Nessuno dubita oggi che la terra di forma quasi sferica che ruota
intorno al sole sia più reale della terra che possiamo toccare e vedere. Ecco
il significato del termine “scientifico”.
Scientifico non è il dato di
fatto, ma è scientifica la spiegazione razionale del dato di fatto.
Ecco come, secondo me,
esistono i numeri. Secondo questa definizione di esistenza, né i numeri di
Dedekind, né a maggior ragione i numeri transfiniti di Cantor o quelli “non
standard” di Robinson, possono esistere. E non solo perché non vi è nessuna
operazione fisica che loro corrisponda ma perché (e proprio per la precedente
ragione) non si può provare la loro coerenza sintattica, checché ne possano
pensare i metamatematici.
I numeri di Euclide e di
Archimede, invece, esistono perché si può verificarne, e lo facciamo tutti i
giorni senza accorgercene, la loro conformità con le nostre più comuni
operazioni fisiche, anche quando seguiamo le involuzioni delle spire di fumo
della nostra sigaretta.
Pure gli animali, anche
degli ordini più bassi delle classificazioni zoologiche, mostrano di saper
contare e di saper stimare la misura di quelle grandezze che sono rilevanti per
la conservazione dell’individuo e della specie, come diversi studi specifici
hanno accertato.
Ci si potrebbe porre il
problema di sapere qual è il minimo numero di termini che dobbiamo assumere come
primitivi (oltre i termini della logica) e, quindi, non nominalmente definiti,
per costruire l’intero sistema assiomatico relativo alle grandezze fisiche e ai
loro rapporti (cioè quelli che oggi si chiamano numeri reali).
Si può dimostrare che basta
un solo termine; e cioè quello di “equivalenza” in grandezza di due segmenti;
il significato di tale termine viene “astratto”
dalle nostre operazioni di “trasporto
rigido” di un regolo fisico, che può essere un’asta di ferro o di legno o
di plastica o di qualunque altro materiale, che noi giudichiamo come
approssimativamente “rigido”.
Non è opportuno darne qui la
dimostrazione, tanto più che la cosa è irrilevante per qualunque altra scienza,
che non sia la filosofia della matematica.
Invece è molto più interessante
considerare le conseguenze del concetto di numero astratto come emerso,
attraverso posteriori riaggiustamenti, dalle idee dei vari Dedekind, Cantor,
Russell e consoci metamatematici, sul piano della fisica e, perché no, anche
dell’analisi economica.
Riprendiamo, per un momento,
il concetto di asta rigida e seguiamo, per riassunto, il più fedele che ci
riuscirà possibile, un dialogo tra un relativista convinto, un fisico
sperimentale e un matematico puro (il dialogo fu scritto nel 1920)1.
I1 dialogo si svolge,
pressappoco, in questi termini: Il relativista chiede se ci siano ragioni,
oggi, per ritenere vera la proposizione di Euclide, secondo la quale la somma
di due lati di un triangolo è sempre maggiore del terzo lato.
I1 matematico si limita a
dire che la verità della proposizione dipende dalla verità degli assiomi, sui
quali non è competenza sua asserire alcunché.
I1 fisico si sorprende della
risposta del matematico, in quanto i matematici hanno sempre asserito che gli
assiomi della geometria sono autoevidenti. Ma il matematico gli risponde che,
modernamente, non si pensa piu così.
Il fisico incalza: se il
sistema è coerente non è evidente che la proposizione è vera? Ma il matematico
dice che ci possono essere diversi sistemi tutti internamenti coerenti. La
geometria di Lobačevskij ne è un esempio.
Tuttavia il fisico insiste
che, sperimentalmente, la geometria euclidea è vera. Ma il relativista non è
soddisfatto di tale affermazione e invita il fisico a descrivere
dettagliatamente le operazioni che deve compiere per verificare la proposizione
di Euclide di cui si stà discutendo.
Per il fisico la faccenda è
molto semplice, dice: prendo dei regoli graduati e li misuro! Ma il relativista
obietta: sembra che stiamo parlando di cose diverse, io sto parlando di
geometria e, quindi, di spazio! non della materia! I tuoi esperimenti provano
solo proposizioni intorno a quest’ultima.
Il fisico: ma io posso usare
strumenti ottici.
Il relativista: peggio di
peggio, ora tu parli delle proprietà della luce!
Il fisico: ora non capisco
più di che cosa stai parlando se non mi permetti di fare alcuna misura! È il
solo strumento a mia disposizione per sapere qualcosa sulla natura.
Il relativista misura i lati
di un triangolo con un metro avvolgibile e trova che la proposizione di Euclide
non è vera, e ne chiede il perché. Il fisico osserva che, quando il relativista
misurò il terzo lato, allungò troppo il metro. Ma questi ribatte con
sufficienza: perché non avrei dovuto farlo?
Risponde il fisico che egli
è obbligato a misurare con un asta rigida, se vuole essere sicuro del
risultato.
Ma cos’è un’asta rigida?
chiede il relativista. Se noi abbiamo definito una misura di lunghezza mediante
il confronto con un asta rigida come facciamo a verificare che l’asta di misura
è rigida? Ci vorrà un’altra asta rigida e così via all’infinito. Tu mi fai
ricordare, racconta il relativista, della storiella dell’orologio pubblico e
del cannone. L’incaricato del cannone sparava regolandosi con l’orologio e
l’incaricato dell’orologio, lo regolava con gli spari del cannone!
Ovviamente, continua il
relativista, lo “standard” di lunghezza non può cambiare se cambiamo il
materiale di cui è fatto!
A questo punto possiamo
interrompere il dialogo in quanto, se accettiamo gli argomenti del relativista
(ed io, personalmente, li accetto come logicamente incontrovertibili),
dobbiamo concludere, in modo assolutamente logico e razionale, che non potremo
mai accorgerci se l’unità di misura delle lunghezze (o, per questo argomento,
di qualunque altra grandezza) si allunghi o si accorci per effetto del
movimento, come nella teoria della relatività particolare, o di qualsiasi altra
causa, come, p. es., l’ipotetico incurvamento dello spazio per effetto di campi
gravitazionali, secondo la teoria della relatività generale di Einstein.
Ma, stranamente, il
relativista di Eddington, alla fine del dialogo, concluderà esattamente
all’opposto!
Questa conclusione, quando
la lessi la prima volta, mi fece ricordare di quella storiella secondo la quale
un giudice, il quale era soddisfattissimo delle lunghissime e molto pertinenti
argomentazioni che aveva, con grande fatica, trascritto nella sentenza, la
quale si concludeva con la frase di rito: “Per
questi motivi l’imputato viene condannato”.
Ma, come qualche volta
capita, motivi superiori, anche se estranei alla causa, hanno costretto il
giudice a cambiare opinione sulla sorte dell’imputato. Tuttavia le
argomentazioni della sentenza erano troppo belle e troppo ben connesse logicamente
per essere modificate minimamente, quindi il giudice decide, non si sa se a
malincuore, di modificare solo l’ultima parola: “Per questi motivi l’imputato viene assolto”.
Non diversamente fa il
nostro relativista, e lo stesso fanno Einstein ed Infeld, infatti essi
scrivono:2 “L’esempio di cui stiamo per servirci è ancora più fantastico di quello dell’ascensore in
caduta libera. Dobbiamo abbordare un nuovo
problema: quello della connessione fra
relatività generale e geometria. Cominceremo col descrivere un mondo nel quale abitano soltanto esseri bidimensionali e non più tridimensionali, come nel
nostro mondo. I film ci hanno abituato a vedere degli esseri bidimensionali
agire su schermi bidimensionali. Immaginiamo ora che quei fantasmi, vale a dire
gli attori sullo schermo, esistano realmente, che essi abbiano la facoltà di
pensare, che essi siano in grado di creare una scienza loro propria e che per
essi lo schermo bidimensionale rappresenti lo spazio geometrico. Tali esseri
sono incapaci di immaginare, in forma concreta, uno spazio a tre dimensioni,
così come noi siamo incapaci di immaginare uno spazio a quattro dimensioni.
Essi possono flettere e incurvare una linea retta, e sanno che cosa sia un
cerchio, ma sono incapaci di costruire una sfera, poiché per ciò fare
dovrebbero abbandonare il loro schermo a due dimensioni. In quanto a noi, siamo
bensì capaci di torcere e curvare linee e
superfici, ma non riusciamo a rappresentarci
uno spazio tridimensionale torto e incurvato.
Supponiamo che qualcuno dal di fuori, vale a dire dalla «terza dimensione», tolga
i nostri fantasmi dallo schermo e li trasferisca sulla superficie di una sfera
di raggio immenso. Se i fantasmi fossero molto piccoli rispetto a tale
superficie, se non disponessero di mezzi di comunicazione a
distanza e se non potessero allontanarsi molto, essi non potrebbero accorgersi
affatto del mutamento sopravvenuto. La somma degli angoli dei piccoli triangoli
sarebbe sempre eguale a due retti. Per due piccoli cerchi concentrici il
rapporto fra le circonferenze sarebbe sempre eguale a quello fra i raggi.
Viaggiando in linea retta essi non farebbero mai ritorno al punto di partenza.
Ma supponiamo ... che inventino dei mezzi di
comunicazione con i quali possano percorrere rapidamente distanze molto grandi.
In tal caso essi costaterebbero che
andando dritto
innanzi a loro, finirebbero per
tornare al loro punto di partenza… che il rapporto tra le circonferenze non è
eguale al rapporto fra i rispettivi raggi ... Essi cercherebbero probabilmente di imputare alla fisica le discrepanze
osservate ... Ma presto o tardi
scoprirebbero che c’è un modo molto più logico e convincente di spiegare i
fatti ... Essi finirebbero per
comprendere che malgrado la loro incampacità di rappresentarselo, il loro mondo
è bensì una superficie a due dimensioni, ma sferica.”
Ma per gli argomenti del
relativista di Eddington, anche se non per le sue conclusioni, gli esseri
bidimensionali di Einstein e Infeld non potranno mai accorgersi di essere in
uno spazio curvo, se il loro campione di lunghezza è immerso nello stesso
spazio ed eseguano misure per confronto diretto. Essi non cambieranno la loro
geometria ma chiameranno quadrati degli oggetti che gli esseri tridimensionali
chiameranno quadrilateri non equiangoli in una superficie curva. Il relativista
di Eddington, così come Einstein e Infeld, pensano che, per il fatto che
abbiamo chiamato qualcosa “lunghezza”, essa
sia perciò stesso una “grandezza” e
non una semplice “quantità numerica”, infatti nelle geometrie non-eudidee si chiamano lunghezze certe funzioni
numeriche degli angoli che, a loro volta, vengono definiti come semplici quantità
numeriche e non come grandezze, si chiamano aree altre funzioni degli angoli, e
così via. Le misure per confronto diretto non c’entrano per niente e non
vengono menzionate.
Quindi qualunque fisica che
si basi sugli spazi curvi non parla di grandezze fisiche, ma solo di numeri che
non si sa come “misurare”, anche se
si possono “determinare”, p.es.,
ponendo uguale a 1 l’angolo giro (definito come tutto il “piano” o, se si
preferisce, lo “spazio bidimensionale anche curvo” che circonda un punto) e ponendo,
per definizione, l’angolo retto uguale a 1/4. Certamente 1/4 rappresenta un
numero, ma altrettanto certo è che “tutto” il piano non è una grandezza.3
Ma, allora, cos’è lo
“spazio” e che sarà mai il “tempo”?
Non è peregrino leggere le
seguenti parole di Peano: “In quasi tutti
i trattati italiani moderni si introduce per primo il concetto di spazio,
dicendo che esso non si definisce, ma gli si attribuiscono le proprietà di
essere omogeneo, illimitato, infinito, divisibile, immobile, ecc., proprietà
queste parimenti non definite. Ritenendo pertanto il concetto di spazio come
fondamentale per la geometria, ne viene che non si potrebbe scrivere un
trattato di questa scienza in una lingua che per avventura manchi di tali
parole. Quindi non si potrebbe scrivere di Geometria nella lingua di Euclide e
di Archimede, ove appunto manca la parola corrispondente al termine spazio, nel
senso in cui lo si usa negli odierni trattati. In conseguenza una prima
notevole semplificazione si ottiene col sopprimere puramente e semplicemente il termine spazio,
gli aggettivi omogeneo, illimitato e tutti i postulati che legano quel soggetto
con questi attributi. Questa osservazione sulla inutilità del termine spazio,
in Geometria, riuscirà strana agli autori che incominciano il loro libro col
parlare dello spazio. Però l’esempio di Euclide e di tanti altri che non ne parlano affatto, è del tutto
convincente”.4
I “principi” organizzativi della geometria degli antichi erano il “punto” e la “distanza”.
Il primo veniva inteso come “segno”
(σημεĩον)
e, quindi, come “elemento”
(στοιχεĩον) (= lettera con la
quale comporre le altre parole). Dice Euclide che “il punto è ciò che non ha parti”, non nel senso che non ha estensione
fisica (cosa che eventualmente deve risultare dagli altri assiomi che sono
stati assunti in ogni specifico caso concreto) ma nel senso che non c’è
nient’altro che possa essere considerato come una parte di un singolo punto,
quindi: non sono le sue dimensioni fisiche che lo rendono “indivisibile” ma le sue proprietà logiche che lo fanno considerare
come “atomo” del reticolo
delle proprietà e, come diceva Democrito, potrebbe anche essere grande quanto
il mondo. Si dice spesso che con Euclide viene introdotta la “geometria della precisione”, intendendo con ciò la possibilità di parlare
di oggetti sensa dimensione fisica, ma questa, allora, sarebbe la geometria
della confusione. La precisione di Euclide è di natura logica (come per
Parmenide!) e il concetto di dimensione fisica è del tutto escluso dal concetto
di punto.
Nella lingua comune il
termine “punto” (come, del resto,
ogni altro termine) viene usato in modo ambiguo, sia per parlare del singolo
punto inteso come “individuo”, sia
per indicare il concetto di punto che invece si riferisce a tutti i punti e non
ad uno solo, cioè inteso come “proprietà”
(e in questo senso, come notava il Peano, viene a coincidere con il
concetto stesso di spazio), e ancora per parlare dell’“idea” di un singolo e determinato punto che, ovviamente, in
quanto “idea” e altra cosa dal
singolo punto pensato come “essere
concreto” a cui l’“idea” si
riferisce. Con l’ideografia di Peano è facile distinguere i tre concetti, ma
entreremmo in un discorso troppo tecnico, non adeguato allo scopo di questo
scritto.
La seconda (cioè la
distanza) viene intesa, a sua volta, come il risultato di una ben precisa
operazione fisica che trasporti rigidamente lungo una direzione la lunghezza di
un segmento, pensato come l’insieme dei punti compresi tra i suoi due punti
estremi. Ma cos’è mai un “trasporto
rigido”? Oggi, come abbiamo visto, questo sembra
essere un grosso problema. Noi ci accontenteremo di dire che è un’operazione
fisica che lascia invariata la forma e l’estensione di un ente fisico come
misurate dagli opportuni parametri: la lunghezza di una qualunque linea, l’area
di una qualunque superficie, il volume di un qualunque corpo, gli angoli
relativi tra i vari segmenti che possiamo individuare nel corpo; tutte
grandezze queste che si suppone che abbiamo definito operativamente, altrimenti
non potremmo chiamarle tali.
Oggi l’opinione generale è
che gli antichi assumevano le proprietà del trasporto per “intuizione”; ma è più probabile, invece, che ne
assumessero il concetto come una necessità logica conseguente al loro concetto
di grandezza. Osserviamo che, a partire dai concetti di punto e distanza, si
possono definire nominalmente (usando i soli segni della logica) tutti gli altri
concetti della geometria come e stato mostrato da Peano e da Pieri.5
Già per i pitagorici
(secondo la testimonianza di Aristotele) il punto si distingue dalla “monade unità elemento” in quanto oltre
a essere una “monade” ha anche una “posizione” individuata da una terna di grandezze
(“distanze”) relative ad altri punti
dello spazio fisico, assunti convenzionalmente come punti di riferimento che
necessariamente dobbiamo pensare come immoti ché il pensare che non lo siano
sarebbe senza senso, non avendo alcun modo di accorgercene per l’assoluta
omogeneità e isotropia del concetto di spazio (ovvero di “punto”) quando pensato come privo di ogni qualità particolare che
può solo essere individuata quando, preliminarmente, si sia introdotto il
concetto di materia (come, p. es., quello di essere spazio “pieno” di materia o spazio “vuoto”,
cioè privo di materia) — e, pur avendo già introdotto il concetto di
distanza e assunto come unità di misura la distanza tra due punti arbitrari, lo
spazio resterebbe, di necessità, ancora “omogeneo
e isotropo”, per la definizione stessa di grandezza; e una geometria
cosiddetta “non-euclidea” (come
geometria “fisica”) non sarebbe, “per necessità logica”, neppure
pensabile in quanto questa impedirebbe qualsiasi trasporto rigido e, quindi,
qualsiasi possibilità di confronto diretto.
Quindi, il punto che si
considera in geometria, quando il termine “geometria”
venga considerato nel suo significato etimologico, è rappresentato da una “tetrade”, cioè da una quaterna di punti
(di cui tre di riferimento, in genere assunti tacitamente dal momento che poi
si debbono considerare solo distanze relative) i quali insieme individuano una
terna indipendente di dimensioni (cioè di distanze del punto considerato
rispetto alla terna dei punti di riferimento); in geometria piana basta
considerare una “triade”, cioè una
terna di punti e una coppia di distanze; sulla retta (o, più in generale, su di
una linea) il punto sarà una “diade” ,
cioè una coppia di punti (il punto in oggetto e quello di riferimento) e la
distanza tra di essi.
Nello spazio fisico il
numero di punti di riferimento necessario per individuare un punto qualsiasi
mediante le sue distanze relative è, quindi, tre. Tali distanze vengono
chiamate da Euclide rispettivamente: “lunghezza,
larghezza, profondità”; infatti, per individuare il punto basterà pensarlo
come uno dei vertici del tetraedo che ha come rimanenti vertici anche i tre
punti di riferimento (riferimento comune a tutti gli altri punti dello spazio).
Nel libro primo, Euclide fa
astrazione dalla terza dimensione e definisce la linea come lunghezza senza
larghezza, restando implicita l’altra caratteristica di essere senza
profondità, nel senso che, nel piano, il tetraedo può essere sostituito da un
triangolo e, restando fissi i due vertici di riferimento, la linea può essere
descritta facendo variare continuamente il terzo vertice con una legge
determinata, di modo che su di essa abbia senso solo il concetto di lunghezza.
Nel linguaggio di Euclide,
quando non è strettamente necessario, non si distingue tra la figura
geometrica e la grandezza che gli compete e due figure sono per lui eguali se
hanno la stessa estensione; ma, a differenza di quanto farà poi Archimede, la
sua eguaglianza si limita alla coincidenza delle figure dopo un’operazione di
trasporto fisico — traslazione o rotazione o riflessione — la quale, per
definizione, mantiene invariate le distanze relative fra i punti della figura;
invarianza che si suppone verificata per confronto con i due punti assunti come
unità di misura delle distanze. Solo a poco a poco e costruttivamente, egli
estende il concetto di uguaglianza anche a operazioni fisiche più complesse
come quella del taglio ideale e ripetuto effettuato su di una figura con
opportune rette (e nel libro undicesimo anche con piani) immaginando di poter
sovrapporre le singole “parti” di una
figura a quelle dell’altra per confrontarle.
Nell’asserire che gli
estremi di una linea sono punti e che gli estremi di una superficie sono linee
e che limite di un solido è una superficie, Euclide presuppone alcune
fondamentali nozioni topologiche, molto probabilmente, già chiarite nella
tradizione pitagorica.
Avendo introdotto la nozione
di spazio come insieme di tutti i suoi punti, senza introdurre altre
specificazioni, tale spazio coinciderà con l’“essere
parmenideo” e cioè sarà: limitato, immobile, omogeneo, isotropo, e senza
tempo. Avendo aggiunto la nozione di distanza tra punti se ne può rendere
illimitata l’estensione, ma i suoi punti resteranno indifferenziati. Per
differenziarli bisognerà aggiungere un’altra specificazione: la materia.
Per tali ragioni, secondo
Newton, i punti possono essere materiali (punti di un solido ideale di densità
massima “atomo democriteo”) e punti
non materiali (punti dello spazio vuoto di materia). Un corpo fisico, nella sua
apparenza, sarà una proporzione data di atomi e vuoto.
In geometria si astrae dalle
proprietà particolari che tale mescolanza produce, basterà considerare la
geometria degli atomi, cioè dei corpi solidi privi di “pori”, come già aveva precisato Empedocle, i quali, a loro volta,
vengono “idealizzati” ulteriormente come figure geometriche con tre, due, una
o zero dimensioni; basterà solo distinguere la figura dallo spazio vuoto; solo
in esso è possibile effettuare traslazioni, rotazioni, riflessioni e
separazioni arbitrarie.
Un punto materiale è interno
alla figura, un punto del vuoto è esterno alla figura (la figura è un oggetto
ideale e può essere semplicemente una periferia), i punti di contatto tra
materia e vuoto sono “estremi” o “limiti” o “termini”.
A questo punto Euclide
enuncia il suo concetto di “linea retta”, dicendo: Linea retta é quella in cui i suoi punti vi giacciono uniformemente (έξ
’ισου).
L’enunciato, in lingua
greca, di questa asserzione ha sempre provocato grandi perplessità e, quindi,
difformi traduzioni in base al suo dubbio significato. La mia ipotesi è che le
perplessità derivano esclusivamente dal pregiudizio che Euclide non poteva
possedere quelle conoscenze che solo dopo millenni sono state da noi moderni
conquistate, dimenticando che il suo testo (seppure sia il suo o non piuttosto
il suo completo rifacimento ad uso di leone d’Alessandria per i suoi studenti!)
ci è pervenuto dopo secoli di quasi totale barbarie scientifica, malamente
illuminato da vari commentatori medioevali che, a fatica, cercavano di
risollevarsi alla luce della scienza, seppure ancor dentro il paradigma
platonico-aristotelico.6
Credo che l’interpretazione
più coerente e più nello spirito di tutta la scienza dei pitagorici si possa
ricavare dall’impostazione della geometria come rigorosamente assiomatizzata
dalla scuola di Peano (vedi nota5), come, del resto, lo stesso Pieri
nota, riferendo la propria definizione di retta alle proposizioni XI e XII del
terzo libro degli Elementi di Euclide, che ne costituiscono la proposizione
inversa (nel piano).
Quindi la definizione
euclidea si può rendere con: Dicesi retta
quella linea in cui, presi due punti qualsiasi di essa, esiste sempre un punto in
essa, e non più di uno, che ha la proprietà di essere equidistante dai primi
due e non esiste alcun altro punto nello spazio che equidista dai due punti
detti per lo stesso valore della distanza (probabilmente è questa proprietà
di “equidistanza univoca” che Euclide
vuole esprimere con il termine έξ
’ισου) o, equivalentemente: retta passante per due punti é il luogo dei
punti di tangenza di due sfere che hanno per centri i due punti dati. Tale
definizione è equivalente a quella successivamente data da Archimede come linea
di lunghezza minima (oggi detta “geodetica”).
Notiamo che, avendo assegnato le precedenti proprietà, non si definisce
univocamente una retta, ma se ne ne dà solo una delle sue proprietà; infatti,
qualunque geodetica, in una varietà riemanniana comunque curva, soddisfa le
precedenti definizioni.
Subito dopo, Euclide
definisce l’angolo piano come la pendenza relativa (κλίσις) di due linee in un piano che
si incontrino tra loro ma che non giacciano su di una linea retta.
Molti commentatori, all’interno
del paradigma hilbertiano, trovano tale definizione circolare in quanto si
definisce l’angolo mediante il termine pendenza che si può definire solo
mediante la nozione di angolo.
Ma è proprio vero questo?
Forse tali commentatori dimenticano che per Euclide la pendenza (così come la
distanza e l’angolo) è una grandezza fisica e non un semplice numero, come per
Lobačevskij, o un nome senza significato, come per Hilbert! E qualunque
agrimensore, fin da tempi molto più remoti, sapeva come misurare una pendenza
per confronto con un’unità di misura assegnata. Quindi Euclide si limita a dire
che l’angolo è la stessa cosa di una pendenza, solo misurata in una scala
diversa, additiva per le aree.
Infatti, il fatto che
Euclide definisce l’angolo per due linee in generale, e non per due rette,
porta a pensare che l’unità di misura degli angoli piani doveva essere
un’area, per cui la pendenza poteva ben essere individuata dal rapporto tra la “misura” dell’area compresa tra le due
linee date e la circonferenza di un cerchio, di raggio opportunamente
determinato (a seconda del caso concreto in esame, ma sempre con centro nel
punto di incontro tra le due linee) e la “misura”
dell’area del cerchio stesso. Ovviamente, solo quando le due linee fossero
state delle rette si sarebbe potuto dare una regola generale per tale misura;
potendosi, in questo caso, scegliere un cerchio di raggio qualunque; per cui,
nei suoi “Elementi”,
Euclide si limita nel seguito a trattare solo degli angoli rettilinei.
Un tale rapporto può essere
dato, in tutta generalità, con i metodi di Archimede che, per la prima volta,
fornisce il modo di misurare il rapporto tra l’area del cerchio e il quadrato
del suo raggio. Ma, per le dimostrazioni di Euclide, non è necessario conoscere
tale numero, bastando solo assumerne l’esistenza.
Senza un criterio di
misurazione per gli angoli non si potrebbero definire gli angoli retti come
quegli angoli adiacenti “uguali” formati
da due rette intersecantesi; ché, se si volessero definire gli angoli come
porzioni di piano limitate da due raggi, come in epoche posteriori si è
cominciato a fare, non si potrebbe misurare il rapporto tra due grandezze
(ammesso che lo siano!) che si sa dove cominciano e non si sa dove finiscono!
Per angoli rettilinei è
possibile farlo purché si ammetta l’indipendenza della “misura” dell’angolo dalla lunghezza del lato, a ciò provvede
Euclide enunciando un assioma in cui si asserisce che tutti gli angoli retti
sono uguali tra loro. E poiché per Euclide “uguale”
(ǐσος) significa eguale in grandezza, ne viene che se
si assume tale assioma non e possibile nessuna geometria che non sia euclidea
come molti matematici del passato hanno dimostrato; in questo specifico
contesto bisogna ricordare il Wallis (1616 - 1703) e il Saccheri (1667 - 1733)7.
Ma, allora, qual è il
significato fisico delle cosiddette geometrie non-euclidee, delle quali si è
fatto un gran parlare tra matematici e fisici, e di cui ancora si parla,
specialmente da parte dei volgarizzatori scientifici?
Poiché sovente si leggono
affermazioni piuttosto strane, secondo le quali da una parte la possibilità di
tali geometrie verrebbe provata empiricamente dalla teoria della relatività e,
a sua volta, la teoria della relatività riceve l’avallo dalla coerenza delle
geometrie non-euclidee, chiudendo così un circolo vizioso, sarà bene esaminare
la questione un pò più a fondo.
Ci sarebbe, intanto, una
questione che potrebbe apparire puramente nominalistica se non si collegasse
direttamente alla nuova metafisica sulla funzione della scienza. Scriveva, p.
es., Peano:8 “Certo è
permesso a chiunque di premettere
quelle ipotesi che vuole, e lo sviluppare
le conseguenze logiche contenute in quelle ipotesi. Ma affinché questo lavoro
meriti il nome di Geometria, bisogna
che quelle ipotesi o postulati esprimano il risultato delle osservazioni più
semplici ed elementari delle figure fisiche. La Geometria di posizione, o
proiettiva, poi, è una parte della Geometria generale; quindi i suoi postulati
si debbono trovare fra quelli assunti per la Geometria generale.
In conseguenza, sotto il punto di vista pratico, non parmi lecito
l’assumere ad es. come postulato su cui fondare la Geometria proiettiva il
seguente:
«Due rette giacenti in uno stesso piano hanno sempre un punto in comune», poiché questa proposizione non si verifica con l’osservazione, ed è anzi in contraddizione coi teoremi di Euclide.
La Geometria proiettiva parte dai postulati della Geometria elementare,
e, con opportune definizioni, introduce nuovi enti, detti punti ideali (sia
nella Geometria Euclidea, che nella non Euclidea), e ne risulta così che i
nuovi enti ottenuti soddisfano alle proposizioni precedenti”.
Il fatto paradossale è che i
primi autori che si sono occupati di geometrie non-euclidee partivano
dall’esigenza di far ritornare lo studio della geometria, che era ormai
diventato troppo astratto, all’antico legame con le “operazioni fisiche”; ma quando, dopo i primi rifiuti da
parte dell’“Accademia” di accettare
come scientifiche le proposte di tali innovatori (come sempre naturalmente
accade), si è acceso il fervore per tali nuove geometrie, tali esigenze furono
completamente dimenticate e l’avvento della relatività, nonostante le analisi
operativistiche dei primi lavori di Einstein (come esamineremo in seguito
parlando più specificamente di tale teoria), non ha modificato l’atteggiamento
astratto dei geometri, atteggiamento che, invece, si è imposto anche tra i
fisici.
Scriveva Lobačevskij:9 “Tutta la matematica è scienza della misura; tutto ciò che esiste nella
natura, è assoggettato alla condizione necessaria di essere misurabile: perciò
la differenza tra grandezze deve ricondursi a un diverso
genere di misura e ai numeri che rappresentano le loro misure; tutti gli altri
concetti saranno sempre oscuri e insufficienti” .
Sembra lo stesso linguaggio
di Newton, ma non è così! perché, quando Newton parla di misure vere e
matematiche intende quelle “assolute”, mentre
Lobačevskij si riferisce a quelle sensibili che per Newton sono “relative”, apparenti e volgari.
Infatti, precisa
Lobačevskij:10 “Nella natura noi abbiamo cognizione,
propriamente, soltanto del movimento, senza il quale le impressioni sensoriali
sono impossibili. Pertanto tutti i rimanenti concetti, per esempio quelli
geometrici, sono creazioni artificiali della nostra mente, tratte dalle
proprietà del movimento; ecco perché lo spazio, in sé, separatamente preso, per noi non esiste. Dopo di che nella nostra mente non vi può essere
nessuna contraddizione, se supponiamo che talune forze della natura seguono una
geometria, altre un’altra loro particolare geometria. Per chiarire questo
pensiero supponiamo (e di ciò molti sono convinti) che le forze attrattive si
indeboliscano per la diffusione della loro azione su superfici sferiche. Nella
Geometria ordinaria si prende la grandezza uguale a 4πr2 in
corrispopdenza del raggio r, dal che si ha che la forza deve diminuire
proporzionalmente al quadrato della distanza. Nella Geometria immaginaria11 io ho trovato che la superficie della sfera è:
π (e r- e - r) 2
e può essere
che tale geometria seguano le forze molecolari, ogni particolarità delle quali dipenderebbe
con ciò dal numero ‘e’, sempre molto grande. Del resto, sia dato questo esempio
come pura ipotesi, a conferma, della quale è necessario trovare altre più convincenti prove. Di una
cosa tuttavia non è permesso di dubitare: che le forze da sole generano tutto:
movimento, velocità, tempo, massa, perfino distanze e angoli. Con le forze,
tutto si trova in stretto legame: non riuscendo
a cogliere l’essenza di tale legame, non possiamo affermare se nelle relazioni
di grandezze eterogenee tra di loro debbono intervenire soltanto i loro
rapporti. Ammettendo la dipendenza dal rapporto, perché non supporre anche la
dipendenza senz’altro? Alcuni casi parlano già in favore di questa opinione: la
grandezza della forza di attrazione, ad esempio, si esprime con la massa,
divisa per il quadrato della distanza. Per distanza uguale a zero, questa
espressione, propriamente, non rappresenta nulla. È necessario cominciare con
una distanza purchessia, grande o piccola, ma sempre effettiva, e solo allora
la forza compare. Ora si chiede: la distanza come mai genera questa forza? come
mai sussiste nella natura questo legame tra oggetti così eterogenei? Non
riusciremo probabilmente mai a pervenire a ciò; ma quando è vero che le forze
dipendono dalle distanze, allora i segmenti possono del pari essere dipendenti
dagli angoli”.
Il “matematico” Lobačevskij vuole ridurre tutto a forze, il “fisico” Hertz, al contrario, vuole
eliminare le forze dalla fisica!12
Ma vediamo di capire meglio il significato di grandezze omogenee ed eterogenee a cui si riferisce il Lobačevskij.
L’espressione x = α u definisce una grandezza
omogenea in rapporto alla sua unità di misura. Più in generale, se conveniamo
di indicare con Qa la
classe di tutti i termini α a, in
cui α Î Q è una quantità (= valore =
misura = numero) e a è
una grandezza determinata allora, per definizione, Qa esprime la classe di tutte le grandezze omogenee con a. Se b Ï Qa e b Î G (cioè: b è una grandezza) allora a e
b sono grandezze eterogenee.
Non sempre è definita la
somma di due grandezze omogenee (p. es. non ha senso, in generale, la somma di
due densità, a volte scriviamo ρ =
ρ1 + ρ2
come abbreviazione di ![]() sotto la condizione “ineliminabile”
che v deve essere uguale in tutti
e tre i membri, in quanto, in effetti, si sommano le masse e non le densità.
sotto la condizione “ineliminabile”
che v deve essere uguale in tutti
e tre i membri, in quanto, in effetti, si sommano le masse e non le densità.
Se è definita “operativamente” la somma, si parla di
“grandezza estensiva”; nel caso che non lo sia e, però, la grandezza sia
definita come il rapporto di due grandezze estensive, si parla di “grandezza
intensiva” (tale vocabolario si ricollega alla distinzione newtoniania tra “extensio” ed “intensio” ed è usuale nell’odierna termodinamica teorica).13
In tal caso la somma non è
definita (e non può essere definita!), semplicemente perché non avrebbe alcun
senso la somma tra grandezze eterogenee (tuttavia nei libri di meccanica
statistica moderni si sommano tranquillamente impulsi e coordinate!).
Il risultato del prodotto di
due grandezze omogenee (quando ha fisicamente senso) è una grandezza eterogenea
alle prime due (p. es., l’“area” del
quadrato non è omogenea con la “lunghezza”
del suo lato).
Il prodotto di due grandezze
eterogenee (quando ha fisicamente senso) è una grandezza eterogenea alle due di
cui si è fatto il prodotto.
In fisica risulta opportuno,
più generalmente, introdurre grandezze come funzioni di altre grandezze (p.
es. ![]() ).
).
In tal caso si deve
pretendere che la funzione matematica che definisce la nuova grandezza debba
essere non omogenea nella grandezza che si definisce e che, invece, sia
omogenea nell’eguaglianza che esprime una legge fisica.
Citiamo da Peano:14
“Le aree costituiscono una classe di grandezze indipendenti dalle
lunghezze. Da Herone in poi si fa la convenzione:
Quadrato di lato 1 = 1
cioè si
identifica Cq =
C2 ; o, in altre
parole, si fa la convenzione:
Rettangolo di lati a e b = a ´ b.
Parimenti, senza alcuna convenzione, si ha:
Parallepipedo ortogonale di lati a, b, c = (cubo dilato 1) ´ a ´
b ´ c;
e si suol fare
generalmente:
Cubo di lato 1 = 1.
Si potrebbe fare una convenzione diversa, ponendo p. es.:
Cerchio di raggio 1 = 1.
Gli angoli piani
si sogliono misurare col retto, col grado sessagesimale = retto/90, col
centesimale = retto/100, col mill = retto/16000; e infine col radiante, o angolo
chiuso dall’arco eguale al raggio, = retto ´ (2π).
In geometria e in fisica si fa spesso
Radiante = 1,
e si
identificano gli angoli ai numeri astratti. Però questa convenzione è meno frequente delle precedenti; ed è più pericolosa…
Una legge naturale, fisica o economica, si suole esprimere
coll’eguaglianza di due funzioni di certe grandezze. Dividendo l’un membro per
l’altro, essa potrà assumere la forma:
funzione di alcune grandezze = 1.
Per funzione non si deve intendere solo una funzione analitica, ma
un’espressione composta col linguaggio ordinario. Ad esempio, il rapporto fra
la lira e il franco è una funzione del tempo, che, pel tempo passato risulta dai
listini di borsa, e pel futuro risulterà quando sia passato. Nessuno pensa di
trovarne l’espressione analitica.
Si dice che la legge è omogenea rispetto a una grandezza C quando,
ridotto il secondo membro=1, il primo membro è funzione
omogenea di grado 0 di C, cioè non dipende da C; o, sotto forma volgare, non
varia se al posto di C metto 2C.
Se la relazione non è omogenea in C, da essa si può ricavare C, cioè può servire a definire
la grandezza C.
Perciò le definizioni delle grandezze fisiche non sono omogenee nella
grandezza che si definisce.
Centimetro = 10-9 ´ quadrante terrestre,
«Gramme=poids absolu d’un volume d’eau pure égal au cube de la centième
partie du mètre, à la température de la glace fondant», come dice la legge del
18 germinale anno III (7 aprile 1795), non sussistono se al posto di C metto 2C.
In geometria pura ogni relazione fra lunghezze è omogenea. Se una
lunghezza è funzione di altra lunghezza definita colla sola geometria senza
introdurre altre lunghezze, quella funzione è una proporzionalità. Quindi per
definire una lunghezza assoluta, il c, bisogna parlare di meridiano terrestre o
di anno luce, uscendo dalla geometria pura.
Se si nega il postulato delle parallele, allora da un punto si possono
condurre due parallele ad una retta che formano un angolo, funzione delle
distanze del punto dalla retta. Questa relazione non è omogenea; quindi posso
determinare una lunghezza assoluta, che chiamasi raggio di curvatura dello
spazio. Alcuni preferiscono dire che anche le formule di pangeometria15 sono omogenee,
purché si introduca il raggio di curvatura.
Gli antichi Cinesi si rappresentavano, come tutti i popoli primitivi,
la terra piana; osservarono che camminando verso il nord, l’altezza del polo
sull’orizzonte aumentava. Considerarono il rapporto fra il cammino e
l’incremento di quest’angolo; ed ottennero una lunghezza assoluta, che
chiamarono diametro del mondo. Noi lo chiamiamo raggio terrestre.
Nei trattati di meccanica e di fisica si dimostra la formula che dà la
durata di oscillazione di un pendolo, come segue.
Se la durata, cioè un a quantità di s, è funzione della lunghezza del
pendolo= quantità di c, e della gravità=quantità di cs-2, e se
questa relazione è omogenea, si potranno determinare i numeri p e q in modo che:
![]() ,
,
da cui p + q=0, -2q = 1, onde p = 1/2, q = -1/2 , e
durata
= coefficiente ´ ![]() .
.
Ma molti autori sopprimono 1’ipotesi che la formula debba essere
omogenea.
Per rendere evidente questa illusione, prodotta dalla confusione fra
grandezze e numeri, considero, per esempio, la distanza r dalla terra al sole,
che è una funzione del tempo t. Per trovare la natura di questa funzione
poniamo r = f(t); cambiamo l’unità di tempo, prendendone un’altra k volte più
piccola; allora la nuova misura del tempo sarà kt; ma r deve restare immutato;
dunque dovrà essere f(kt)=f(t),
cioè f(t) è
costante, e la distanza dalla terra al sole è costante; parimenti costanti sono
le reciproche distanze di tutti i corpi celesti e terrestri!…
Se una legge fisica stabilisce una relazione fra grandezze di specie
diversa, e questa non è omogenea, si può ricavare una di queste in funzione
delle altre.
O altrimenti, se nell’enunciato della legge fisica si sono indicate
tutte le grandezze che vi compaiono esplicitamente e implicitamente in guisa
che nessuna grandezza non indicata esplicitamente si possa ricavare da quella
relazione, allora essa è omogenea”.
Se accettiamo le “convenzioni” di
cui sopra, e notiamo che tali convenzioni sono state sempre
fatte, consciamente o inconsciamente, fin dall’antichità (chi
ha deviato l’ha sempre fatto inconsciamente, non avendo mai fatto una misura
diversa da quella che si può compiere guardando le lancette sul quadrante di un
orologio o esperienze similari)16 che
cosa possiamo dedurre intorno alla formula di Lobačevskij che esprime la
superficie della sfera nella sua geometria? e che cosa dobbiamo pensare della
sua tesi secondo la quale “non possiamo
affermare se nelle relazioni di grandezze eterogenee tra di loro debbono intervenire soltanto i
loro rapporti”? E che cosa, ancora,
della sua proposta che “Ammettendo la
dipendenza dal rapporto, perché non supporre anche la dipendenza senz’altro?”
O, più in generale, qual è la rilevanza fisica delle geometrie non-eucidee?
Per rispondere alle prime tre domande basta
ricordare che la dipendenza dai soli rapporti (e quindi l’“omogeneità”) si pretende solo per le leggi fisiche;
mentre, al contrario, per le definizioni di una grandezza come funzione di
altre grandezze si pretende l’“eterogeneità”.
Quindi la formula di Lobačevskij, essendo eterogenea, si deve
intendere come definizione di superficie della sfera. Ora è chiaro che ognuno è
libero di definire tutte le grandezze che vuole, a seconda dei suoi scopi; ma,
generalmente, non è ritenuto conveniente, se si vogliono evitare confusioni e
slittamenti semantici, il chiamare la nuova grandezza con un nome che, fin
dall’antichità, è stato usato per un’altra e diversa grandezza, con la quale,
tuttavia, è obbligatorio stabilire le derivanti connessioni.
Una grandezza fisica può essere definita
operativamente sia per confronto diretto con la sua unità di misura, o in modo
indiretto mediante un’equazione tra grandezze. Questo, naturalmente, vale anche
per l’area di qualche superficie. L’area si può definire (cfr. Perucca) in modo
diretto mediante un’operazione fisica che può essere effettuata, p. es.,
mediante un planimetro; o, come è più usuale, dal confronto con un quadrato di
lato l, mediante l’equazione
definitoria S = l2 . In quest’ultimo caso la superficie
sferica vale sempre (come legge fisica e quindi “omogenea”): Ssfera = 4πr2,
dal momento che la geometria non può cambiare, per se stessa (cioè senza
esplicite convenzioni sul tipo di misure che dobbiamo fare), il risultato di
una misura.
Sulla base di tale confusione linguistica,
assunta a postulato metafisico, lo stesso Lobačevskij (usando misurazioni
astronomiche) e anche Gauss (usando misurazioni geodetiche) tentarono la
verifica empirica della “verità” della
geometria euclidea! Alla luce delle infinite (e spesso contraddittorie)
riflessioni epistemologiche prodottesi in seguito alla teoria della relatività,
tali tentativi appaiono, perlomeno, ingenui.
Per cercare di capire questo fatto,
rispondendo così all’ultima domanda che ci siamo posti, è utile riportare un
classico esempio, dovuto a Bridgman17
che mostra, in modo inequivocabile, come la diversa definizione operativa
di una quantità fisica che, intuitivarnente, dovrebbe dare lo stesso risultato,
ci costringe a concludere che due metodi diversi di effettuare una misura non
necessariamente misurano la stessa grandezza fisica. Tale identità può solo
essere affermata, con un grado maggiore o minore di certezza, solo dopo
un’accurata analisi teorica e sperimentale: “Il
concetto di velocità, come definito di solito, implica i due concetti di spazio
e tempo. Le operazioni con cui noi misuriamo la velocità di un oggetto sono
queste: dapprima osserviamo l’istante in cui l’oggetto è in una posizione, poi osserviamo l’istante in cui esso si trova in un’altra
posizione, dividiamo la distanza fra le due posizioni per l’intervallo di tempo
e se necessario, quando la velocità è variabile passiamo al limite.
Questo
concetto di velocità, così definito, può venir usato come strumento per
descrivere la natura e si troverà che la natura
ha certe
proprietà: per esempio, la velocità della
luce è 3. 1010
cm/s. Inoltre a nessun oggetto
materiale può venir impressa una velocità altrettanto elevata; all’aumentare
della sua velocità verso questo valore,
occorrono incrementi di energia crescenti
senza limite.
Vi è ancora un altro modo assai interessante di definire la velocità, in cui non si
compie affatto l’analisi in termini di spazio e tempo, bensì la
velocità viene misurata direttamente ricostruendo la velocità data mediante
l’addizione fisica di una unità di velocità scelta arbitrariamente. ... Noi possiamo anzitutto costruire un campione
concreto di velocità, per esempio stendendo un filo tra due sostegni con un peso fisso per tenerlo in tensione. Se urtiamo il filo, lungo di
esso si propaga un disturbo che possiamo seguire con l’occhio; definiamo unità
di velocità la velocità di questo disturbo. Un oggetto ha una velocità maggiore
dell’unità se precede il disturbo, minore se rimane indietro. Possiamo ora
duplicare il nostro campione, costruendo un altro sistema di sostegni con filo
teso, e controllare l’eguaglianza delle due velocità osservando se i due
disturbi procedono insieme. Definiamo due unità di velocità di qualcosa che
corra insieme col disturbo del filo del secondo sistema, quando il secondo
sistema si muove con una velocità tale che esso corre insieme
al disturbo del primo filo. Si può estendere indefinitamente il processo, e
misurare qualunque velocità.
…si trova che la velocità della luce è infinita. Inoltre, non vi sarebbe alcun limite alla velocità che si può impartire ai corpi materiali dando ad essi
un’energia illimitata, cosa che l’esperienza ordinaria ci ha preparato a
considerare come semplice e naturale.
La velocità infinita della luce, d’altra parte è quanto mai innaturale, specialmente
se noi ci atteniamo al punto di vista del mezzo di trasmissione.”
Da questo esempio ricaviamo l’esigenza di
analizzare le operazioni fisiche che effettivamente compiamo prima di dedurre
qualcosa su di una qualunque grandezza fisica, anche in riguardo a quei
concetti che da tutti sono ritenuti più semplici e primordiali, come quelli di
spazio, di tempo e di movimento.
Era questa, del resto, l’esigenza che aveva
avanzato Einstein nel suo famosissimo lavoro in cui sono state gettate le basi
della relatività.
In passato era difficile trovare un libro di
testo di Fisica, o di Meccanica Razionale, o di Geometria (e persino molti
libri di Analisi Matematica) che non cominciasse con una trattazione delle
grandezze fisiche. Oggi la teoria delle grandezze è scomparsa persino dai libri
di Fisica; qualcuno vi dedica due o tre paginette che, senza accorgersene,
contraddirà nelle pagine successive.
Ma, per parlare di relatività, è bene
chiarire il significato di “spazio
assoluto” e “tempo assoluto”, anche
perché con gli stessi nomi, spesso, nella letteratura si intendono cose
assolutamente diverse, provocando non pochi fraintendimenti.
Alcuni autori, senza darne un’esplicita
definizione, sembrano contrappore l’aggettivo “assoluto” a “relativo” inteso
quest’ultimo nel senso che noi possiamo misurare solo differenze di coordinate
(siano esse spaziali o temporali). Ma questa distinzione è troppo banale per
avere una qualche rilevanza fisica o filosofica in quanto l’affermazione della
relatività (intesa in questo senso) ci dice solo che noi possiamo scegliere ad
arbitrio l’origine delle coordinate. Ma questo era un fatto ovvio sia per
Galilei che per Newton (anche se non lo era nella fisica aristotelica).
Per Newton i due termini facevano
riferimento: l’uno (l’assoluto) a una pura convenzione “logica” e perciò insopprimibile in quanto distinzione puramente
logica tra lo spazio e il tempo (proprietà distinte da qualunque altra
proprietà esprimibile con parole), l’altro (il relativo) alle “concrete misure sensibili” che noi
possiamo compiere; le quali ultime, naturalmente, sono affette da errori sia
sistematici, sia casuali, sia dovuti alla sensibilità finita dei nostri
strumenti.
Se identificassimo i concetti di spazio o di
tempo con un solo tipo di misura sensibile e negassimo loro (per questo e
giustamente) l’aggettivo “assoluto”, non
ci sarebbe nessuna possibilità logica per poter asserire che altri tipi di
misurazioni misurino effettivamente la stessa cosa, dal momento che si verrebbe
a negare, in partenza, l’esistenza della “cosa”
stessa. A meno che, come sembra fare Einstein, non affermiamo che tutti i
tipi di misurazioni diano lo stesso risultato, ma questa ora diverrebbe
un’affermazione empirica e come tale bisognerà verificare sperimentalmente e
non può essere assunta come definizione.
Questo problema, non chiarito nella
formulazione di Einstein, ha portato a diverse possibili interpretazioni della
teoria della relatività, spesso non molto coerenti, specialmente quando ci si
propone di salvare capre e cavoli.
Ma analizziamo, più da vicino, i concetti di
spazio e tempo.
Scrive il Bridgman:18 “Abbiamo
visto che le misure di lunghezza si compiono applicando metri fisici su oggetti
fisici. Non possiamo misurare la distanza tra due punti dello spazio vuoto,
perché se lo spazio fosse vuoto non vi sarebbe nulla con cui identificare la
posizione degli estremi del metro quando lo spostiamo da una posizione a quella
successiva. Vediamo dunque che dal punto di vista operativo il sistema di
riferimento della geometria cartesiana, spesso immaginato in senso matematico
ideale, è di fatto un sistema fisico, e che per proprietà spaziali non
intendiamo altro che le proprietà di questo sistema di riferimento. Dicendo che
lo spazio è euclideo, intendiamo che lo spazio fisico dei regoli misuratori è
euclideo: non ha senso chiedersi se lo spazio vuoto è euclideo. La geometria,
in quanto si vogliano applicare i suoi risultati al mondo fisico esterno e in quanto non la si consideri solo un sistema logico costruito sulla
base di postulati, risulta pertanto una scienza sperimentale.
Abbiamo già
osservato come lo spazio dell’astronomia non sia uno spazio fisico di regoli
graduati, bensì uno spazio di onde luminose. Possiamo avere diverse specie di
spazio a seconda delle operazioni fondamentali. Abbiamo chiamato «spazio
tattile» lo spazio dei regoli graduati e «spazio ottico» lo spazio dei raggi
luminosi. Chiedendoci se lo spazio astronomico è euclideo, intendiamo
semplicemente chiedere se quelle caratteristiche dello spazio ottico che
rientrano nel raggio delle misure astronomiche sono euclidee. L’unico
atteggiamento possibile nei riguardi di tale questione e di quelle ad essa
connesse, per esempio se il volume totale dello spazi o èfinito o se lo spazio
è curvo, consiste nel lasciare ogni decisione all’esperimento e nel dichiarare
che non abbiamo alcun diritto a nozioni preconcette. La cosa è dunque al di
fuori degli scopi di questa discussione.
È interessante
osservare come la teoria ristretta della relatività in sostanza presupponga,
anche senza farne cenno esplicito, che lo spazio tattile e quello ottico
coincidano. Questa coincidenza risulta dalle proprietà che si suppone abbiano i
raggi di luce. La distanza di uno specchio si può misurare egualmente bene sia
mediante un regolo, sia calcolando il tempo occorrente a un segnale luminoso
per giungere allo specchio e tornare indietro. Tuttavia questa situazione è
insoddisfacente, in quanto bisogna supporre che le operazioni per misurare il
tempo siano definite indipendentemente, cosa che, come vedremo, non è vera. Dalla supposta equivalenza tra spazio ottico e spazio tattile
consegue che il cammino di un fascio luminoso è rettilineo, la linea retta
essendo determinata da operazioni compiute con i regoli. Passando ai fenomeni
astronomici, le operazioni fisiche mediante regoli non si possono più
effettuare e diventa privo di significato l’attribuire ai raggi luminosi su
scala cosmica le stesse proprietà geometriche che attribuiamo ad essi su
piccola scala.”
Stando a queste considerazioni di Bridgman,
l’idea di Gauss e di Lobačevskij di verificare sperimentalmente il tipo di
geometria dello spazio risulterebbe priva di senso. Al più si sarebbe solo
potuto verificare se lo spazio tattile e quello ottico risultassero ancora
coincidenti alle grandi distanze.
Anche la misura del tempo è soggetta a simili
considerazioni. Infatti continua il Bridgman: “Dobbiamo distinguere due specie di tempo: il tempo degli eventi che
hanno luogo l’uno vicino all’altro nello spazio, o tempo
locale, e il tempo degli eventi che hanno luogo in punti dello spazio
notevolmente lontani, o tempo esteso. Come ora sappiamo, il concetto di tempo
esteso è legato inestricabilmente al concetto di spazio. Questa non è un’affermazione sulla natura, e
vi si può giungere con la semplice
osservazione che le operazioni mediante cui si misura il tempo esteso implicano quelle mediante cui si misura lo spazio…
Le operazioni
fisiche alla base della misura del tempo non sono mai state sottoposte all’esame
critico che sembra occorrere. Un metodo di misura, per esempio, implica le
proprietà della luce.19 Agli estremi
di un regolo graduato vengono posti due specchi ed un raggio di luce viaggia
avanti e indietro fra i due specchi senza subire assorbimenti.
L’intervallo di tempo occorrente per un percorso di andata e ritorno viene
preso come unità, e il tempo si
misura semplicemente contando tali intervalli. Questo procedimento però non
risulta soddisfacente se vogliamo poter fare tutte le operazioni richieste
anche dal postulato relativistico più semplice, in quanto dobbiamo essere in
grado di spostare il nostro orologio da punto a punto, di trasferirlo da un
sistema a un altro in moto relativo e di determinare mediante esso le proprietà
dei raggi di luce nel sistema in quiete o
in movimento. Riconosciamo in linea di principio che la lunghezza del
metro può essere diversa quando esso è in movimento, che può cambiare anche
durante l’accelerazione inerente allo spostamento del metro da un punto
all’altro, e che fino a prova contraria la velocità della luce può essere
funzione della velocità o dell’accelerazione. Il giuoco complicato di tutte
queste possibilità ci lascia molto in dubbio sul significato fisico di
postulati come, per esempio, quello secondo cui la velocità
della luce è la stessa nel sistema in movimento e nel sistema in quiete. Per
poter attribuire un significato semplice ai postulati sulla velocità della
luce, sembra che dovremmo avere uno strumento per misurare il tempo, il quale non implichi esso stesso la proprietà della luce. Per far questo
potremmo cercare di
specificare la misura del tempo in termini puramente meccanici, per esempio
mediante le vibrazioni di un diapason o la rotazione di un volano. Ci troviamo però
di nuovo in grandi difficoltà, in quanto dobbiamo ammettere che le dimensioni
del nostro orologio meccanico possono cambiare quando esso viene posto in moto,
e che anche la massa dei suoi componenti può cambiare. Vogliamo usare
l’orologio come strumento fisico per determinare le leggi della meccanica, le
quali naturalmente non sono determinate fino a che non possiamo misurare il tempo, e
troviamo che le leggi della meccanica entrano nel funzionamento dell’orologio
stesso…
I brevi
intervalli di tempo acquistano quindi significato solo in connessione con le
equazioni dell’elettrodinamica, che hanno una validità molto dubbia e possono venir controllate solo in termini delle coordinate spaziali e
temporali che vi compaiono. Incontriamo qui lo stesso circolo vizioso di prima.
Ancora una volta troviamo che ai limiti dell’esperienza attuabile i concetti si
fondono l’uno con l’altro.”
Ma è proprio così disperata la situazione?
Forse le difficoltà nascono solo dal volere
identificare il “concetto” di tempo con
la sua “misura sensibile”. Infatti
per gli antichi (da Pitagora a Newton) queste difficoltà non si ponevano. Per
essi lo spazio fisico era un sistema di punti dove si potevano trasportare i
punti “materiali” da un posto a un altro nello spazio dei punti “dello spazio
vuoto”.
Avendo convenuto che la distanza tra due
punti (materiali) assegnati era, per convenzione, l’unità di misura delle
lunghezze, essa risultava indipendente dal tempo e dalla posizione; infatti
sarebbe senza senso il chiedersi se la distanza tra i due punti che
costituiscono gli estremi del metro campione potrebbe allungarsi per il
trasporto nello spazio e nel tempo. Sarebbe come chiedersi se un’unità possa
essere diversa da una unità?! Se poi si definiscono le aree e
i volumi, rispettivamente, con S =L2
e V = L3,
lo spazio viene a risultare, per definizione, eudideo, come già detto sopra
e quindi omogeneo e isotropo. Un regolo sarà “rigido”, per definizione, se il rapporto con l’unità di misura
resta costante e non ha senso chiedersi se le due lunghezze possano variare
entrambe allo stesso modo dal momento che non avremmo nessun modo per
accorgercene.
Per quanto riguarda il tempo, per gli
antichi, esso non era altro che la misura del movimento e si può dimostrare che
è possibile, operativamente, individuare una misura del tempo che risulti
uniforme. La clessidra degli antichi può ben essere un tale orologio; ma
esaminiamo il problema con un esperimento idealizzato e, quindi,
concettualmente più semplice.
Consideriamo una piccola massa (la chiameremo
una pallina), in caduta libera in un tubo a vuoto di Newton, soggetta
all’accelerazione costante g. Supponiamo che un orologiaio preistorico voglia
costruirsi un orologio che segni un tempo uniforme (chiariremo dopo che cosa
dobbiamo intendere per tempo uniforme dal punto di vista operativo, dal momento
che noi non possiamo trasportare nel tempo la sua unità di misura), senza
nessuna conoscenza preventiva delle leggi della fisica.
Egli comincia col costruirsi due regoli
rigidi graduati, uno per misurare gli spazi percorsi dalla pallina cadendo e
l’altro per misurare i tempi impiegati a percorrerli (supporremo che, al
principio degli esperimenti, i regoli siano graduati allo stesso modo, stante
che l’ingenuo orologiaio, non sapendo niente di fisica, suppone che un corpo in
caduta libera, vicino alla superficie della terra, percorra spazi uguali in
tempi uguali; del resto, questa era la convinzione di Aristotele; ma
l’orologiaio ha solo fiducia negli esperimenti e non è disposto a riconoscere
l’autorità di chicchessia e l’assume perciò come semplice ipotesi da
verificare).
Si accorge subito che, con una sola pallina
che cada lungo i due regoli, posti entrambi verticalmente e vicini tra loro, la
sua ipotesi è sempre verificata. E così prende un’altra pallina identica alla
prima e, facendo partire (da ferma) la prima pallina dalla cima dei regoli, fa
partire la seconda (anch’essa da ferma) dalla metà dei regoli, all’istante in
cui la prima pallina ha raggiunto tale quota.
Se la sua ipotesi fosse vera: le due palme
dovrebbero percorrere la rimanente metà dei regoli nello stesso tempo,
giungendo contemporaneamente (localmente e nello stesso sistema, aggiungiamo
noi, ma l’orologiaio non è in grado di badare a tali sottigliezze, che nemmeno
comprende) alla base dei regoli.
Ma si accorge subito che la sua ipotesi è
sbagliata e, quindi, cancella la graduazione sul secondo regolo che, secondo
lui, doveva fungere da orologio; proponendosi di segnare una nuova graduazione
da trovare sperimentalmente.
Allora, per tentativi razionalmente eseguiti
allo scopo di individuare la quota da cui deve lasciar cadere la seconda
pallina per arrivare alla base contemporaneamente alla prima, può riuscire a
incidere il primo segno sul secondo regolo (usando il metodo dei dimezzamenti
successivi può raggiungere qualsiasi precisione migliore di un qualunque
numero, diciamo p, preventivamente assegnato, con un numero finito di
passi, esattamente n > — ln p / ln 2).
Ripetendo i suoi esperimenti, facendo partire
la prima pallina da quote diverse, può tracciare la nuova scala dei tempi sul
secondo regolo.
Riportando in un grafico le corrispondenti
graduazioni dei due regoli otterrebbe una parabola (in questo caso ideale; nel
caso generale otterrebbe, comunque, una ben determinata curva).
Se ripetendo successivamente l’intero
esperimento troverà la stessa curva concluderà che il suo orologio va bene. Se
(volendo usufruire di un orologio più pratico) si procurasse un fenomeno
periodico che vada d’accordo con la sua graduazione, direbbe che anche il nuovo
orologio segna un tempo uniforme. Se ogni volta che ripete l’esperimento,
invece, trovasse curve diverse, allora direbbe che il suo orologio non va bene,
perché le forze (o cause) in giuoco nel suo fenomeno non sono costanti nel
tempo; ma non perderebbe, per questo, la sua fiducia nella convinzione che il “tempo assoluto” esiste, per cui proverà
con altri fenomeni, magari con la luce; ed è possibile che, anche se non
trovasse il fenomeno adatto, troverebbe il modo di superare l’ostacolo (p. es.
mediando sulle varie curve ottenute in un lungo periodo) non essendoci alcuna
compulsione logica ad abbandonare la sua idea di tempo assoluto, ché la
compulsione, anzi, è in senso contrario, essendo il tempo assoluto, per lui,
una necessità logica, derivante dall’esistenza del movimento, indipendente da
qualsiasi metafisica che si voglia adottare.
Potrà il nostro orologiaio preistorico, che
dopo i suoi esperimenti è diventato un fisico, passare dal suo tempo locale (o,
comunque, quasi locale) al tempo esteso? Se privo di pregiudizi metafisici
potrebbe fare la stessa osservazione di Einstein, naturalmente se fosse portato
a credere che la velocità della luce fosse costante nel suo sistema quando
misurata facendo uso di corpi rigidi e di orologi meccanici.
Sul significato effettivo delle
trasformazioni di Lorentz e della teoria della relatività, cioè se le
conseguenze dipendano solo da una nuova convenzione per misurare lunghezze e
tempi, o se, al contrario, esse comportino una reale modificazione fisica degli
orologi e dei regoli rigidi per effetto del loro movimento, i pareri sono
sempre stati discordi anche per coloro che dichiarano di accettare in toto la
teoria.
Senza schierarci, momentaneamente, per l’una
o per l’altra tesi, esaminiamo alcune conseguenze della teoria sul piano
puramente metrologico.
La relazione che lega tra loro le lunghezze
di un’asta rigida, come misurate dai due classici osservatori della teoria
della relatività ristretta, è data da L’
= γ L.
Poiché γ è una grandezza
adimensionata la relazione può essere scritta
![]()
(avendo indicato con l ed ![]() i valori numerici e con
i valori numerici e con ![]() e
e ![]() le rispettive unità
di misura).
le rispettive unità
di misura).
Noi siamo sempre liberi di includere (vedi Perucca)
il coefficiente γ o tra i valori
(![]() con
con ![]() ) o tra le unità di misura (
) o tra le unità di misura (![]() con
con![]() ) o, anche, possiamo fare altre convenzioni più convenienti a
seconda dei casi e delle nostre necessità.
) o, anche, possiamo fare altre convenzioni più convenienti a
seconda dei casi e delle nostre necessità.
Nel primo caso noi siamo obbligati a misurare
le due grandezze, riferentesi alla stessa asta, con la stessa unità di misura.
Non sapendo se effettivamente i regoli si allunghino per effetto del movimento,
se vogliamo essere sicuri che l’unità di lunghezza sia la stessa, dobbiamo
effettuare le misure nello stesso riferimento e quindi con metodi diversi,
l’una per confronto diretto, l’altra, necessariamente, impiegando segnali
luminosi. Non potremo mai decidere, in questo caso, se il fatto che y sia diverso da 1 sia solo apparenza o
una modifica effettiva delle lunghezze.
Nel secondo caso, si deve supporre, fin dal
principio, che l’allungamento dell’asta in movimento sia effettivo, essendo le unità
di misura vere “grandezze” e non semplici numeri; ma, in tal caso, i valori
misurati dai due osservatori (cioè i “numeri” trovati) risulterebbero sempre
identici nei due sistemi e, quindi, entrambi gli osservatori sono legittimati a
usare la meccanica classica e a non menzionare più il fatto che hanno bisogno
di segnali luminosi per comunicare, perchè il fatto risulterà assolutamente
irrilevante per tutti i loro esperimenti, che ognuno di essi è “obbligato” a
compiere nel suo proprio sistema, non potendo uscirne fuori, in quanto misure
per confronto diretto, sia di distanze che di tempi, si possono fare “solo” nel
“proprio” sistema di riferimento.
Si potrebbe, ancora, pensare che sia: 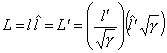 .
.
Lo stesso discorso vale per qualunque altra grandezza.
È utile approfondire la questione a partire
dalle ipotesi con cui vengono derivate le trasformazioni di Lorentz.
Einstein, nel suo primo lavoro sulla
relatività20, comincia con
l’osservare che la teoria che vuole sviluppare “si appoggia, — come ogni altra elettrodinamica — sulla
cinematica del corpo rigido, poiché le dichiarazioni di una di quelle teorie
riguardano i rapporti fra corpi rigidi (sistemi di coordinate),
orologi e processi elettromagnetici. Le non sufficienti considerazioni di questa
circostanza è la radice delle difficoltà con
le quali l’elettrodinamica dei corpi in
moto ha presentemente da lottare.”
Quindi, continua: “Sia dato un sistema di coordinate nel quale valgano (si intende: in
prima approssimazione) le equazioni meccaniche newtoniane. Noi denominiamo
questo sistema ... «sistema in
quiete». Se un punto materiale
è fisso relativamente a questo sistema di
coordinate, la sua posizione relativa a quest’ultimo può venir determinata per
mezzo di aste di misura rigide, impiegando i metodi della geometria euclidea
espressa in coordinate cartesiane.” (le sottolineature sono nostre).
Avendo notato che, nel caso di sistemi in moto rispetto a un ipotetico riferimento in cui si suppone che si propaghi la luce, si devono riscontrare differenze tra le misure di distanza tra due punti, effettuate per confronto diretto con l’asta rigida di misura, rispetto a quelle effettuate misurando il tempo impiegato dalla luce a percorrere la stessa distanza e ciò a causa della difficoltà che si hanno non conoscendo il riferimento in quiete assoluta (ammesso che esista), procede ad estendere la nozione di contemporaneità a grandi distanze. Decide di “definire” la contemporaneità mediante l’istante di tempo che si può trovare divendo per due il tempo impiegato dalla luce per andare e venire da un posto assegnato in cui si suppone posto un orologio che si voglia sincronizzare.
Decide, ancora, che si può fare a meno di un
riferimento in quiete assoluta ed enuncia due postulati:
“1. Le leggi, secondo le quali si modificano gli stati dei sistemi fisici, sono indipendenti
dal fatto che questi cambiamenti di
stato vengano riferiti all’uno
o all’altro di due sistemi di coordinate che si trovano in relativa reciproca traslazione uniforme.
2. Ogni raggio
di luce si muove nel sistema di coordinate «in quiete» con la determinata velocità V,
indipendentemente dal fatto che quel raggio
di luce sia emesso da un corpo in quiete, o da un corpo in movimento. Con ciò è
Percorso della luce
Velocità = _________________________
Durata del tempo
ove «durata del tempo» è da
intendere nel senso della definizione precedentemente data”.
E conclude: “Vediamo dunque che al concetto di contemporaneità non
possiamo attribuire alcun significato assoluto, ma che invece due avvenimenti che, considerati da un sistema
di coordinate, sono contemporanei,
considerati da un sistema mosso relativamente ad esso, non sono più da
considerare come avvenimenti contemporanei.
Ciò è assolutamente vero solo se si specifica
ulteriormente; e precisamente ricordando: “se
conveniamo di misurare tempi e distanze nel modo convenuto”.
In altre parole: la relatività si ha rispetto
ai “mezzi di osservazione” e non
rispetto al “sistema di riferimento”, per
usare (anche se con diversa bipartizione) il vocabolario di Fock, che era
inteso a distinguere tra la relatività della meccanica quantistica da quella
della teoria di Einstein.
Questo slittamento semantico (tra i due detti
modi di intendere l’aggettivo “relativo”)
si avverte in tutto l’articolo di Einstein e lo porta a una derivazione
delle trasformazioni di Lorentz inutilmente complicata e anche sbagliata in
quanto, implicitamente, si fa un’ulteriore e non giustificata ipotesi oltre
alle due esplicitamente enunciate come 1. e 2. di cui sopra; e cioè quella di
scambiare una precisa “ipotesi fisica”, tutta da verificare, per una “definizione” di contemporaneità, per
cui ritiene naturale assumere che due osservatori, in moto relativo, che usino
la luce come mezzo di comunicazione, debbano osservare gli stessi effetti sia
che reciprocamente si avvicinino, sia che reciprocamente si allontanino, cosa
che, invece risulta empiricamente assolutamente falsa, indipendentemente da
qualunque possibile trasformazione di coordinate.
Sulla possibile diversità della nozione di
contemporaneità, in relazione ai diversi metodi empirici di misura, in effetti,
sembra che Einstein abbia presente, in qualche modo, il problema; ma non ci
insiste più di tanto. Infatti, nel considerare il ritardo reciproco tra due
orologi (sincronizzati secondo le sue regole), uno dei quali, dopo avere
percorso una linea chiusa a velocità costante (in modulo), si ritrovi nuovamente
a coincidere con l’altro (questo problema, in seguito all’interpretazione di
Langevin, è diventato il paradosso dei gemelli), Einstein precisa: “Si conclude da ciò che un’orologio che non ha necessità di rimanere
fisso [notiamo qui che secondo
Einstein, sembrerebbe che, quantomeno, si debbano escludere gli orologi che, come
gli orologi a pendolo, dipendano da una proprietà locale, come la gravità, per
funzionare] il quale si trovi
all’equatore, deve procedere
più lentamente di un piccolo importo che
un orologio esattamente eguale e sottoposto a eguali condizioni, che
si trovi al polo”.
Queste parole ci fanno capire che per
Einstein la misura dei tempi è relativa ai tipi di orologi che usiamo. Quindi,
per poter parlare di tempo in astratto, l’alternativa è: o ci riferiamo al
tempo “assoluto” di Newton definito
logicamente e indipendentemente dal modo di come concretamente lo misuriamo; o
specifichiamo esattamente le operazioni concrete con il quale lo misuriamo ed
esso ora sarà “relativo” ai mezzi di
osservazione, cioè se cambiamo il modo di misurarlo dobbiamo trovare la precisa
relazione fisica che lo lega al precedente. Ma questo, ovviamente, vale per
qualunque grandezza fisica e, in particolare, anche per lo spazio, in quanto
considerato come luogo delle posizioni relative dei suoi punti, definite per
mezzo di misure di lunghezza. E ciò non basta: bisognerà, se optiamo per la
seconda possibile scelta, distinguere tra un “tempo locale” e un “tempo
esteso”.
Notiamo, tuttavia, che nei successivi lavori
Einstein semplifica la dimostrazione sulla base della formulazione di Minkovski
e, anche se in modo non esplicito, tenta una giustificazione dell’ipotesi
nascosta, non accorgendosi che dietro il nuovo formalismo quadridimensionale
si nasconde una precisa ipotesi di ordine metafisico (che d’altronde era ben
chiara al Minkovski,21 in un
primo tempo Einstein non aveva capito la necessità della nuova veste matematica
che alla sua teoria aveva dato il suo ex professore e la considerava come “un inutile sfoggio di erudizione matematica”)
che sembra in contraddizione con la teoria delle grandezze; fatto questo
che emerge chiaramente quando si utilizzi il calcolo sulle grandezze come
descritto nei passi soprariportati di Peano e nella Fisica del Perucca già
menzionata.
Vediamo di ricostruire la dimostrazione di
Einstein (ma tenendo conto della teoria delle grandezze, di cui alle citazioni
di Peano e di Bridgmann e come dettagliatamente sviluppata dal Perucca e come
usata da ogni fisico sperimentale).
Svilupperemo una particolare interpretazione
della teoria della relatività (ristretta) proposta da Synge e da questi
esposta con la usuale confusione tra grandezze e numeri,22 confusione che, se potrebbe essere tollerata in
fisica classica, è assolutamente pericolosa nella fisica relativistica, quando
si voglia stabilire il significato fisico delle trasformazioni di Lorentz,
fatto che è confermato dalle infinite proposte interpretative avanzate nel
passato e che si continuano ad avanzare perennemente.
***
Saremo ora costretti ad usare un linguaggio
piuttosto tecnico; quindi, il lettore a cui non siano familiari i simboli
matematici può, se vuole, saltare ai successivi tre asterischi.
Converremo di usare le lettere maiuscole per
indicare le grandezze, le corrispettive lettere minuscole per indicare le
relative misure e le lettere minuscole con un apice ^ per indicare le
rispettive unità di misura.
Useremo le lettere segnate con ′ per
le quantità che si riferiscono al sistema in moto, per distinguerle dalle
corrispondenti quantità nel sistema in quiete.
Supponiamo che i due osservatori O e O′, di cui parla Einstein nel lavoro sopracitato,
scelgano la stessa origine delle coordinate al tempo t′
= t = 0 e decidano entrambi di usare la luce per misurare le distanze
ognuno nel proprio sistema.
Per quanto si può leggere nell’articolo di
Einstein, possiamo dedurre che ognuno dei due osservatori può immaginare di
avere a che fare con spazi e tempi assoluti, nel preciso senso che gli
attribuiva Newton, e non in quello che spesso viene attribuito a Newton
(d’altronde, ipotesi necessaria se si pretende che i due osservatori possano
fare misure per confronto diretto, ognuno all’interno del proprio sistema;
questa assunzione verrà, nei successivi lavori, abbandonata da Einstein perché,
come vedremo subito, è incompatibile con le trasformazioni di Lorentz, quando
non si vogliano fare ipotesi inaccettabili e se si vuole mantenere alla teoria
il suo ruolo di “teoria fisica” e non
quello, puramente estetico, di riscrittura delle equazioni della meccanica).
Per l’ipotesi della relatività, come
formulata nella 1., basterà considerare solo quello che può dedurre il primo
osservatore, in quanto il secondo ragionerà esattamente allo stesso modo.
Come già abbiamo avvisato, useremo l’aggettivo
“assoluto” nel senso newtoniano e
cioè quello definito da regoli rigidi, che si possono trasportare; e di tempo
uniforme e indipendente dallo spazio. Non supporremo, però, l’esistenza di uno
spazio assoluto in “quiete assoluta”.
Sia P la
posizione (“assoluta”) al tempo T (“assoluto”) di una particella materiale
secondo il primo osservatore. Sia O l’origine
delle sue coordinate ed O′ la posizione dell’origine delle
coordinate del secondo osservatore, come vista dal primo osservatore.
Per il primo osservatore, dal momento che il
suo spazio è euclideo e che tempi e distanze sono misurate con operazioni
indipendenti, si ha:
![]()
Se poniamo:
![]()
possiamo scrivere:
(1) ![]() .
.
Siano ora R e T le coordinate (spaziali e
temporali) di un evento dato per O.
Supponiamo che, all’istante opportuno Tp, O lanci un segnale
luminoso verso R. Sarà ricevuto al tempo ![]() (avendo posto R = | R | e C = | C | ). Sarà di
ritorno al tempo
(avendo posto R = | R | e C = | C | ). Sarà di
ritorno al tempo ![]() .
.
Calcolerà:
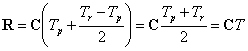
Secondo le vedute di O, perché O′ possa ricevere, propriamente, il segnale di ritorno, O′ dovrà lanciare il segnale al tempo T1, istante in
cui si troverà in una certa posizione R1
(come misurata da O),
tale che il segnale possa giungere in R al tempo
(2) ![]()
ed essere ricevuto, di ritorno da O′, al tempo
(3) ![]() ,
,
essendo R2
la posizione di O′ al tempo T2.
Ricordiamo che R1, R2,
T1, T2 si intendono tutte
misurate nel riferimento di O. Per
trovare più semplicemente le relazioni opportune tra le varie grandezze poniamo:
(4) ![]() .
.
Naturalmente si ha:
(5) ![]() .
.
Da (2),
(3), (4) si ha:
(6) ![]()
(notiamo che per O l’intervallo
di tempo impiegato dal segnale per andare da O′ a R è diverso dal tempo
impiegato per ritornare in O′, il primo intervallo sarà maggiore o minore del secondo a seconda
che O e O′ si allontanino o si avvicinino reciprocamente).
Avendo posto:
(7) ![]() ,
,
per somma e sottrazione delle due equazioni in (6), si ottiene:
(8) ![]()
(9) ![]() .
.
Dalle definizioni di D ed S si trova:
(10) ![]()
e ancora, tenuto conto delle definizioni precedenti:
(11) ![]() .
.
da cui
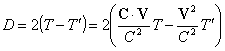
e, quindi, anche:
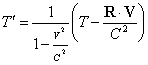
Se usiamo le stesse unità di misura per
misurare V e C, si avrà: ![]() e quindi:
e quindi:
(12) ![]() .
.
Per il principio di relatività, O immagina che il secondo osservatore
scriverà
(13) ![]() ,
,
che per la (12) può scriversi:
(14) ![]() ,
,
ricordando che per (1), (5), (13) si ha
![]() .
.
e quindi
![]() ,
,
la (14) si può scrivere:
(15) ![]() .
.
Le formule precedenti, per il modo in cui
sono state ricavate, obbediscono ai due postulati di Einstein e alla sua definizione
di contemporaneità.
Vediamo se i due osservatori possono
scegliere unità di misura tali da ottenere le trasformazioni di Lorentz.
Sostituendo alle grandezze le loro
espressioni in termini di valori e di unità di misura e ponendo (come è necessario
per non violare il principio di relatività):
![]() e
e ![]() ; e ponendo, ancora,
; e ponendo, ancora, ![]() , vediamo quali ipotesi ulteriori dobbiamo fare per scrivere
le trasformazioni di Lorentz relative alle quantità numeriche.
, vediamo quali ipotesi ulteriori dobbiamo fare per scrivere
le trasformazioni di Lorentz relative alle quantità numeriche.
Le (15),(12) diventano:
(16) ![]() ,
,
(17) ![]() ,
,
se poniamo, per convenzione, ![]() e
e ![]() ,
(notiamo che con tale scelta i valori numerici della velocità relativa e della
velocità della luce non possono coincidere per i due osservatori, — cioè
,
(notiamo che con tale scelta i valori numerici della velocità relativa e della
velocità della luce non possono coincidere per i due osservatori, — cioè ![]() e
e ![]() — a meno che non si abbia γ = 1) otteniamo
— a meno che non si abbia γ = 1) otteniamo
![]() ;
;
e, infine, avremo:
(18) ![]() ,
,
(19) ![]() .
.
Queste non sono esattamente le trasformazioni
di Lorentz, infatti, quando si sceglie per entrambi i sistemi, l’asse x come
direzione della velocità relativa si ottiene:
![]() ,
,
invece di
![]() .
.
Ma le formule usuali (più corrette?!) si
possono facilmente ottenere cambiando leggermente le convenzioni, decidendo di
scegliere, nella direzione del moto, unità di misura diverse da quelle di tutte
le altre direzioni, arrivando alle formule usuali:23
(20) ![]()
(21) ![]() .
.
***
In linea di principio, “non abbiamo alcun
modo di verificare le convenzioni che abbiamo fatto sulle unità di misura”, perché
riguardano un “impossibile” confronto diretto tra due sistemi in movimento
relativo. In teoria, potremmo verificare la coincidenza, anche per osservatori
in moto qualsiasi, tra spazio tattile e spazio ottico (ma questo è un altro
problema che non ha niente a che vedere con il primo che, come abbiamo detto,
non è verificabile per sua natura). Si ritiene che l’esperimento di Michelson e
Morley abbia deciso questa questione. Ma molti in passato hanno contestato il
risultato dell’esperimento, alcuni contestandone l’accuratezza dal punto di
vista sperimentale, altri contestandone la teoria usata per predire il
risultato dell’esperimento, nel senso che alcuni (in particolare il Righi24) hanno mostrato che usando
correttamente il principio di Huygens si deve ottenere (classicamente) il
risultato che effettivamente è stato trovato sperimentalmente. Altri ancora
negando che l’esperimento possa avere qualcosa a che fare con il problema in
discussione.
L’impressione che si ricava, leggendo la
letteratura odierna sull’argomento, è che l’accordo tra teoria ed esperimento
sembra essere diventato solo una questione di fede, come la materia del
catechismo con il quale ho cominciato il mio discorso.
Ma, in ogni caso, l’esperimento di cui sopra,
quando lo si voglia interpretare come una prova della coincidenza dei due spazi
(ma su questo si possono avanzare serissimi dubbi), non cambierebbe niente
sulle convenzioni riguardo alle unità di misura, che bisognerà sempre fare; al
massimo, potrebbe solo dire che non esistono osservatori privilegiati.
Ecco perché, in seguito, Einstein (dopo la
formulazione puramente “geometrica” di
Minkovski) abbandona ogni riferimento alle diverse operazioni di misura nei due
sistemi di riferimento e si limita a postulare l’invarianza del
quadrintervallo, del quale non v’è alcun cenno nel primo articolo.25
Successivamente è costretto ad asserire:26 “Né il punto dello spazio, né l’istante del tempo in cui qualcosa
accade, hanno una realtà fisica, ma soltanto l’evento in
se stesso. Non vi è alcuna relazione spaziale assoluta, cioè indipendente dallo
spazio di riferimento, né alcuna
relazione temporale assoluta tra due
eventi, ma vi è soltanto una relazione assoluta nello
spazio e nel tempo, cioè indipendente dallo spazio di riferimento, come
apparirà nel seguito.”
Sul perché Einstein volesse ritrovare ad ogni
costo le trasformazioni di Lorentz non c’è dubbio alcuno, perché lo stesso
Einstein dichiara che il suo scopo principale era quello di trovare le stesse
trasformazioni sia per i fenomeni elettromagnetici che per quelli meccanici,
dando la preferenza ai primi, essendo per lui inconcepibile, anche a livello
emotivo, l’idea dell’azione a distanza. Infatti, già molto tempo prima del
Lorentz, era stato dimostrato dal Voigt27
che quelle trasformazioni (ora chiamate di Lorentz) rendevano invariante
l’equazione del moto di una perturbazione locale, in un mezzo non dispersivo,
propagantesi con velocità costante, trasformazioni valide anche per i fenomeni
meccanici (a parte il valore della velocità di propagazione) e non solo per
l’elettromagnetismo (ammesso che si possa trovare un modello fisico, quindi
sperimentalmente verificabile, a partire da misure di grandezze fisiche e non a
partire da non misurabili — senza l’intermediario delle prime — quantità numeriche);
quindi, alla fin dei conti, Einstein voleva eliminare le particelle dal
linguaggio della fisica; e dobbiamo dire che c’è riuscito, a costo di ulteriori
complicazioni che, probabilmente, ci costringono ad abbandonare completamente
la teoria delle grandezze, con buona pace dei fisici sperimentali e degli
antichi scienziati.
Ma, comunque, ci restano i numeri di Dedekind
e di Cantor e la geometria di Hilbert e possiamo continuare a vivere beati con
la consolante filosofia platonico-aristotelica, tanto deprecata da Bacone,
ingiustamente, perché non apprezzava i discorsi consolatori!
L’esportazione di tale particolare metafisica
della matematica ai problemi della gravitazione universale ci ha condotto al di
là di ogni ragionevole immaginazione.
Gli antichi Cinesi cui accennava Peano nella
citazione che abbiamo sopra riportato, hanno scoperto il raggio del mondo
mediante l’osservazione.
Ma noi moderni siamo riusciti a scoprire,
addirittura, il raggio dello “spazio”, senza bisogno di osservare alcunché, con
la sola potenza del pensiero.
Per poter parlare di fisica finora ci sono
bastati i numeri di Dedekind; ma, per poter parlare cli economia politica,
occorrerà ricorrere ai numeri transfiniti di Cantor.
Un bel giorno, un mio amico economista mi ha
chiesto se, per caso, ero in grado di spiegargli quella strana matematica che
si impiega nella teoria dei “beni pubblici”.
Mi ha detto che il valore di un bene pubblico
era una quantità proporzionale ai benefici, che pare che siano una misura della
soddisfazione che ogni cittadino prova nell’usufruire del bene pubblico; mi
portava l’esempio, allora, della base missilistica di Comiso, figurarsi la mia
soddisfazione! La cosa strana, e che d’altronde bisognava capire, era come mai
questa quantità, la stessa per tutti i cittadini, poteva mai risultare uguale
alla loro somma.
Gli ho detto che, forse, il beneficio del
cittadino veniva calcolato dividendo il costo dell’opera per il numero degli
abitanti. Mi ha detto che ciò era impossibile; ché egli, se fosse stato così,
l’avrebbe facilmente capito.
A riprova mi ha mostrato diversi libri ed
articoli di riviste dove si poteva leggere:28
![]() .
.
Gli ho detto che quelle strane quantità
potevano solo essere i numeri transfiniti di Cantor o i numeri non standard di
Robinson, e quindi per me non erano quantità, ma semplici sciocchezze.
Il mio amico se ne è andato, sicuramente
pensando, e sicuramente a ragione, anche se non me l’ha detto, che io non
capivo un bel niente nè di economia, nè di matematica; perché era assolutamente
impossibile che a qualcuno avessero potuto dare il premio Nobel per l’economia
(mi ha detto che glielo avevano davvero dato; a dire il vero, io non mi sono
sorpreso del fatto) per avere inventato delle semplici sciocchezze.
Molti ripetono che la scienza moderna si
occupa solo di “fatti” e che le teorie sono vere solo se spiegano i fatti.
Non è chiaro il significato di “fatto” e
nemmeno quello di “spiegazione”; gli epistemologi le hanno inventate tutte!
È noto che teorie assolutamente false e
contraddittorie possono spiegare i fatti, anzi “tutti” i fatti (specialmente se
i fatti si inventano di sana pianta, in effetti sembra difficile oggi
distinguere tra fatti e modelli; c’è chi ci ha scritto sopra libri interi). E
qualcuno, invece, pensa, ed io tra questi, che quello che conta non sono i
fatti ma la loro interpretazione (basta pensare ai “fatti” che oggi succedono
nel Golfo Persico).
Si dice che Keplero abbia scoperto le sue
famose leggi perché, in base alla sua filosofia mistico-religiosa, era convinto
che i pianeti, nel loro volgere, suonassero una bellissima armonia secondo le
migliori regole del contrappunto.
Newton si è valso di tali leggi per una
filosofia tutta diversa.
Ma è divertente, in proposito, un aneddoto
personale che, allora, mi fece venire molti pensieri sul ruolo delle teorie; a
me, che ero completamente digiuno di epistemologia.
Ero fresco della mia laurea in fisica e un
mio amico mi ha voluto presentare un suo conoscente che voleva investire del
denaro per sfruttare l’invenzione di un contadino che si vantava di avere
inventato un dispositivo che, automaticamente, suonava l’allarme in caso di
fughe di gas in un luogo chiuso.
Il giovane imprenditore pretendeva che, date
le competenze che egli pensava che io dovevo possedere, bisognava che lo
accompagnassi per verificare se il contadino non avesse avuto, per caso,
l’intenzione di imbrogliarlo; diceva, oggi non ci si può più fidare di nessuno!
Spinto anche dalla curiosità sono andato in
una casa di campagna nei dintorni di un paesino etneo, insieme all’imprenditore
ed al nostro amico comune.
Il dispositivo, che il contadino ci ha
mostrato, funzionava veramente. Aprendo una bombola di gas faceva suonare un
campanello del tipo di quelli che si usano negli ingressi di casa.
Ho cercato di capire come funzionasse il
marchingegno e ho pregato il contadino di aprire la scatola che lo conteneva.
Era di una semplicità estrema! Dentro la scatola metallica a forma di
parallelepido, fatta con delle latte di conserva, c’era, sistemato nel mezzo,
un mattoncino di un impasto terroso, che aveva l’apparenza di essere stato
indurito al sole e che divedeva la scatola in due parti uguali. Una parte
comunicava con la bombola di gas, mediante un tubicino di gomma. Dall’altra
parte della scatola era sistemato un relè che, per effetto della pressione del
gas sulla parete di latta della scatola, chiudeva un circuito elettrico che
azionava la suonerìa. E questo era tutto!
Nonostante la strana teoria fisica del
contadino, mi è parso di capire che l’oggetto essenziale doveva essere quello
strano mattoncino terroso.
Infatti sapevo (l’avevo letto nel libro di
Fisica del Perucca) che ci sono dei materiali che sono, nei processi di
diffusione, selettivi per i diversi gas, a seconda del loro peso molecolare.
Per cui ho pensato che il mattoncino poteva
ben essere impermeabile all’aria ma permeabile al butano della bombola. Questo
faceva aumentare la pressione nello scomparto dove stava il relè, che chiudeva
il circuito, così azionando la suoneria.
Ma qualunque fosse la corretta teoria fisica
per la spiegazione del fenomeno, la cosa più strabiliante per me fu la teoria
con la quale, invece, il contadino era riuscito nell’impresa, dopo dieci anni
(così egli diceva) di innumerevoli tentativi falliti.
Secondo il suo racconto, il tutto cominciò in
seguito alla morte del fratello a causa di una fuga di gas. Egli decise che
bisognava inventare qualcosa per impedire tali accidenti. Da dove partire? La
sua teoria era molto semplice: nel mondo ci sono due forze contrastanti, da una
parte il bene, rappresentato dall’angelo e, dall’altra il male, rappresentato
dal diavolo. Fin qui capivo, mi ricordavo della maestra di catechismo.
Senza alcun dubbio il fratello era morto a
causa del diavolo che aveva approfittato del fatto che nei luoghi chiusi e
specialmente in presenza del gas, che era “il male”, l’angelo, che
rappresentava “il bene”, non poteva certamente stare.
Quindi, per prima cosa, bisognava creare una
situazione in cui l’angelo potesse essere presente anche se separato dal
diavolo.
Ecco l’idea della scatola divisa in due
comparti nettamente separati, il tubo del gas, ovviamente, dalla parte del
diavolo e il campanello d’allarme, altrettanto ovviamente, dalla parte
dell’angelo.
Ma la prova non funzionò, forse perché: se i
due stanno nettamente separati non possono azzuffarsi. E la lotta tra il bene e
il male è essenziale per la buona riuscita dì ogni cosa (mi viene ancora da
pensare alla guerra del Golfo).
Bisognava trovare il setto divisorio adatto.
Dieci anni ci son voluti per trovarlo, ma ci è voluto anche l’intervento della
provvidenza divina.
Un giorno si trovava alle foci
dell’Alcantara. Aveva camminato a piedi nudi e sentiva il bisogno di lavarseli
li, sull’argine. Era una bella giornata. Notò il colore del fango in riva al
fiume; era bellissimo, bianchiccio; non aveva mai visto un fango di un colore
così bello e delicato. Un fruscio di arbusti là vicino lo avvertì che
finalmente aveva trovato quello che cercava. Il fruscio degli arbusti era la
voce del Signore.
Svuotò la gavetta del suo mangiare e la
riempì di quella poltiglia miracolosa. Lungo la strada del ritorno andò
ruminando sul come fare indurire quella poltiglia. Una forma adatta e il sole
sarebbero bastati.
Dopo qualche prova il marchingegno funzionò e
ora egli era pronto a far fruttare la sua invenzione che aveva avuto anche la
benedizione di Dio.
Ho concluso che tutte le teorie sono buone a
spiegare i fatti sperimentali, anzi a produrre invenzioni in qualche modo
commerciabili.
Da allora ho preteso che le teorie
scientifiche, per essere tali, non dovevano limitarsi a spiegare i fatti o a
produrre invenzioni.
La coerenza sintattica non mi bastava più.
Pretendevo la coerenza semantica; e ... non solo!
Avrei pure preteso la coerenza totale con la
mia visione del mondo; ma, sfortunamente, quest’ultima non la si può
pretendere dagli altri e la scienza dovrebbe, invece, essere oggettiva, nel
senso che non dovrebbe essere influenzata da quest’ultimo fattore. Non so come
risolvere questa contraddizione, chissà se mi potrebbero aiutare i numeri
transfiniti.
Ho capito, in seguito, che tutti vogliono
escludere quest’ultimo fattore dalla scienza. Ma il guaio è che identificano
l’oggettività proprio con la propria personale visione del mondo o con quella
degli uomini più influenti.
Non so più se può esistere una scienza che
possa fare a meno della fede, come prima ingenuamente pensavo.
Il mio diavolo mi ha messo nei guai e non
sono riuscito a trovare l’angelo, come invece è capitato al fortunato contadino
inventore.
Catania, 20/2/1991.
NOTE
- A. Eddington, Space,
time and gravitation, Harper, 1959.
TORNA
- A. Einstein, L. Infeld, L’evoluzione della
fisica, Einaudi, 1953, p. 233 e segg. TORNA
- Per alcune importanti critiche registratesi nel
passato cfr. A. Pagano, Su di un’opera dimenticata di fisica di Boggio
e Burali-Forti, Mondotre/Quaderni, Ott. 1989, Siracusa; e anche il suo
articolo in questo stesso numero dei Quaderni. TORNA
- G.Peano, Opere Scelte, vol. II, Ed.
Cremonese, Roma, 1958, p. 117. TORNA
- G.Peano, Opere Scelte, vol. III, op.
cit., p. 268; M. Pieri, Opere sui Fondamenti della Matematica, Ed.
Cremonese, 1980, p. 455. TORNA
- Scriveva Bacone nel Novum Organum: “Oggi la
filosofia naturale non si trova nella sua forma pura ma è infettata e
corrotta: nella scuola di Aristotele per mezzo della logica, nella seconda
scuola di Platone, di Proclo e consoci per mezzo della matematica, tali
strumenti devono portare a compimento la filosofia naturale e non
generarla o procrearla”. TORNA
- Osserviamo che se si divide un triangolo
rettangolo isoscele con un segmentoche divide in due l’angolo retto si
vengono a formare due altri triangoli rettangoli isosceli uguali tra loro
e, quindi, ciascuno di area metà del primo. Questo fatto, insieme alla
definizione di area di un triangolo, implica che la somma degli angoli di
un tale triangolo è uguale a due retti. Ma, come già il Saccheri ha
dimostrato (cfr. R. Bonola, La Geometria Non-Euclidea, Zanichelli,
1906, p. 25-26), se tale proprietà vale in un caso varrà in tutti i casi e
risulterà valido il postulato delle parallele. La maggior parte dei
commentatori moderni nega la validità delle dimostrazioni del Saccheri e
del Wallis, e di molti altri antichi commentatori dell’opera di Euclide.
L’argomento col quale si nega la validità di tali dimostrazioni è
oltremodo divertente: invece di partire dagli assiomi di Euclide, come
facevano gli antichi commentatori, si parte, invece, dagli assiomi di Hilbert!
È banale osservare che qualunque dimostrazione può risultare valida o non
valida se si cambiano gli assiomi.
TORNA
- Opere Scelte, vol. III, op. cit., p. 141. TORNA
- Cfr. N. I. Lobačevskij, Nuovi principi
della geometria, Boringhieri, 1974, p. 39. TORNA
- Ibidem, p. 61-63.
TORNA
- Oggi si chiama: geometria non-euclidea
iperbolica. TORNA
- Cfr. Hertz, Miscellanous
Papers, Vol. III, Principles of Mechanics, Macmillan,
1896. TORNA
13. “Caeterum harum potestatum, nempe motus, vis, ... ,
quantitas duplici ratione aestimatur;
utpote vel secundum intensionem earum vel extensionem” =
“Inoltre queste quantità, cioé moto, forza, ... , si possono considerare in modo duplice, cioé sia secondo l’intensione,
sia secondo l’estensione”. Cfr. Newton, De gravitatione et equipondio fluidorum, Unpublished
scientific papers of Isaac Newton, Cambridge Univ. Press,
1962. TORNA
14. Operazioni sulle grandezze, in Opere
Scelte, vol. III, op. cit., p. 435 e segg. TORNA
15.
Altro nome usato da Lobačevskij per la sua
geometria. TORNA
16.
Per ulteriori dettagli in questioni di metrologia cfr. E.
Perucca, Fisica Generale e Sperimentale,
I, UTET, 1949, p. 5-90. TORNA
17. P. W.
Bridgman, La logica della fisica moderna,
Einaudi, 1952, p. 98-99; Bridgman ha ricevuto il premio Nobel per le
importanti sue ricerche sperimentali nel campo delle fisica dei materiali alle
altissime pressioni ed è stato sempre attento ai problemi epistemologici; nel
libro di cui sopra, nella prefazione, leggiamo: “Questa escursione nel dominio della critica dei fondamenti, da parte
di uno scienziato le cui attività si sono
finore limitate quasi totalmente al campo delle esperienze, non dipende da un
decadimento senile, come qualche
spregiudicato potrebbe supporre. Ho sempre sentito, nel corso dei miei lavori sperimentali, l’esigenza impellente
di una migliore comprensione dei fondamenti del nostro
pensiero fisico, e per molto tempo ho tentato
in modo più o meno sistematico di
raggiungere questa comprensione. ... Nonostante
i precedenti scritti sui fondamenti della
scienza in genere, di Clifford, Stallo,
Mach e Poincaré, per non citare altri, credo che un nuovo saggio critico non abbia bisogno di giustificazione”; perché, come dice
nell’introduzione: “Una delle novità più notevoli della fisica recente è il cambiamento di
atteggiamento verso quello che si può chiamare l’aspetto interpretativo
della fisica. Si va riconoscendo sempre più, sia negli scritti che nelle
conversazioni dei fisici, che il mondo degli esperimenti non è comprensibile
senza un esame dello scopo della fisica e della natura dei suoi
concetti fondamentali. ... Il fisico
medio tende ad evitare di interessarsi a tali questioni ed a liquidare le speculazioni dei colleghi
definendole “metafisiche”. …Tuttavia la crescente reazione in favore di una
maggiore intelligenza dei fondamenti interpretativi della fisica ... rappresenta ... una nuova tendenza cominciata senza dubbio con la teoria einsteiniana
della relatività ristretta.” TORNA
18. Op.
cit., p. 73-84. TORNA
19. A
proposito di questo argomento toccato qui dal Bridgman, scriveva Einstein nel
1922 (cfr. A. Einstein, Il significato
della relatività, Einaudi, 1955, p. 37): “Si critica spesso la teoria della relatività perché
attribuisce senza giustificazione un’importanza concettualmente preminente alla
propagazione della luce, in quanto fonda il concetto del tempo sulla legge della propagazione della luce. La cosa
sta tuttavia pressappoco in questi termini. Per attribuire un significato
fisico al concetto di tempo si richiedono processi che permettano di stabilire delle relazioni fra posti differenti. Non ha importanza quali tipi di
processi si scelgano per una tale definizione
del tempo, ma è teoricamente vantaggioso scegliere soltanto quei processi sui
quali si conosca qualcosa di sicuro. Ciò vale per la propagazione della luce
nel vuoto in una misura maggiore che per qualunque altro processo che si possa
considerare, grazie alle indagini di Maxwell e di H. A. Lorentz.” Ma su quest’ultimo punto, in seguito, Einstein ha cambiato opinione,
infatti: “Le 12 décembre 1951, presquè à
la fin de sa vie, il écrivait ce qui suit á son vieil ami Michele Besso, avec qui, jadis, au Bureau des brevets,
il avait discuteé ses idées naissantes:
«Cinquante ans à ruminer sans trêve, et me voici sans plus
de réponse qu’au premier jour á la question de savoir ce que sont les quanta de
lumiére. De nos jours, Pierre, Paul ou Jacques s’imagine qu’il a une réponse, mais il se trompe.»”, tratto da: Banesh
Hoffman, Albert Einstein, créateur et
rebelle, Édition du Seuil, 1975, p. 203.
TORNA
20. A.
Einstein, Zur Elektrodynamik bewegter
Körper, Annalen der Physik, 17, 1905, p. 891; vedi la traduzione in
italiano di P. Straneo riportata in: Cinquant’anni
di relatività, (a cura di Pantaleo), Universitaria Editrice, Firenze,
1955. TORNA
21. In una
sua lezione, tenuta nel 1908, Minkowski comincia: “Le concezioni su spazio e tempo, che vorrei sviluppare per voi, sono
cresciute sul terreno fisico-sperimentale. … D’ora in avanti lo spazio in sé e
il tempo in sé sono destinati a sprofondare completamente nell’ombra e solo una
specie di loro commistione potrà mantenere un’esistenza autonoma.” TORNA
22. J. L. Synge, Relativity: The
special theory, North Holl. Pu. Co., 1956. TORNA
23. Le
equazioni vettoriali (20) e (21) si possono trovare in A. Katz, Classical Mechanics, Quantum
Mechanics, Field Theory, Academic Press, 1965, p. 167. TORNA
24. A.
Righi, Nuovo Cimento, XVI, p. 213,
1919. Potrebbe sembrare strano che nessuno mai abbia fatto riferimento a questo
lavoro né per contestano né per approvarlo, ma secondo la teoria di Kuhn questa
sarebbe giusto la norma. TORNA
25. Tale
ipotesi equivale all’assunzione di Einstein, che a un certo punto è costretto a
fare per ritrovare le trasformazioni di Lorentz, di equivalenza tra osservatori
in moto di avvicinamento o in allontanamento reciproco. Nella formulazione in
coordinate di Einstein (e di tutti i posteriori autori) questo potrebbe
sembrare un semplice cambiamento di coordinate; ma, in effetti, come risulta
ovvio in un linguaggio “assoluto” (cioè senza l’inutile intermediazione delle
coordinate), è un fatto fisico indipendente dalla scelta del sistema di
coordinate. Spesso tra i “giustificazionisti” viene confuso con le proprietà di
invarianza per trasformazioni di coordinate, relative a un’operazione di
“riflessione” nello spazio-tempo. Questa confusione viene favorita da un
linguaggio assolutamente inadeguato, e perciò mistificante, che include le
“riflessioni” nel “gruppo completo delle rotazioni”. Come al solito, da Hilbert
in poi, una generalizzazione di natura assolutamente formale viene ad assumere
significato fisico per effetto di un abuso di linguaggio! Ecco a che cosa serve
quello che Einstein credeva essere “un inutile sfoggio di erudizione matematica”! Ed Einstein niente
potrebbe mai obiettare a Minkowski, il quale gli risponderebbe: se vuoi trovare
le trasformazioni di Lorentz è inutile complicare le cose con la fisica e con
le grandezze; basta assumere che vogliamo trasformazioni “di coordinate” che
formino “gruppo” o, equivalentemente, che sia invariante il quadrintervallo;
poi, eventualmente, ci sforzeremo di appioppare un qualche significato, più o
meno fisico, a quest’ultimo oggetto che è matematicamente ben definito! Fra
l’altro, così facendo, daremo un gran lavoro agli inventori di giustificazioni,
basterà che non parlino di grandezze fisiche omogeneee, o, se proprio ne
vorranno parlare, le identifichino con i numeri di Dedekind; e si limitino a
parlare di “esperimenti ideali” fatti con parole e con simboli senza significato
fisico, basterà dirli definiti “operativamente”. TORNA
26. Cfr. Il significato della relatività, op.
cit. TORNA
27. W. Voigt, Über das Doppler’sche
Prinzip, Nachirichten der Königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu
Göttingen, 10 März 1887. TORNA
- Gli increduli possono consultare The new
Palgrave – A dictionary of economics a pag. 1061. TORNA