Riflessioni
sulla didattica della fisica
Angelo Pagano
1.) Premessa
Alcuni giorni fa mi son ritrovato in una
riunione di amici, quasi tutti docenti di fisica (o comunque di materie
scientifiche) nei licei.
L’argomento principale di discussione era
l’angustia dei programmi ministeriali per l’insegnamento delle scienze e
l’inedeguatezza dei libri di testo. Giudicati entrambi assolutamente
inadeguati per la società odierna.
Interpellato dissi che anche all’università,
a mio giudizio, la situazione non era molto più entusiasmante.
Pensavo, infatti, che l’insegnamento e,
soprattutto, la ricerca nelle discipline scientifiche, avrebbero dovuto essere
indirizzati, principalmente, sulla questione ambientale, che mi pareva e mi
pare il problema fondamentale e il più urgente da risolvere oggi, pena la
sopravvivenza stessa del genere umano su questa terra.
Con mia grande sorpresa i miei amici mi
dissero che non era affatto a questo che essi stavano pensando. Sentivano, invece,
la mancanza di adeguate conoscenze sui settori moderni della fisica e citavano,
come esempio, la teoria della relatività, che, a loro dire e a giudizio di
tutti i più grandi fisici del presente, è la più fondamentale delle teorie
fisiche, insieme, naturalmente, alla meccanica quantistica.
Come ho già detto la cosa mi ha sorpreso e mi
ha fatto modificare un po’ alcune decisioni che avevo preso qualche giorno
prima.
Infatti avevo già maturato l’idea di scrivere
qualcosa, per i quaderni di Mondotre, sulla questione ambientale, ma questa
esigenza dei miei amici, che essi ritenevano essere molto più diffusa di quanto
io potessi ritenere, mi ha fatto cambiare obbiettivo. Tuttavia mi son
ripromesso di tornare in un futuro, che spero non molto lontano, sul primo
problema.
Io avevo già scritto qualcosa sulla
relatività1 ma ho sentito il
bisogno di tornare ancora sull’argomento, questa volta sotto la prospettiva
didattica.
Spero sinceramente di poter dare un piccolo
contributo all’esigenza che sopra ho prospettato; anche se temo di tradire le
aspettative dei miei amici, dal momento che non condivido affatto il loro
entusiasmo per la detta teoria.
Questo perché mi son convinto, anche e
soprattutto attraverso quel po’ di ricerca storica che ho dovuto fare per
preparare i due articoli di cui alla precedente nota, che il problema non è
solo di inadeguatezza dei libri di testo e dei libri di divulgazione
scientifica, anche se scritti da illustri scienziati, i quali, con la scusa di
rendere più semplici le cose ad un più vasto pubblico di lettori, si lasciano
spesso andare a banali luoghi comuni, assolutamente inaccettabili per chi
volesse riflettere solo per un momento, abbandonando per un po’ il reverenziale
timore nei confronti dell’autorità del grande scienziato, e volesse meditare un
pochino di più sulle conseguenze e sull’utilità di quanto viene impartito a
scuola o all’università, al fine di non dare ai giovani l’impressione che la
scienza non giovi per capire il mondo che ci circonda, ma solo per far apparire
possibili i miracoli.
Qualche giovane particolarmente sensibile
potrebbe porsi la domanda: se la scienza non giova a capire, a che giova far
scienza?!
Per questo penso che sia urgente ridare
all’insegnamento e ad ogni libera espressione del pensiero la più grande
dignità.
Forse il problema è anche di intrinseche
difficoltà della teoria stessa.
Nel seguito intendo mettere a fuoco alcuni
punti che, pur della massima importanza e delicatezza, vengono spesso
insegnati e divulgati senza alcun riferimento alla critica intelligente e
positiva, che pure vi è stata in passato e che continua a registrarsi nel
presente, nei confronti di alcuni problemi connessi con la comprensione della
teoria che, lungi dall’essere banali, meriterebbero ancora oggi una particolare
attenzione.
La questione può essere posta in questi
termini.
Nell’insegnamento della relatività (sia
speciale che generale) sovente si forniscono ai discenti delle formule matematiche
che vengono presentate come leggi fisiche, senza aver prima introdotto la
fondamentale distinzione fra legge e modello. Si afferma, contestualmente, che
tali supposte leggi sono verificate sperimentalmente e, a sostegno, si citano
taluni esperimenti considerati “fondamentali”.
Non si fa nessuno sforzo per vedere se tali
esperimenti non siano anche interpretabili all’interno della teoria
newtoniana, che ancora oggi costituisce il primo approccio degli studenti con
le teorie fisiche.
Rendendo, così, un cattivo servizio sia
all’insegnamento della meccanica newtoniana, che viene spesso banalizzata, che
a quello della relatività, che viene, il più delle volte, sprofondata dentro un
profluvio di parole incomprensibili, e non solo per i poveri studenti!
2.1.) Un
po’ dì cronaca del passato
La teoria della relatività, come in seguito è
stata rielaborata, non è più quella che Albert Einstein ebbe a proporre in un
famoso suo articolo del 1905.
Essa si è venuta modificando per far fronte,
da un lato, alle numerose critiche che ebbe sin dal suo nascere e, dall’altro
lato, per sottrarla ai salotti ed ai circoli culturali piccolo borghesi, che se
ne erano ìmpadroniti, rimettendola, in qualche modo, nel “sacro tempio della
scienza”, secondo i canoni della scientificità di un’epoca che sembra ormai
passata.
Come tutte le teorie scientifiche, che si
presentano come innovatrici sul piano filosofico, essa ebbe molti oppositori
negli ambienti scientifici tradizionali. Mentre, a differenza di quanto oggi si
possa pensare, la teoria trovò entusiastici consensi al di fuori del campo
della scienza, cioè tra giornalisti, filosofi, circoli culturali ecc..
Il successo delle nuove e sconvolgenti idee,
al di fuori degli ambienti che tradizionalmente si sogliono considerare scientifici,
fu di tale intensità da provocare persino il giustificato risentimento di
eminenti scienziati dell’epoca.
Sono sintomatiche le parole che si possono
leggere in un intervento dell’illustre scienziato francese Bouasse sulla
rivista Scientia:2
“Quando
Fresnel immaginò che l’etere vibrasse come un solido e, grazie a questa ipotesi, fondò l’ottica moderna, la Gazette de France non credette opportuno
di informarne il mondo intero.
E quando
Faraday mostrò che i dielettrici non sono degli
isolanti inerti, proposizione dalla quale scaturì la telegrafia senza fili, il
Times non innalzò inni di lode.
Quando, più
recentemente, J. J. Thomson propose la sua teoria degli elettroni, rimettendo
in causa i fenomeni di conducibilità nei gas,
il pubblico non ne fu informato.
Eppure la
gloria dell’Einstein uguaglia quella del Carpentier e del Siki Battling. I
periodici sono pieni dei suoi ritratti; le belle signore fanno la coda per vederlo; passa
da una tourné all’altra come un’attrice e si fa la ressa per incontrarlo. Evidentemente,
come si suole dire a Toulouse, ci si trova dinnanzi a un di più o a un di meno!
La ragione di
questa gloria, che io credo effimera, risiede nel fatto che la teoria di Einstein
non rientra nel quadro delle teorie fisiche: essa è una ipotesi metafisica che, per di più, è incomprensibile; doppia ragione per giustificarne il
successo.
Che Bergson,
illustre filosofo, parteggi per Einstein, è naturale ma è indifferente al
dibattito. Credo che ci sia troppo buon senso in giro per ammettere che in
questa materia la sua opinione possa avere il benché minimo valore: non andremo
certo a chiedergli di spiegarci a cosa serve una teoria fisica e che cosa da questa ci si deve attendere.
Non siamo
particolarmente turbati da quelle galanti manifestazioni di cenacoli culturali,
dove un ex primo ministro funge da uscere raccogliendo i biglietti d’invito, mi
riferisco all’Illustration dell’Aprile 1922. Gli applausi frenetici di una
cotale enorme quantità di incompetenti non aggiungono niente all’accettabilità o meno
dell’ipotesi.
Poco importa
che matematici ed astronomi la tengano in cosi gran conto tanto da trattarci da
beoti o da conformisti
piccolo-borghesi, e che finiscano con l’insinuare che siamo buoni solo per la carrozzella e per le chiacchiere inutili.
Tutte queste
gentilezze ci lasciano indifferenti perché, alla fine, noi fisici sperimentali, avremo
l’ultima parola …”.
Il Bouasse, che a giudizio di Peano,3 “ha il coraggio delle proprie opinioni”, ben dipinge l’atmosfera
dell’epoca: euforica accettazione della teoria da parte di quanti nulla avevano
a che vedere con il quotidiano lavoro del ricercatore di fisica.
Questa testimonianza viene a confermare
quanto ho già avuto modo di notare in precedenza, negli articoli sopra citati,
cioè che il successo della teoria di Einstein sia dipeso, in larga misura, dal
fatto che l’ambiente socio-economico, agli inizi del ventesimo secolo, era
ormai dominato da un paradigma empirista e fenomenologista, che ben si sposava
con l’efficientismo economico di un capitalismo sempre più aggressivo.
Ma, naturalmente, Bouasse non fu l’unico ad
opporsi contro l’accettazione acritica della teoria della relatività come teoria
fondamentale della fisica.
Moltissimi altri illustri fisici criticarono
più o meno aspramente la teoria.
Il dibattito tra fautori e detrattori si
mantenne a livelli di massima intensità e di grande polemica fino a circa la
fine degli anni quaranta. Poi, poco a poco, la polemica scese di tono fino a
scomparire quasi del tutto. Forse in seguito alla naturale estinzione fisica
dei sostenitori del vecchio paradigma. Lo stesso Planck era dell’opinione che
un nuovo paradigma scientifico può solo affermarsi solo quando siano morti i
rappresentanti della filosofia precedente.
Il lettore che volesse farsi un’idea più
precisa delle idee salienti che circolavano intorno alla “questione
relativistica” negli anni 1920-1930 può consultare i fascicoli della rivista Scientia a partire dall’anno 1923. Vi si
possono rintracciare le opinioni dei più famosi scienziati dell’epoca (quali
Fabry, Somigliana, Castelnuovo, Eddington, Levi-Civita, La Rosa, Fubini e tanti
altri ancora), ai quali la rivista aveva offerto esplicitamente l’occasione di
esprimere liberamente le loro opinioni in merito.
2.2) La
didattica della relatività
Quando per la prima volta lessi il libro
dell’illustre prof. Eligio Perucca, già famoso docente dell’Università di
Torino, fui colpito dalla mancanza, in quella pur ponderosa opera, di un
capitolo riguardante la moderna teoria della relatività.4
Una tale mancanza fu giudicata gravissima,
sin dalla pubblicazione della prima edizione, da parte di colleghi ed allievi
del Perucca. L’autore nella prefazione alla seconda edizione scrive
testualmente:
“Dei
suggerimenti, dei benevoli appunti di Colleghi e Lettori ho fatto tesoro. Ma
non ho potuto, ad esempio, accogliere l’amichevole consiglio, rivoltomi da un
mio caro e chiaro Collega, che avrebbe voluto un posto per la Meccanica relativistica nel mio trattato. Evidentemente il mio amico e Collega volle attribuire al mio libro una portata che l’autore, pur
nella sua immodestia, non osò assegnargli. Perciò il mio libro si rinnova senza
Relatività.”
Queste parole mi sembrano assai significative
e, a mio giudizio, forse non dicono tutto.
In effetti, il libro del Perucca, a
differenza della generalità dei più moderni libri di fisica generale,
finalizzati esplicitamente all’insegnamento, dedica ampio spazio alla
metrologia.
In quelle pagine si può apprendere con
profitto l’arte “di misurare” con accuratezza e precisione; arte che dovrebbe
essere il bagaglio naturale del fisico.
La teoria delle grandezze fisiche è ivi
espressa con tale chiarezza da non lasciare dubbi sul perché l’autore, a mio
avviso, non può trattare la teoria della relatività.
Questa infatti fonda tutta la sua brillante
forza persuasiva col lavorare con dei simboli che non possono, in alcun modo,
rappresentare delle grandezze, secondo la definizione del Perucca; la quale,
del resto, coincide con quella universalmente concepita dai fisici
sperimentali.
In breve, credo di poter dire che la
relatività non sta nel libro del Perucca semplicemente perché non ci può stare,
a prescindere dal fatto che l’autore potesse considerare qualche formula della
teoria come valida relazione di natura fenomenologica.
Il suo inserimento avrebbe richiesto la
cancellazione automatica, ma anche paradossale, della teoria delle grandezze
fisiche che, è bene ribadirlo, non è fisica “classica” o “quantistica” o
“relativistica”; ma, se così mi è permesso dire, è al di sopra di qualsiasi
teoria o paradigma. Essa rappresenta l’essenza stessa della fisica, strumento
irrinunciabile per la conoscenza sperimentale.
Ma cosa è una grandezza fisica?
Seguiamo il Perucca:
“Grandezza
fisica è ogni ente utile per la descrizione dei fenomeni fisici e suscettibile
di definizione quantitativa, cioè di misurazione”.
Quando si rifletta un poco e ci si accordi
sul significato da attribuire al concetto di misurazione, si può dire che un
ente, diciamolo a, è una grandezza se, presa ad arbitrio una quantità
numerica, diciamola q, si ha che il prodotto q ´ a (che significa: si prenda q
volte a) è ancora una grandezza, che, p. es., chiameremo b.
Il numero
q si dice misura o valore di b rispetto ad a.
“Grandezza fisica” è il nome di una classe.
Uno qualsiasi dei suoi membri può essere
preso, ad arbitrio, per misurare un’estensione. La scelta della grandezza unità
è un fatto di pura convenienza e comodità.
Questa definizione di grandezza, già nota ai
pitagorici, è con chiarezza espressa da Euclide e da Archimede.
Dai postulati fondamentali della teoria delle
grandezze discende che queste godono della proprietà dell’“additività”, allo
stesso modo delle quantità numeriche.
Siano a, b, due grandezze
omogenee tra loro (cioè tali che sia possibile determinare una quantità
numerica q in modo che si abbia a = q ´ b); siano qa , qb , le loro rispettive
misure, relativamente alla grandezza unitaria u; o, in simboli, sia a
= qa ´ u e
b = qb ´ u ; sia α una
quantità numerica (numero reale), si può definire il prodotto della grandezza
fisica per il detto numero ponendo: α ´ a uguale alla grandezza che si
ottiene facendo α qa ´ u (dove tra α e qa è sottinteso il segno del normale prodotto tra
numeri).
Si definisce, invece, la somma c = a
+ b ponendo c = (qa + qb)
´ u (dove la somma tra numeri si
intende nota).5
Le grandezze dunque rappresentano un esempio
di quello che i matematici definiscono astrattamente come “spazio lineare”,
anzi ne è l’archetipo.
Esempi di grandezze fisiche sono: la massa,
la carica, il tempo, la lunghezza, l’energia, la quantità di moto, ecc.
Ora, se si accetta l’interpretazione che oggi
viene data delle formule relativistiche, sarà necessario ammettere che gli
enti con cui si opera in relatività non godono della proprietà di additività,
la quale caratterizza le grandezze fisiche. Esempi ne sono la massa
relativistica di un corpo e la sua velocità.
Soffermiamoci un momento sul concetto di
massa di un corpo.
Il Landau nel suo famosissimo e diffusissimo
libro di fisica teorica6 afferma
che:
“…mc2
non è uguale alla somma Σa mac2
(ma sono le masse delle particelle) e, di conseguenza, nemmeno
m è uguale a Σa ma.
Quindi nella meccanica relativistica la legge di conservazione della massa non
sussiste: la massa di un corpo composto non è uguale alla massa dei suoi componenti…”.
Ovviamente analoghe affermazioni si ritrovano
per la velocità, il tempo e così via.
Se si accetta l’interpretazione del Landau
(che comunque, è bene precisarlo, è la stessa di quella che viene data dalla
maggior parte dei libri di testo) si è costretti ad ammettere che o la massa
relativistica non è una grandezza fisica oppure che la massa di cui si parla in
relatività è solo l’“apparenza della massa”, per usare il linguaggio
parmenideo.
La prima ipotesi porterebbe la relatività
immediatamente fuori dal quadro delle teorie fisiche. La seconda ipotesi
porterebbe a giustificare la validità empirica di certe formule della
relatività, nel dominio di certi fatti sperimentali, come semplice
manifestazione di particolari correlazioni tra grandezze, tra le quali, ma non
necessariamente, vi possono essere le masse come intese da Newton, cioè come
quantità di materia.
Tali correlazioni si manifestano in
dipendenza delle particolari operazioni fisiche che facciamo per misurarle. La
relatività verrebbe ridotta a pura “fenomenologia”, eventualmente in grado di
riassumere una, più o meno grande, collezione di fatti. Dunque essa si
risolverebbe in tassonomia, cioè semplice “classificazione” di fatti e non
potrebbe pretendere di fornire una “spiegazione” del mondo fisico.
Da questo punto di vista, la teoria di
Einstein si piazzerebbe più nella tradizione della fisica scaturita da Platone
e da Aristotele piuttosto che in quella tradizione di filosofia naturale che
scaturisce da Pitagora e Democrito.7
È bene avvertire che la “fenomenologia” può
risultare estremamente utile, e possibilmente anche sufficiente, per le
applicazioni pratiche della conoscenza scientifica (tecnologia); ma tradirebbe,
presa da sola e in sostituzione, gli scopi stessi della scienza come intesa
dagli antichi scienziati, cioè come “filosofia naturale”.
La quale ultima, quanto meno, ha sicuramente
maggior valore euristico della pura fenomenologia e rappresenta la molla
essenziale per il progresso della scienza, con lo stesso grado, ma con insostituibile
ruolo, col quale la fenomenologia costituisce lo strumento essenziale per lo
sfruttamento della scienza.
Parlando di relatività non si può fare a meno
di citare il punto di vista del Bridgman, che viene considerato il padre
dell’operazionismo moderno:8
“La relatività
ristretta di Einstein ha dato un grande
contributo nel raggruppare e coordinare i fenomeni in modo che essi possano
venire abbracciati tutti da una formula matematica semplice, ma non sembra
averli presentati sotto una luce tale che sia semplice o facile coglierli
fisicamente. L’aspetto esplicativo manca del tutto nel lavoro di Einstein ...”.
Ma ora soffermiamoci su alcuni punti
particolari, sui quali la critica è stata più sensibile nel passato.
2.3) Energia
e massa
Analizziamo per prima la questione della
massa relativistica un po’ più in dettaglio.
Scegliamo ancora il Landau come libro di
riferimento, anche perché è ritenuto uno tra i migliori libri di testo
esistenti.9
Partiamo dalla famosa formula della
relatività speciale valida per una particella non soggetta a forze:
(2.3.1)  .
.
In essa c
è la velocità della luce, v è la
velocità della particella, m0 viene
chiamata la “massa a riposo” del corpo, E
sarebbe l’energia totale della particella che, per v = 0, diventa
l’energia a riposo E= m0c2.
È istruttivo vedere come gli autori sopra
citati pervengono a tale risultato.
Sotto opportune ipotesi, che gli autori richiedono
per il momento di accettare, viene ricavata l’espressione della “lagrangiana
relativistica”, come applicazione del principio di minima azione; quindi si
scrive:10
![]() ,
,
con il parametro α caratteristico della
particella data.
La dimostrazione della formula (2.3.1)
procede come di seguito qui indicato.
Poiché, in meccanica classica, la particella
è caratterizzata dalla sua massa m0
bisogna trovare il legame tra α ed m0. Per trovarlo si imponga la condizione che al limite
per c tendente all’infinito si
debba ottenere la lagrangiana classica ![]() .
.
Sviluppando in serie la lagrangiana relativistica si ha:
![]() .
.
A questo punto è bene rifarsi direttamente
alle parole del libro:
“Come si sa i
termini della funzione di Lagrange che rappresentano una derivata totale rispetto al tempo non sono essenziali e li si può omettere. La costante che compare nello sviluppo si può dunque omettere nell’espressione di L.” (Si
faccia attenzione a quest’ultima frase perché la più importante per il nostro
discorso).
Avendo trascurato la costante, per ottenere
l’espressione classica, basta porre α = m0c e si ottiene:
![]() ,
,
che è l’espressione cercata per la lagrangiana.
A questo punto, seguendo l’impostazione
analitica che gli autori hanno dato al loro corso sin dal primo volume, si
determina l’impulso, p, della particella libera a partire dalla
definizione ![]() e si trova:
e si trova:
 .
.
E, allo stesso modo, definendo l’energia
secondo l’espressione:
![]() ,
,
ed eseguendo i facili calcoli si trova l’espressione (2.3.1) per
l’energia della particella libera.
Se si pone v = 0 si deve ottenere l’energia a “riposo” della particella:
(2.3.2) E = m0 c2
Ma si dimentica, ed è quanto qui volevo far
notare, che la lagrangiana era stata definita a meno di una funzione arbitraria
del tempo e dunque, per lo meno, a meno di una costante (cosa che, del resto,
gli autori ci avevano, opportunamente, fatto notare quando avevano voluto
ottenere il limite classico).
Se dunque riteniamo che la lagrangiana è
determinata a meno di una costante, chiamiamola k, ponendo k = - m0 c2, possiamo
ottenere E= 0; ponendo k = - 2 m0 c2
otterremo,
invece, E = - m0 c2 e così via di seguito potremo ottenere tutti i
valori che vogliamo.
Ma la “piccola” omissione del Landau si
propone effetti sconvolgenti. Infatti, come si potrebbe altrimenti insegnare
agli studenti, e futuri insegnanti, che “la
massa a riposo di una particella misura la quantità totale di energia ivi
contenuta”?!
Per le ipotesi fatte la sola cosa che si può
asserire è:
Δ E = Δ mc2
e ci resta ancora da sapere che cosa significhi Δ m. Certamente
non può essere la variazione di quantità di materia, newtonianamente intesa; ma
può ben essere una variazione di massa inerziale, che è cosa ben diversa dalla
prima, come il banale esempio di una sfera che rotola su di un piano inclinato
mette in mostra.
Il lettore a questo punto obietterà che non
bisognerebbe essere eccessivamente formalisti, poiché il “piccolo imbroglio” è
giustificato dall’esigenza di rendere semplice la dimostrazione di una legge
che, soprattutto nel campo della fisica nucleare, ha ottenuto numerose evidenze
sperimentali. (Ma a che servono le dimostrazioni che non dimostrano?!)
Infatti la formula espressa dall’eq. (2.3.2)
conduce naturalmente al teorema (detto, molto spesso, “principio”) di
equivalenza massa energia, che si ritiene ampiamente provato dall’esperienza,
anche tragica (penso alla bomba atomica).
Come si sa, non vi è nulla di più arduo che
combattere le “evidenze di fatto”. Il lettore segua il ragionamento che di
seguito espongo e poi giudichi senza pregiudizi.
Consideriamo, all’interno dello schema
newtoniano, un corpo pensato come un insieme di n particelle elementari (cioè piccoli corpi idealizzati come punti
massa) interagenti tra loro, e supponiamo che non vi siano forze esterne.
L’energia totale del corpo è:
E = T + U
con T l’energia cinetica e U l’energia potenziale; o, più
esplicitamente:
(2.3.3) ![]() ,
,
con: Ui j = Uj i ,
ma Ui j = 0 per i=j .
Introducendo la velocità, V (V2 =V2), del baricentro del sistema,
potremo separare l’energia cinetica macrosopica del corpo dall’energia cinetica
interna:
(2.3.4) ![]() ;
;
dove abbiamo indicato con ![]() la massa totale del
corpo.
la massa totale del
corpo.
Indichiamo con Eint = Tint + U, l’energia totale interna del
corpo e definiamo la grandezza ![]() , che chiameremo “massa efficace” del corpo.
, che chiameremo “massa efficace” del corpo.
L’energia totale diventa:
(2.3.5) E
= Tcorpo + mc2 .
Ci proponiamo ora di determinare il guadagno (o
perdita) di energia cinetica macroscopica che si potrebbe ottenere da un
processo di scissione di un corpo A in
due corpi B e C (A ® B + C).
Applicando la (2.3.5) otteniamo:
(2.3.6) TA + mA c2 = TB + mB c2 + TC + mC c2 ;
e dunque:
(2.3.7) D T = (TB
+TC) - TA = [(mB +mC) - mA] c2 .
Supponendo di aver misurato le masse efficaci in gioco (o di conoscerle in base a un qualche opportuno modello), possiamo ottenere facilmente il guadagno di energia cinetica macroscopica della “reazione”.
Da questo esempio possiamo concludere che,
all’interno dello schema newtoniano, sarebbe possibile spiegare un processo di
fissione nucleare. Allora il problema sarebbe solo quello di verificare
sperimentalmente se tali variazioni di energia cinetica macroscopica sono
esattamente quelli previsti dalla relazione massa energia relativistica.
I primi esperimenti ideati per la “verifica
sperimentale” dell’equivalenza massa energia, furono riportati nel 1933 da K.
I. Bainbridge.11
Nel suo articolo vengono discussi gli
esperimenti di (a) Cockcroft - Walton e di (b) Lewis - Livingston - Lawrence.
Il primo esperimento, (a), consisteva nel
bombardamento di bersagli di Litio 7 con protoni (nuclei di idrogeno) con
un’energia12 incidente di 270 K eV. Come risultato di questi
bombardamenti si osservavano, in uscita, due particelle alfa che percorrevano
una distanza in aria di 8.4 cm. In base al percorso delle particelle si stimava
che esse dovevano possedere un’enegia cinetica di 8.6 M eV.
Si supponeva di descrivere il processo
considerato con l’equazione simbolica:
1H + 7Li ® α + α .
Moltiplicando per due l’energia della
particella alfa e sottraendone l’energia cinetica del protone incidente, veniva
stimato un guadagno di energia cinetica pari a 16.9 M eV.
Applicando la relazione di equivalenza massa
energia D E = D mc2 e supponendo noto il valore
della costante c (che nell’articolo
non viene dato) si stimava una differenza di massa di 0.0182 unità di massa
(nella scala basata sull’ ossigeno 16).
Si accettavano i valori sperimentali delle masse del protone e della
particella alfa come dati da Aston (che, però, non vengono indicati)13 e quella del litio come data
dallo stesso Bainbridge (7.0146 ± 0.0006);
si otteneva una differenza di massa di 0.018 che veniva giudicata in
“soddisfacente accordo” con le predizioni della formula relativistica di
equivalenza massa energia.
Il secondo esperimento (b) riguardava il
bombardamento del Litio 6 con deutoni (nuclei di deuterio). In questo caso si
osservavano due particelle alfa di “percorso” differente: 8.2 cm e 14.8 cm,
rispettivamente. L’energia incidente era di 1.33 M eV.
Anche in questo caso si stimava l’energia
delle particelle alfa mediante i loro percorsi. Tuttavia, in base ai dati
sperimentali disponibili, veniva determinata l’energia della particella alfa di
maggiore percorso, il cui valore era dato in 12.5 M eV. Assumendo il processo di disintegrazione
6Li+ 2H ® α + α
e, supponendo valida la legge di conservazione dell’impulso, si
calcolava un guadagno in energia di 23.7 M
eV. Applicando l’equivalenza massa energia anche in questo caso, si
otteneva un differenza di massa di 0.025. Assumendo i valori delle masse di
Aston (per le alfa) e di Bainbridge (per il Litio), si calcolava, in questo
caso, una differenza di massa di 0.023, che veniva giudicata, questa volta, “in
non soddisfacente accordo” con la relazione di equivalenza massa energia. Il
Bainbridge, a conclusione dell’articolo sottolineava che, per verificare meglio
il “disaccordo”, sarebbe stato necessario effettuare un test più stringente,
ammesso che fosse stato possibile avere una più precisa relazione empirica tra
energia cinetica e “percorso delle alfa”.
A parte il fatto che, come abbiamo visto
sopra, la validità della relazione di equivalenza massa energia può solo essere
confermata con un errore massimo stimato non minore dell’8%, notiamo che ci si
trova di fronte a due esempi che dovrebbero, in teoria, corrispondere alle
condizioni ideali richieste per l’applicazione della relazione di equivalenza
in esame.
Tutti gli altri esempi di questo tipo che si
potrebbero portare, anche i più recenti, si prestano alle stesse critiche.
In tali esperimenti si cerca la variazione di
energia cinetica del moto dei baricentri dei corpi (nuclei) mediante la
conoscenza delle loro masse, come determinate empiricamente, tramite un
processo di misurazione, che concisamente chiameremo Om.
Ora, se si verifica che differenti operazioni
del tipo Om danno
differenti valori di m, ciò
significa, dal punto di vista operativo, che la “massa” che si misura non è una
grandezza fisica associata al corpo in esame ma dipende in modo essenziale
dalle operazioni fisiche che bisogna compiere per determinarla. Operazioni
diverse potrebbero dare valori diversi. Per esempio, per il difetto di massa
del protone, 1H,
si danno i seguenti valori:14
[8.130 - Mattauch (1940)], [8.128 - Cohen et
al. (1947)], [8.128 - Bainbridge (1948)], [8.169 - Roberts (1951)], [8.141 -
Ewald (1951)], [8.146 - Collins et
al. (1951)], [8.142 - Li et al. (1951)].
Un’analisi degli errori più probabili (che
qui si omette per brevità, rimandando al libro dell’Evans) con cui i diversi
autori dicono di poter determinare le tre cifre significative dopo il punto,
rivela che, come dice l’Evans, “i valori
più probabili sono spesso mutuamente inconsistenti, e di molte volte l’errore
probabile ad essi assegnato” ed,
ancora, che “queste incertezze
vanno fuori l’errore probabile assegnato sulla base della riproducibilità
statistica dei risultati. Esse (incertezze) sono dunque dovute ad errori
sistematici sconosciuti relativi alla particolare tecnica usata”.
Analoghe osservazioni valgono per le masse
del litio, deuterio, elio, e di tutti gli elementi conosciuti.
Non migliore, o addirittura peggiore, sembra
essere la situazione in altri campi dove si arriva ai valori delle masse, a
partire dai dati sperimentali, attraverso l’intermediazione di poco
controllabili approssimazioni, sulla base della teoria quanto - relativisica
dei campi.
È chiaro dunque che le verifiche sperimentali
dell’equivalenza tra massa ed energia, come quella illustrataci
dall’esperimento del Bainbridge, dipendono in larga misura dagli effettivi
valori usati per le masse. Per lo stesso sistema si può dichiarare un
“soddisfacente accordo” oppure un “non soddisfacente accordo” dal momento che
non è per niente chiara l’origine di quelli che Evans chiama “errori
sistematici sconosciuti”.
Dal punto di vista dell’analisi newtoniana,
che sopra abbiamo schizzato, tale origine sconosciuta potrebbe risultare,
invece, molto chiara. Infatti il difetto di massa Δ m verrebbe a
dipendere dalle particolari configurazioni interne dei nuclei. A parte i
disturbi apportati al sistema atomico nel suo complesso (nuclei ed elettroni)
che sono sicuramente non trascurabili e dello stesso ordine di grandezza di Δ m.
Dalle precedenti considerazioni si può concludere
che le masse, di cui si parla in fisica nucleare, non sono certamente le
quantità di materia, newtonianamente intese, bensì delle masse efficaci. Questa
supposizione è resa ancor più plausibile se riflettiamo sul modo con cui esse
vengono determinate.
Una rilevante quantità dei valori delle masse
tabulati sono stati ricavati facendo uso della formula di equivalenza massa
energia (per es., il valore di 8.142, già citato e dovuto a Li et al.). Dunque
devono essere considerate delle masse efficaci che non possono valere come
conferma dell’equivalenza; che, tuttavia, innescano un processo a circolo
chiuso, cioè tautologico, e non si verrebbe più a capire se la relazione massa
energia è una legge fisica o una semplice definizione, banalmente vera per necessità
logica.
Alcuni valori di massa vengono ottenuti con
metodo diretto, sfruttando l’azione combinata di campi elettrici e magnetici.
Un atomo di carica q viene accelerato
mediante una differenza di potenziale ![]() e si scrive l’equazione
per l’energia cinetica:
e si scrive l’equazione
per l’energia cinetica:
(2.3.8) ![]()
successivamente, il sistema atomico viene sottoposto all’azione di un
campo magnetico H e si impone
l’uguaglianza fra forza di Lorentz e forza centrifuga:
(2.3.9) ![]() ,
,
essendo R il raggio di
curvatura e B = μ H l’induzione magnetica.
Dalle misure di ![]() , B, R si ricava il
rapporto
, B, R si ricava il
rapporto![]() , dal quale, supponendo noto il valore di q, si ottiene m. La teoria degli esperimenti è, in effetti,
molto più complicata di quella qui delineata. Ma l’essenza è data dalle formule
(2.3.8 e 2.3.9).
, dal quale, supponendo noto il valore di q, si ottiene m. La teoria degli esperimenti è, in effetti,
molto più complicata di quella qui delineata. Ma l’essenza è data dalle formule
(2.3.8 e 2.3.9).
Quello che qui voglio sottolineare è il fatto che, nello sviluppo della teoria, anche in questo caso, si trascurano completamente i moti interni del sistema atomico, le sue dimensioni e la sua forma, supponendoli ininfluenti, il che equivale a trattare il sistema atomico come un punto massa.
Questo, classicamente, può essere fatto solo
sotto opportune ipotesi sulle forze esterne (loro eventuale riducibilità ad
un’unica forza agente nel baricentro, ecc.) e sotto opportune altre ipotesi
sulla struttura dei legami interni (se corpo rigido oppure no, ecc.).
In base a quanto detto, è chiaro che le
misure di massa eseguite con strumenti che usano le filosofie sopra illustrate
danno una massa che non necessariamente è la somma delle masse dei costituenti;
e un’analisi classica potrebbe rendere conto delle frequenti deviazioni che
invece vengono attribuite a non spiegati errori sistematici.
Le prove sperimentali che si portano a favore
dell’equivalenza massa energia difficilmente possono essere considerate come
necessariamente a favore della teoria relativistica e, in ogni caso, non
possono contraddire la teoria newtoniana.
2.4) La
luce ed il campo elettromagnetico
Come oggi è dai più riconosciuto, la
relatività di Einstein non nacque da esigenze di carattere sperimentale, ovvero
da fallimenti della teoria newtoniana, presunti o reali che essi siano. Ma, piuttosto,
essa ripone le sue origini nell’esigenza di conciliare le nozioni di spazio e
di tempo che sembrano essere diverse quando si passa dalla meccanica newtoniana
alla teoria elettromagnetica di Maxwell -
Lorentz.
Einstein crede di individuare nella teoria
elettromagnetica, piuttosto che nella teoria newtoniana dei corpi, il cardine
fisico e filosofico per l’interpretazione del mondo fisico.
Leggiamo ancora uno stralcio tratto dal libro
di Bridgman:15 “Praticamente tutto il nostro pensiero
intorno ai fenomeni ottici si impernia su un’invenzione, mediante la quale
questi fenomeni vengono assimilati a quelli dell’esperienza meccanica ordinaria e così resi più
accessibili all’intelligenza…
…Dal punto di
vista operativo è privo di senso l’attribuire una realtà fisica alla luce nello spazio
intermedio (cioè tra sorgente e rivelatore) e bisogna riconoscere
che la luce come cosa che viaggia è soltanto un’invenzione…
…Questa idea
della luce è fondamentale in tutto lo svolgimento della relatività ristretta”.
In effetti se si analizza l’opera
dell’Einstein, indipendentemente dalle possibili deviazioni interpretative, si
deve concordare con il Bridgman che Einstein ha in mente l’idea di un campo
come substrato reale a cui ricondurre persino il significato di corpo o di
massa.16
Per Einstein la luce è qualcosa che viaggia e
non è un semplice modello. Egli crede che le equazioni del campo
elettromagnetico di Maxwell siano “Le
Leggi” per antonomasia. Ciò è confermato dallo stesso17 quando, rispondendo alle critiche ricevute sul
ruolo preminente che la velocità della luce assume nella sua teoria, asserisce
che la luce è il fenomeno che meglio conosciamo, grazie alle indagini di Maxwell
e Lorentz.
Questo punto di vista, certamente
“metafisico”, intorno al significato da attribuire alle equazioni di campo, lo
condurrà naturalmente ad assegnare alle trasformazioni di Lorentz
un’importanza fondamentale, molto al di là di quella che, molto più
modestamente, tali trasformazioni sembrano indicare.
Per capire meglio la questione è bene
ricordare, brevemente, il significato delle cosiddette equazioni di Maxwell - Lorentz.
Maxwell propose le sue equazioni come riassunto
delle leggi empiriche, e quindi macroscopiche, dell’elettromagnetismo. Per
ragioni di pura simmetria formale e assumendo la conservazione locale della
carica elettrica, introdusse una nuova grandezza fisica, che si usa chiamare corrente di spostamento. Tale ipotesi
fisica apre il campo alle radioonde (brillantemente confermate dagli
esperimenti di Hertz); ma, cosa più importante dal punto di vista teorico,
unifica i fenomeni ottici con quelli elettromagnetici; per cui la velocità
della luce, usualmente misurata “cinematicamente”, viene ad essere legata in
modo univoco alle costanti dell’elettricità e del magnetismo. Questo permette
una misura “statica” di c. (In
effetti, l’accordo tra i due tipi di misurazioni non è così buono rispetto a
quello che si potrebbe pretendere data la precisione con la quale tali misure
possono essere eseguite. Anche su questo punto ci sono state e ci sono
contestazioni).
Tali equazioni fenomenologiche non sono
invarianti per le cosiddette trasformazioni di Galileo, a differenza delle
equazioni di Newton, come si scrivono in un riferimento assoluto.
Ma, finché le equazioni di Maxwell si
interpretano come leggi macroscopiche, non si vede nessun problema in questo
fatto; nessuno può pretendere che le medie statistiche si debbano comportare
come le grandezze microscopiche.
L’idea di interpretare microscopicamente le
equazioni di Maxwell si deve a Lorentz, il quale fra l’altro nella sua teoria
dell’elettrone è il primo a ricavare le equazioni macroscopiche da quelle
microscopiche.
Per far questo deve fare parecchie
approssimazioni. Oggi la critica che viene fatta a tale derivazione è che: si
parte da equazioni che sono invarianti per trasformazioni di Lorentz, e quindi
sono “relativistiche”, si procede poi “non relativisticamente” e quindi si deve
imporre “per postulato” che quelle macroscopiche siano in accordo con le
trasformazioni di Lorentz.18
A questo punto le equazioni di Maxwell,
interpretate microscopicamente, non sono più delle leggi fenomenologiche, ma
diventano “principi fondamentali” della fisica e si pone il problema della loro
compatibilità con i “principi altrettanto fondamentali” della meccanica.
Si è creduto e si crede che l’esperimento di
Michelson - Morley neghi la possibilità di “spazi” diversi per i fenomeni
elettromagnetici e per i fenomeni meccanici. Per cui le ipotesi relativistiche
di Einstein sono la sola ancora di salvezza.
Indipendentemente dalla validità e dal
significato dell’esperimento di Michelson-Morley, che discuteremo in seguito,
c’è, primariamente a nostro giudizio, da chiedersi: è vero che le equazioni
che descrivono i fenomeni meccanici debbano sempre essere invarianti per
trasformazioni di Galileo?
Su questo punto ci possono essere parecchi
dubbi! Daremo ora un esempio, che qualche volta viene riportato sui libri di
testo, ma senza menomamente accennare alla sua connessione con il problema che
stiamo esaminando.
L’equazioni di Maxwell-Lorentz modernamente si scrivono (nel sistema di Gauss
razionalizzato) così:19
(2.4.1) ![]()
(2.4.2)
div B = 0
(2.4.3) 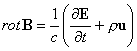
(2.4.4) div E = ρ
dove c è una costante avente le dimensioni di una velocità, nota
come “velocità della luce nel vuoto”, e ρu è il vettore
densità di corrente definito come il prodotto tra la densità di carica e la sua
velocità (in effetti, in uno schema microscopico, è una somma di singolarità).
Si postula l’equazione di continuità:
(2.4.5) ![]() .
.
Le relazioni (1-4) viste come equazioni nelle
incognite E e B, con le assegnate funzioni ρ e u,
e sotto opportune condizioni, sono risolvibili univocamente.
Noto il campo elettromagnetico E, B
in tutto lo spazio, l’equazione del moto di una particella di massa m e carica q sufficientemente piccola, tale da non alterare il campo già dato,
si scrive mediante la consueta forza di Lorentz:
(2.4.6) ![]()
essendo p,v, rispettivamente, impulso e velocità della
particella soggetta al campo di forze.
Si può far vedere che le relazioni formali di cui sopra si possono scrivere anche nell’ambito della teoria classica delle particelle.
Si consideri un sistema di riferimento S
rispetto al quale valgano le tre leggi della dinamica di Galileo-Newton.
Supponiamo data una distribuzione di cariche
di densità ρ funzione di punto e
supponiamo che questa distribuzione sia fissa nel riferimento S; sia ![]() il potenziale
newtoniano associato. L’equazione del moto di una particella di massa m e carica q si scrive allora:
il potenziale
newtoniano associato. L’equazione del moto di una particella di massa m e carica q si scrive allora:
(2.4.7) ![]() ;
;
si ha (teorema di Gauss):
(2.4.8)
div
grad ![]() = ρ .
= ρ .
Se in luogo del sistema S consideriamo
il sistema di riferimento S ′ , che si trovi in moto rotatorio
rispetto ad S, l’equazione del moto acquista la forma:
(2.4.9) 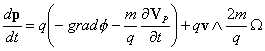 ,
,
dove VP e Ω hanno i ben noti significati
di velocità di trascinamento e di velocità angolare, per le quali si ha:
(2.4.10) VP
= Ω Ù r
(2.4.11)
rot VP = 2Ω ,
dove r = P — O
è il raggio vettore di P rispetto
ad un punto fisso in S sull’asse di istantanea rotazione.
Definiamo:
(2.4.12) ![]()
(2.4.13) ![]()
(2.4.14) ![]()
(2.4.15) B
= rot A ,
la costante arbitraria c ha
le dimensioni di una velocità; ![]() ed A si
possono chiamare, in analogia alla teoria dei campi, potenziali,
rispettivamente, scalare e vettore.
ed A si
possono chiamare, in analogia alla teoria dei campi, potenziali,
rispettivamente, scalare e vettore.
Queste posizioni ci permettono di scrivere in
forma più concisa l’equazione
(2.4.9):
(2.4.6′) ![]() ,
,
che possiamo chiamare forma di Lorentz delle equazioni del moto della
particella, in un campo di forze come visto dal sistema S ′. Inoltre, dalle definizioni (2.4.13) e (2.4.14),
tenendo conto delle proprietà degli operatori rot e div si ottiene:
(2.4.1′) ![]()
(2.4.2′) div B = 0.
Applicando l’operatore div alla (2.4.14) si ottiene:
![]() ;
;
e notando che:
(2.4.16) div
VP = div (Ω Ù r) = r × rot Ω - Ω × rot r ,
con
(2.4.17) rot
Ω = 0 ,
supponendo Ω indipendente da P. D’altra parte:
rot r = 0 ;
e, infine, si ottiene:
(2.4.4′) div E = ρ .
Derivando l’espressione (2.4.4′) rispetto al tempo si ha:
![]() .
.
Ammettiamo che l’osservatore solidale con S
′ scriva 1’equazione di continuità (2.4.5) per il moto apparente
della distribuzione di cariche che egli giudica in moto.
Con questa ipotesi di carattere fisico l’ultima
equazione si scrive:
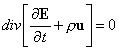
Questa relazione ci dice che si può porre:
(2.4.3′) 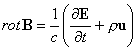 .
.
Si è così mostrato che equazioni della stessa
forma di quelle Maxwell si possono scrivere all’interno dell’usuale meccanica
classica delle particelle interagenti. Esse, in questa luce, rappresentano
espressioni formali a cui devono obbedire i campi delle forze d’inerzia che si
originano nei sistemi ruotanti rispetto ad un sistema considerato come
inerziale.
Notiamo che le definizioni introdotte si
prestano bene per altre interessanti estensioni. Per esempio, si può vedere
che, ridefinendo i potenziali scalare e vettore nella forma:
![]()
![]()
con f funzione arbitraria, si
perviene alla cosiddetta “invarianza di gauge” per i potenziali.
Si potrebbe, ancora, rimuovere l’ipotesi che Ω dipenda solo dal tempo introducendo una funzione di campo
(basterebbe introdurre un operatore lineare, simile a quello che si introduce
nel trattare le “deformazioni rigide” di un mezzo continuo), ma questo ci
porterebbe lontano dagli scopi che mi sono prefisso, che consistevano nel
mostrare semplicemente che l’invarianza galileiana non è obbligatoria neanche
nella teoria classica delle particelle. D’altra parte, nessuno ci assicura che
il sistema delle stelle fisse sia inerziale, anche se si fa usualmente tale
ipotesi; e, in ogni caso, non è detto che lo sia rispetto al baricentro delle
cariche elettriche dell’universo.
2.5) Le
trasformazioni di Voigt - Lorentz
Come è noto dalle equazioni di Maxwell si
deduce facilmente l’equazione delle onde, valida anche in tutti i fenomeni
lineari della meccanica classica dei mezzi continui, come in acustica, in
idrodinamica, ecc.
Essa per tre coordinate arbitrarie x,
y e z si scrive:
(2.5.1) ![]()
dove ‘P può rappresentare una vibrazione in un mezzo elastico.
L’eq. (2.5.1) è la rappresentazione
matematica di un modello del continuo che riesce a descrivere molti fatti
osservati. Per esempio, in meccanica classica (newtoniana) la si stabilisce
agevolmente per descrivere la propagazione delle onde sonore nell’aria e, nel
caso unidimensionale, l’onda che si propaga su di una corda di violino, ecc..
In tal caso, è l’ascissa lungo la direzione
di propagazione, e ct è il tempo
misurato in unità di lunghezza, ottenuto moltiplicando il tempo per la velocità
(di fase) di propagazione delle vibrazioni sulla corda.
Ma l’eq. (2.5.1), come è noto, descrive anche
il fenomeno di propagazione di onde elettromagnetiche nel vuoto o in mezzi
isotropi.
Ci troviamo dunque di fronte ad un modello
matematico che descrive situazioni fisiche differenti tra loro come, p. es., le
“oscillazioni meccaniche” di un mezzo e le “oscillazioni elettriche”.
L’equazione (2.5.1) ammette come soluzione
generale:
(2.5.2) Ψ (x, y, z, t) = f (r + ct)+g (r - ct) ,
dove f, g sono funzioni arbitrarie degli argomenti (r+ct) e (r - ct) ed
![]() . Se introduciamo
le nuove variabili x′, y′, z′, t′ legate alle precedenti da
una trasformazione, tale che si abbia:
. Se introduciamo
le nuove variabili x′, y′, z′, t′ legate alle precedenti da
una trasformazione, tale che si abbia:
(r + ct) = h1(r′ + ct′)
r - ct = h2(r′ - ct′)
con h1, h2
funzioni arbitrarie dei nuovi argomenti e sostituiamo nella soluzione
generale si ha:
Ψ (r′ , ct′) = f
(h1(r′ + ct′)) - g (h2(r′ - ct′))
che, ovviamente, è ancora una soluzione della nostra equazione. Un caso particolare di tali trasformazioni è quello lineare:
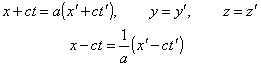
con a costante diversa da zero.
È facile verificare che si ha, in questo
caso:
r2 - c2 t2
= r′ 2 - c2 t′
2 .
Riconosciamo subito che la trasformazione
indicata ha tutte le caratteristiche di una trasformazione di Lorentz, basta
porre ![]() e
e ![]() :
:
x = γ(x′ + βt′) y′ =y z′
= z
c t= γ (β x′ + c t′).
Questo risultato era già da tempo noto, prima
dell’avvento della relatività e prima ancora dei classici lavori di Lorentz
sulla dinamica dell’elettrone, per cui tali trasformazioni, da alcuni, sono
giustamente chiamate “trasformazioni di Voigt-Lorentz”.20
Infatti, questi risultati e molti altri, che
ormai vengono considerati come semplici “curiosità storiche”, fanno parte di un
vasto e competente lavoro, condotto dal Voigt intorno al 1880.21
Il Voigt dedusse tali trasformazioni come le
uniche che permettono ad un’onda sferica, che si propaghi in un mezzo, di
essere vista ancora come sferica, con lo stesso raggio, da un osservatore in
moto rettilineo uniforme rispetto al mezzo, con velocità ![]() . Ma,
probabilmente, erano solo una curiosità matematica, non realizzabile
fisicamente.
. Ma,
probabilmente, erano solo una curiosità matematica, non realizzabile
fisicamente.
Infatti, di tutti i modi equivalenti
conosciuti, per giungere a tali trasformazioni, nessuna può essere compatibile
con la teoria delle grandezze.22
Elenchiamo tali modi di derivazione (vedi il
riferimento citato a nota 20):
1) Le
trasformazioni che lasciano invariata l’equazione dell’onda in uno spazio
tridimensionale (von Laue).
2) Le
trasformazioni che lasciano invariato il quadrintervallo r2 — c2t2
(Minkowski).
3) Le
trasformazioni che lasciano invariata una rotazione immaginaria, ponendo x0
= ict (Marcolongo).
4) Le trasformazioni che lasciano invariata
(in forma e in volume) un’onda sferica propagantesi in un mezzo, per una
traslazione uniforme di velocità assegnata (Le Roux).
5) Le
trasformazioni lineari che formano gruppo, avendo già accettato i due postulati
di Einstein (Pauli).
Poi ci sono le derivazioni che non sono
derivazioni, come nella maggior parte dei libri di testo.23 Qui si parte dall’unica affermazione che si può
fare assumendo il principio detto della costanza della velocità della luce
(vedi appresso) e cioè:
r2 - c2 t2
= r′ 2 - c2 t′
2 = 0 ;
e poi si prosegue dimenticandosi dell’ = 0 assumendo implicitamente che
se un’uguaglianza funzionale vale per un particolare valore delle funzioni deve
valere per tutti i valori!
Spetta al Somigliana aver posto la questione
del significato fisico delle trasformazioni, anche se tale fatto viene spesso
dimenticato.24
2.6) Le
ipotesi di Einstein
Il tentativo di dare significato fisico alle
trasformazioni di Voigt, effettuato dal Lorentz, col supporre un reale
accorciamento delle dimensioni dei corpi fisici in dipendenza della loro
velocità, era così incredibile che nessuno volle prenderlo sul serio, quindi le
ipotesi fisiche, molto più generali, di Eistein furono considerate come l’unico
possibile rimedio alle gravi questioni che poneva la più usuale interpretazione
dell’esperimento di Michelson - Morley.
I due postulati su cui si fonda la relatività
speciale di Einstein sono:
a) Il
postulato della costanza della velocità della luce.
b) Il
principio di relatività.
Quest’ultimo può essere illustrato nel modo
seguente. All’interno di un sistema inerziale (ovvero, per usare la
formulazione originaria di Einstein, un sistema in cui valgano in prima
approssimazione le equazioni cli Newton) nessun esperimento può informarci
circa la velocità del sistema stesso, rispetto al puramente ipotetico sistema
di riferimento in quiete assoluta.
Il postulato a), invece, asserisce che un
raggio di luce si muove nello spazio con una velocità costante in modulo, c,
indipendentemente dal fatto che il raggio sia emesso da una sorgente in quiete
o in moto uniforme rispetto ad un osservatore inerziale (non è chiaro che cosa
inerziale ora possa significare, dal momento che il concetto è stato
relativizzato; solo nella relatività generale Einstein crede di poter ovviare
all’inconveniente).
Einstein assegna a questo postulato
un’importanza capitale, anzi, più volte afferma che la teoria della relatività
si differenzia dalla teoria di Newton solo a causa del postulato sopra
indicato; infatti il postulato b) è valido anche nella fisica di Galileo e
Newton.
Con tali ipotesi, Einstein, giustamente dal
mio punto di vista, elimina totalmente ogni riferimento all’etere, ente
misterioso che occupava, anzi ossessionava, allora le menti dei fisici. E con esso,
anche ogni riferimento a moti assoluti, intesi come moti riferiti a un
altrettanto ipotetico spazio in quiete assoluta. (Notiamo qui che lo spazio
assoluto di Newton non è assoluto perché in “quiete assoluta”, ma lo è,
semplicemente, perché non fa riferimento alle “misure sensibili”).
Per Einstein ciò che conta, dal punto di
vista della fisica, sarebbe solo il moto relativo come rivelato dalle misure
sensibili rispetto a un dato riferimento fisico.
A partire dalle sopraddette ipotesi, il
ragionamento di Einstein si può riassumere come segue.
Consideriamo un osservatore O che si consideri in quiete. Esso lanci
segnali luminosi ad intervalli di tempo r verso un osservatore O ′, in moto
rispetto ad esso, munito di uno specchietto riflettente. Supponiamo di
considerare, per semplicità, il moto lungo una retta.
È facile mostrare che se si calcola
l’intervallo di tempo di ricezione dei segnali da parte di O ′ (calcolo eseguito da O) si ottiene:
![]() .
.
L’osservatore O ′ rimandi indietro i segnali ricevuti,
tramite riflessione sullo specchietto; ammettendo che in questo processo non
si registri alcun ritardo, O riceverà
il segnale di ritorno dopo un
intervallo di tempo:
![]() .
.
Qui si è sfruttata l’ipotesi, tutta da
verificare, che la velocità del raggio, dopo la riflessione, non dipende dal
moto dello specchietto.
Supponiamo ora che il tempo sia universale e
che dunque le misure degli intervalli di tempo di O coincidano con quelle di O
′.
Il rapporto tra i tempi di trasmissione di O e quelli di ricezione di O ′ vale:
![]()
mentre il rapporto tra i tempi di trasmissione di O ′ (la riflessione si può considerare una
trasmissione da O ′ verso O ) e quelli di ricezione di O vale:
![]()
Ora, se non si ammette nessuno spazio
assoluto privilegiato, il principio di relatività einsteniano richiede che
operazioni fisiche simmetriche eseguite da osservatori che si allontanino
relativamente l’uno dall’altro diano risultati uguali per R ed R′, ma se il tempo è considerato universale, ciò non potrebbe
avvenire, come si vede dalle formule precedenti.
In altri termini, l’ipotesi di indipendenza
della velocità della luce dal moto, è incompatibile con una misura dei tempi di
ricezione se si assume il tempo assoluto.
Se si cerca la simmetria e si vuole mantenere
il postulato di indipendenza bisogna modificare il ritmo di uno dei due
orologi, per esempio, quello in moto.
Si può, intanto, imporre l’uguaglianza:
![]() .
.
Purtroppo i due postulati esplicitamente
enunciati da Einstein non sono sufficienti per arrivare alle trasformazioni
cercate (vedi la più completa dimostrazione di Notarrigo in questo quaderno); a
questo punto Einstein introduce un nuovo postulato (senza la benché minima giustificazione)
e precisamente:
(2.6.1) ![]() .
.
Solo con questa ulteriore assunzione si può
avere:
![]()
che pretendono le trasformazioni di Lorentz.
Il fatto, importante da notare, è che i due
postulati di Einstein non sono sufficienti per scrivere il fattore di Lorentz;
né, allo scopo, serve la nuova definizione di contemporaneità, come da lui
definita (cioè la media aritmetica dei tempi di trasmissione e di ricezione
del segnale, come li misurerebbe un osservatore in moto rispetto alla quiete
assoluta), che porterebbe a ben altre trasformazioni (vedi l’articolo di Notarrigo),
ma bisognerà ammettere la nuova ipotesi, derivante dalla relazione (2.6.1), che
corrisponde a una ridefinizione della contemporaneità tale che pretenda la
media geometrica tra i due intervalli di tempo sopraddetti, invece, della media
aritmetica; ma sarebbe impossibile spiegare il significato fisico di tale
operazione matematica, forse bisognerebbe usare orologi logaritmici!
Quindi, questo secondo modo di enunciare
l’ipotesi aggiuntiva non trova alcuna giustificazione razionale. Il primo modo
equivale a supporre che è indifferente (per ogni fenomeno fisico che utilizzi
la luce come mezzo di comunicazione) il fatto che i due osservatori “relativamente”
si allontanino o “relativamente” si avvicinino; cosa che, come dice Notarrigo,
è assolutamente falsa; a sostegno basta citare l’effetto Doppler che, secondo
le stesse deduzioni relativistiche, ci permetterebbe di scoprire il segno della
velocità relativa, una volta fissata convenzionalmente l’orientazione relativa
dei due sistemi di riferimento. Questo fatto condurrebbe all’assurda conclusione
che non sia la stessa cosa l’enunciare il principio di relatività asserendo che
i due osservatori vedono le stesse cose se compiono le stesse operazioni,
oppure asserendo che non si può rivelare il moto assoluto con operazioni
fisiche fatte nello stesso sistema; ciò per la semplice ragione che si sta
confondendo un fenomeno “relativo” (come il reciproco allontanamento o
avvicinamento) con l’esistenza della quiete “assoluta”, che è quella che si
vuole negare.
Fra l’altro, nella fisica dell’effetto
Doppler classico (come nel caso delle onde sonore), risulta rilevante financo
la condizione che sia l’osservatore piuttosto che la sorgente a muoversi,
rispetto all’aria; anche se la differenza è marginale dal punto di vista delle
misure effettuabili con i comuni valori ottenibili per le velocità (vedi
Perucca).
L’ipotesi che la luce non debba risentire del
moto della sorgente è giustificabile solo se si ammette un riferimento assoluto
in cui essa viaggi (anche se costante e indipendente dalla sorgente — il riferimento non è detto che sia
costituito da un mezzo come il fantomatico etere, ma può anche essere il centro
delle cariche elettriche dell’universo) e si assuma una rapida redistribuzione
dell’impulso per effetto delle interazioni con il resto dell’universo, come nel
caso delle onde acustiche o delle onde prodotte nell’acqua da uno scafo mobile
(in questi casi, le interazioni con il resto dell’universo si possono
approssimare con gli urti intermolecolari).
Tuttavia, in assenza di un preciso modello
fisico che spieghi il significato da attribuire alla parola luce, che Einstein
non dà, nonostante asserisca che è la cosa che meglio conosciamo, in assenza di
ipotesi fisiche su come avvenga il processo di emissione ed assorbimento di
essa da parte della materia, non è affatto banale scartare l’ipotesi che per la
luce stessa, in determinate condizioni, si possa ammettere un qualche modo di
composizione della sua velocità con quella dell’assorbitore o dell’emettitore
(o, nel caso della riflessione, dell’assorbitore - emettitore, infatti dovrà pure interagire la luce con lo specchio
per riflettersi!).
L’ipotesi che la luce possa, in certe
condizioni, comporsi con il moto della sorgente emittente fu avanzata dal Ritz
e ripresa successivamnte dal palermitano La Rosa che la sostenne efficacemente.
L’ipotesi va sotto il nome di “ipotesi balistica”.
In base a questa ipotesi la velocità della luce, come osservata da un
osservatore, si comporrebbe secondo lo schema “classico”: c + v o c
— v, a seconda che la luce venga emessa nel
verso del moto o in verso contrario.
L’ipotesi del Ritz fu ritenuta errata dal De Sitter che, secondo il La Rosa, credette di liquidare l’ipotesi balistica senza alcuna giustificazione quantitativa. La giustificazione del De Sitter si basava su una particolare interpretazione dei dati ricavati dalle misure sugli effetti ottici prodotti dal moto delle stelle doppie.
In breve, il De Sitter ragionava così: Se la
velocità della luce non fosse costante e indipendente dal moto della sorgente,
allora dalla terra non potrebbe nemmeno osservarsi il “fenomeno di stella
doppia”, come viene chiamato, perché la luce che ci giunge, inviata in istanti
diversi dalle due stelle della coppia, si mescolerebbe lungo il suo cammino
impedendoci una ricostruzione razionale degli effetti regolari che invece si
osservano e che permettono, invece, una misura della velocità della luce, anche
se non troppo precisa.
L’analisi del La Rosa,25 invece, mostrerebbe l’assurdità della pretesa del
De Sitter e, anzi, la sua impostazione quantitativa proverebbe che gli
osservati fenomeni di intensità variabile, connessi con l’osservazione delle
stelle doppie, si spiegano facilmente assumendo l’ipotesi balistica. Non mi
risulta che i calcoli del La Rosa, che parte dall’ipotesi del Ritz, abbiano
avuto smentite.
C’è, al contrario, una considerazione del
Bridgman che, citando il lavoro di La Rosa, lo cosidera come una valida prova
di come la luce, in certe situazioni, possa presentare alcuni aspetti tipici di
particella.26
Non è il caso, in questa sede, di soffermarci
su questa intricata faccenda dell’ipotesi balistica. Ma è sintomatico che, come
nel caso del Righi (come vedremo essere accaduto nel caso dell’esperimento di
Michelson - Morley), non si citi il
lavoro del La Rosa, nemmeno per criticarne i contenuti.
Se si accetta l’ipotesi balistica si può
verificare banalmente che nessuna contraddizione può esistere tra il risultato
delle misure di ricezione fatte da O e
da O ′ nell’esempio prima considerato, nell’ipotesi di un tempo
universale, perché si avrebbe sempre R =
R ′.
2.7) L’esperimento
di Michelson e Morley
L’esperimento di Michelson e Morley (MM) fu
congegnato in modo da poter mettere in evidenza il moto della terra rispetto
all’etere (supposto esistente) attraverso misure interferometriche.
Descriviamo schematicamente lo strumento
essenziale, detto interferometro di Michelson. Immaginiamo di connettere tra
loro, rigidamente e “a squadra” (cioè perpendicolarmente tra loro) due aste MA e MB,
entrambe di lunghezza l.
Inclinata di 45°, rispetto ad entranbe
le aste, si ponga in M una lamina di
vetro, L; in modo tale che un fascio
di raggi paralleli proveniente da una sorgente di luce, posta in un punto S, venga diviso in due parti (S
sta sulla linea che comprende il segmento MB
e sta dalla parte opposta a B rispetto
ad M).
Una parte del raggio incidente su L si diriga verso A, dopo riflessione in M;
l’altra parte del raggio si diriga verso B, dopo rifrazione in M.
Supponiamo che in A e B siano stati posti due specchietti,
orientati normalmente alle due aste, che riflettano, di nuovo verso M, i raggi su di essi incidenti.
Qui, il raggio proveniente da A attraversi la lamina L, per rifrazione, e si diriga verso un
punto O (O sta sulla linea che
comprende il segmento MA e sta dalla
parte opposta ad A rispetto ad M), mentre quello proveniente da B, per riflessione, si diriga,
anch’esso, verso O. Quindi, a partire
dal secondo incontro con la lamina L, i
due raggi seguono entrambi lo stesso percorso MO. Supponiamo posto in O un
oculare mediante il quale un osservatore possa vedere le frange di interferenza
prodotte dalla sovrapposizione dei due raggi.
Si ragionava cosi:
Se lo strumento è in quiete rispetto
all’etere (mezzo rispetto al quale si supponeva avvenisse la propagazione
delle vibrazioni luminose) i tempi, che i raggi impiegano a percorrere i
cammini MAM e MBM, sarebbero uguali.
Al contrario, se lo strumento è in moto
rettilineo uniforme rispetto all’etere, p.es., lungo MA, e si suppone che “anche in questo caso” valga la legge di
riflessione, secondo la quale l’angolo di incidenza è uguale all’angolo di
riflessione, si avrebbe una differenza tra i percorsi dei due raggi, che
dovrebbe provocare uno sfasamento nella figura di interferenza.
La sensibilità dell’interferometro di
Michelson era tale da permettere di rivelare una velocità (di un moto di
traslazione dell’apparato relativamente all’etere) di circa 10 Km/sec.
Se si suppone l’etere fermo rispetto al sole,
muovendosi la terra con una velocità di circa 30 Km/sec intorno al sole, risultava possibile rivelare tale velocità
mediante lo spostamento delle frange di interferenza previsto.
Risultava più conveniente misurare il
rapporto tra le fasi in due direzioni mutuamente ortogonali in quanto tale
rapporto risulta essere indipendente, per le ipotesi fatte, dall’effettiva
velocità dell’apparato rispetto all’etere, dipendendo solo dall’angolo tra la
direzione dell’asta MA e la direzione
del moto rispetto all’etere, angolo che doveva variare nel tempo per effetto
del moto della terra.
Questo presupponeva delicati aggiustamenti
empirici, sia per orientare la lamina L, sia
per orientare gli specchi posti in A e
B. Operazioni queste, che non erano
facilmente controllabili teoricamente.
Non è qui possibile discutere
dettagliatamente la teoria dell’etere, in base alla quale venivano fatte le
predizioni empiriche. Questo lavoro meriterebbe un riesame critico sia storico
che scientifico e ciò andrebbe molto al di là degli scopi che qui ci siamo
prefissi. Per cui ne daremo solo un rapido cenno.
Michelson e Morley terminarono i loro
esperimenti nel 1887 a Cleveland,27 dando
come risultato, entro i limiti di accuratezza del loro apparato sperimentale,
l’assenza dello spostamento delle frange di interferenza che ci si aspettava.
Si suole indicare questo risultato come
“nullo”.
In base alle loro predizioni teoriche gli
autori si aspettavano, invece, un risultato “non nullo”, dal quale si sarebbe
potuto ricavare la velocità della terra rispetto all’ipotetico etere.
Dal punto di vista dell’analisi sperimentale,
tuttavia, l’esperimento di MM non poteva considerarsi conclusivo. E gli stessi
autori mostravano delle perplessità.
Restavano parecchi dubbi.
In che modo la velocità del sistema solare
influisce nell’esperimento? Infatti il moto del sistema solare poteva,
sottraendosi o aggiungendosi al moto della terra, influire sugli effetti di
interferenza.
Qual è l’influenza della
temperatura sulle varie parti dell’apparato nei diversi periodi in cui le misure
erano state effettuate (p. es., effetto giorno - notte, ecc.)?
In che modo la struttura, solo in prima
approssimazione rigida, dell’apparato, può influire sui fenomeni ottici?
In che modo altre condizioni esterne (come,
p. es., gli eventi atmosferici) agivano sull’accuratezza delle misure?
I problemi sperimentali erano tali e tanti
che altri esperimenti dello stesso tipo furono tentati da altri autori in varie
parti del mondo, ma molto tempo dopo il 1887.
Tali altre misure vanno, grosso modo, dal
1920 al 1930, cioè, una trentina d’anni dopo il primo e ben più famoso
esperimento. Nell’intervallo si registra un solo esperimento condotto da Morley
e Miller tra il 1904 e il 1905.
Un’ampia ed esauriente rassegna di tali
esperimenti si può trovare in un articolo dello stesso Miller.28
Tale articolo consente una più chiara idea su
quello che ha rappresentato l’esperimento di Michelson e sul suo significato
fisico.
I risultati del Miller del 1904 - 1905 indicavano, secondo gli autori, un
risultato “non nullo”. Tuttavia, in base alla stessa teoria proposta da
Michelson, la valutazione del moto della terra risultava di circa 8 km/sec contro i 30 km/sec che si ricavano dalle misurazioni astronomiche.
Miller ripetè gli esperimenti più volte
trovando sempre risultato “non nullo”, salvo qualche rarissima eccezione, oggi,
nessuno più parla di tali esperimenti.
Se si fa eccezione per il Miller, che vi
dedicò la sua vita,29 in tutti
questi delicatissimi esperimenti (circa una decina), si trovarono risultati
“nulli”.
Nel 1955 apparve un riesame critico degli
esperimenti del Miller, da parte di Shankland e collaboratori.30
In base a questo riesame risulterebbe che
anche gli esperimenti del Miller possono considerarsi come “nulli”. La mia
impressione, alla lettura di tale articolo, fu che tale riesame era molto più
artificioso di quanto non fosse l’analisi originale del Miller.
Il risultato “nullo” fu confermato anche
dagli esperimenti più recenti di Kennedy -Thorndike (1932) e di Ives - Stilwell (1938).
Se si accetta il fatto che esperimenti del
tipo MM debbano dare sempre risultato “nullo” e si accetta la teoria
dell’etere, come allora veniva intesa, si perviene alla supposizione che, lungo
la direzione del moto, debba prodursi una contrazione delle lunghezze; tale
ipotesi fu suggerita da Fitzgerald e da Lorentz.
In base a tale ipotesi la lunghezza in moto
dovrebbe valere 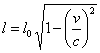 , essendo l0
il valore della lunghezza dell’asta a riposo.
, essendo l0
il valore della lunghezza dell’asta a riposo.
Ma, benché questa ipotesi può essere
accettata dal punto di vista della teoria dell’etere, essa non è necessaria.
Infatti gli esperimenti “nulli” possono venire coerentemente interpretati anche
all’interno della teoria dell’etere come fu mostrato all’epoca.
Diamo un breve cenno su queste
interpretazioni che furono avanzate da personalità scientifiche di chiara fama
internazionale.
Tra i più autorevoli citiamo Hicks,
Sutherland e Righi. Le loro analisi portano a concludere:
a) Le stesse osservazioni sperimentali di
Michelson, se interpretate in modo leggermente diverso da come fecero Michelson
e Morley, autorizzano la conclusione che il risultato non è “nullo”.
b) Anche ammesso che l’esperimento di
Michelson possa essere interpretato come risultato “nullo”, ciò sarebbe ancora
in perfetta armonia con le predizioni della teoria ondulatoria dell’etere e del
principio di Huygens.
Scrive Hicks:31
“Nelle pagine
seguenti mi propongo di riconsiderare in dettaglio la teoria generale degli
esperimenti con la quale i signori Michelson e Morley cercarono di decidere la
questione della quiete o del
moto dell’etere, quando un corpo materiale si muova attraverso di esso.
La teoria non
è semplice, come potrebbe apparire, essendo essa collegata direttamente
all’effettiva riflessione del raggio luminoso su di una superficie in moto.
La correzione
dovuta all’alterazione dell’angolo di riflessione è stata introdotta da Lorentz
ed è stata tenuta in conto nel lavoro di Michelson e Morley (1887).
Ma la
riflessione produce anche un cambiamento nelle lunghezze d’onda dell’onda
riflessa…
…Il presente
lavoro intende presentare in modo corretto tutte queste correzioni…
Il principale risultato delle correzioni è che
nell’esperimento di Michelson e Morley l’effetto da attendersi è esattamente contrario a quello
predetto dagli autori …in base a ciò voglio ora mostrare che, invece di un
risultato nullo, i dati numerici pubblicati nel loro articolo mostrano
una chiara evidenza di un effetto che ci si dovrebbe apettare in base alle
analisi che abbiamo condotto”.
Scrive, a sua volta, Sutherland:32
“L’eperimento
di Michelson e Morley, descritto in Phylosophical Magazine (1887), ha posto un
dilemma nella fisica dell’etere; a causa del quale la tendenza generale è quella di pensare ad una
completa indipendenza dell’etere nelle immediate vicinanze della terra dal moto
della stessa.
Si è supposto
che questo celebrato esperimento provi definitivamente che la superficie della
terra e l’etere adiacente non siano in moto relativo.
Io mi propongo
di mostrare come un piccolo cambiamento nel punto di vista della teoria dell’esperimento rende manifesto che,
tenendo in conto i particolari aggiustamenti che sono stati fatti all’apparato
ottico utilizzato da Michelson e Morley,
esso in effetti è stato reso inadatto a decidere sulla questione posta…
In definitiva,
se l’osservazione che qui abbiamo fatto è corretta, appare chiaro che il
fallimento dell’esperimento di Michelson e Morley
è dovuto all’assenza di una particolare precauzione che si rende necessaria per
dare allo strumento la sensibilità che da esso si pretende e non mai ad un
presunto fallimento della teoria dell’etere”.
Michelson e Morley criticarono le analisi di
Hicks.33 Ma non risulta che
siano state opposte obiezioni all’analisi di Sutherland, che a me è sembrata
inattaccabile.
Le obiezioni del Sutherland furono riprese
dall’italiano Augusto Righi. 34
L’analisi del Righi, tanto profonda quanto
sconosciuta, (vedasi, nei già citati articoli, la polemica che il Righi conduce
nei confronti di qualche autore che si serve della sua teoria stravolgendone i
risultati) mostra chiaramente come una corretta applicazione del principio di
Huygens, agli specchi in movimento, dimostra che l’esperienza di Michelson non
è in grado di decidere intorno alla questione posta.
Scrive Righi: “Mentre dunque la previsione, formulata da Michelson e fino al dì
d’oggi ammessa da tutti, che: si deve osservare uno
spostamento di frange passando dal caso in cui la traslazione terrestre si
compie parallelemente alla direzione della luce incidente, a quello in cui
detta traslazione ha luogo in direzione trasversale, il risultato da me
ottenuto è invece questo: che non deve affatto mutare il fenomeno di
interferenza passando dall’una all’altra di quelle due orientazioni…
Evidentemente,
se questo si fosse saputo prima del 1887 non si sarebbe forse ideata
l’esperienza di Michelson, per cui sarebbe probabilmente mancata l’occasione di
pensare alla relatività e alla contrazione.”
Si vede dunque come, dal punto di vista
dell’interpretazione del risultato relativo all’esperimento di Michelson e
Morley, non si avesse unanime consenso. Anzi, molte obiezioni fondamentali,
alle quali non fu data un’adeguata risposta, lasciano sospettare che il
risultato nullo di Michelson non fosse poi così strano come lo si vuol fare
apparire.
Benché oggi, da più parti, si ritiene che la
teoria della relatività non si fonda sul risultato di Michelson e Morley,
appare paradossale come poi, nel campo della didattica si porti, a conferma del
principio di relatività einsteniano, proprio quell’esperimento la cui dubbia
interpretazione oggi viene ammessa apertamente dagli specialisti.
In ogni caso, è bene ribadirlo, l’esperimento
di Michelson, insieme con la sua interpretazione, riguardava l’ipotesi
dell’etere. Questo strano ente, benché di grande utilità pratica nello studio
dei molti fenomeni dell’ottica classica, era giustamente considerato all’epoca
come un semplice utile modello.
Mediante tale modello si interpretavano
facilmente i fenomeni di interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce.
Ma era noto che esso non riusciva altrettanto
bene, senza l’aggiunta di ipotesi supplementari riguardanti l’interazione
dell’etere con i corpi in moto, a spiegare i fenomeni di assorbimento
selettivo, ed altri fenomeni più complessi.
Penso che sia necessario dare agli studenti
anche una pur minima informazione storica sulla nascita e lo sviluppo delle
teorie fisiche e sulle fondamentali questioni filosofiche che esse hanno
sollevato, se non si vuole che la scienza appaia come una questione di fede
verso le autorità costituite. È semplicemente a tale scopo che ho redatto la
presente nota.
Ringrazio i signori collaboratori della
Biblioteca Zelantea di Acireale per l’aiuto che mi hanno dato nel consentirmi
la consultazione di alcune importanti riviste scientifiche del passato.
Desidero anche esprimere la mia gratitudine al caro amico e collega Prof.
Notarrigo, che con grande pazienza ha letto attentamente questo scritto. Delle
sue positive critiche e dei suoi suggerimenti ho tratto grande vantaggio nella
stesura definitiva dell’articolo.
Acireale, 27/2/1991.
NOTE
- A.Pagano, Fisica
e Metafisica nella teoria di Einstein, Mondotre, n. 6/7, anno
III, 1989 e Su di un’opera
dimenticata di fisica di Boggio e Burali-Forti, Quaderni di Mondotre,
Suppl. N. 4/5, anno Il, 1989. TORNA
- H.Bouasse, La question prealable contre la théorie
d’Einstein, Scientia, 1923, p. 13. Bouasse insegnò fisica presso la facoltà si scienze
di Toulouse in Francia ed era un fisico sperimentale molto
considerato. TORNA
- G. Peano, Operazioni
sulle grandezze, Atti Reale Acc. delle Sc. di Torino, Vol. LVII,
1921-22. TORNA
- E. Perucca, Fisica
Generale e Sperimentale, in due volumi; l’ottava edizione, l’ultima
che potè essere curata dall’autore stesso, è del 1963; qualche volta viene
citato Einstein in relazione a qualche ipotesi per la spiegazione di
qualche fatto sperimentale. TORNA
- Naturalmente si può procedere anche
all’incontrario, dando per nota la somma tra grandezze e definire,
mediante questa, la somma tra numeri; come propone Notarrigo nel suo
articolo in questo stesso numero dei quaderni. Come sosteneva il Peano, è
semanticamente irrilevante la scelta dei termini primitivi in un sistema
assiomatico, se tale sistema deve formalizzare un insieme di “verità
operative”. TORNA
- L. D. Landau, E. M. Lifsits, Teoria dei campi, Vol. 2, Edizioni
Mir, p. 46, 1976. TORNA
- Questa idea, che ho già avuto modo di esprimere
in altre occasioni (vedi op. cit. a nota 1), verrebbe confermata anche
dalle analisi del Christidis. Vedi T. M. Christidis, Annales de la Foundation Louis de
Broglie, vol. 14, n. 1, 1989, p. 99. L’autore accosta Einstein ad Eradito, il
quale, secondo Diogene Laerzio appartiene alla scuola Ionica, dalla quale
scaturisce l’opera di Platone e del suo scolaro Aristotele, e che Diogene
contrappone alla scuola Italica, iniziata da Pitagora e che ha prodotto,
tra gli altri, anche Democrito. TORNA
- Vedi: P. W. Bridgman, La logica della fisica moderna, Boringhieri, 1977, p. 163. Bridgman
è uno di quei pochi scienziati moderni che pensano e riflettono sui
fondamenti del nostro pensiero fisico senza la paura di “sconfinare” negli
aspetti filosofici o metafisici della scienza stessa. Del resto, che la
relatività nasce da esigenze filosofiche, che potremo definire di stampo
empirista, ci è confermato con chiarezza dallo stesso Einstein: (Vedi A.
Einstein, Il significato della
relatività, Ed. scientifiche Einaudi, 1955, p. 1.): “L’oggetto di ogni scienza, sia delle scienze naturali che della psicologia, è di coordinare le nostre esperienze e dar loro una sistemazione logica …” TORNA
- L’argomento, che segue nel testo, si trova nel
già citato Libro di fisica teorica, (vedi nota 6) a pag. 43 e
seguenti. TORNA
- È invalso l’uso tra i fisici teorici moderni di
avvalersi continuamente del “principio di minima azione”. Si ottengono
così risultati formali che vengono successivamente rivestiti di
significato fisico. La fisica viene così ad essere generata dalla
matematica come per miracolo, pressappoco come il coniglio che esce dal
cappello del prestigiatore. I più antichi usavano con molta cautela tale
procedimento. Già Laplace, che di matematica se ne intendeva, metteva in
guardia da abusi del genere: “Molti
filosofi colpiti dall’ordine che regna nella natura, e dalla fecondità di
mezzi nella riproduzione dei fenomeni, hanno
pensato che la natura pervenga sempre al raggiungimento dei suoi obiettivi
per vie le più semplici. Applicando questo modo di vedere le cose alla meccanica essi hanno cercato l’economia come strumento di indagine
fisica. Tolomeo avrebbe compreso che la luce riflessa va da un punto ad
un’altro per il cammino più corto e
dunque nel tempo più piccolo possibile supponendo la velocità del
raggio luminoso sempre la stessa.
Fermat, uno tra i più
grandi geni di cui la Francia si onora, ha generalizzato questo principio
…” Laplace continua
con il notare i contributi di Maupentius e di Newton, e poi aggiunge: “Eulero estende queste supposizioni ai
moti variabili istante per istante; e prova, con diversi esempi, che tra
tutte le curve che un corpo può descrivere andando da un punto ad un altro
dello spazio, esso sceglie sempre quello in cui l’integrale del prodotto della
sua massa per la sua velocità e per l’elemento di curva, è un minimo.
Così, essendo costante la velocità di un punto
materiale che si muove su di una
superficie in assenza di forze, esso
si sposta da un punto ad un altro per la linea più corta su questa superficie. Si è chiamato l’integrale precedente, “azione
di un corpo”; e la riunione di questi
integrali simili, relativi ad ogni corpo del sistema, è stata chiamata
“azione del sistema”. Eulerò stabili dunque che questa azione è sempre
mimima, in modo che l’economia della natura consisterebbe a risparmiare: è
in questo che consiste il “principio di minima azione”, del quale bisogna
considerare Eulero, come il vero inventore, e che Lagrange in seguito ha
derivato dalle leggi primordiali del moto. Questo principio non è in fondo
che un risultato curioso di queste leggi, che come abbiamo visto, sono le
più naturali e le più semplici che si possa immaginare, e che inoltre
sembrano scaturire dall’essenza stessa della materia. Esso si presta bene
a descrivere tutte le relazioni matematiche possibili tra forza e velocità, perché basta sostituire in questo principio, in luogo
della velocità, la funzione della velocità, per mezzo della quale si vuole
esprimere la forza. Il principio di minima azione non deve dunque essere
eretto a causa finale; esso è lontano dall’aver dato nascita alle leggi del moto, non ha nemmeno contribuito alla loro scoperta,
senza la quale si disputerebbe ancora
su cosa bisogna intendere per minima azione nella natura.” TORNA
- K. T.
Bainbridge, Physical Review, Vol.
44 (1933), p. 123. TORNA
- Le unità di energia cinetica sono date in
multipli di e V (elettronVolt),
che rappresenta l’energia cinetica che competerebbe ad un elettrone dopo essere
stato accelerato da un potenziale elettrostatico di un Volt; 1KeV=1000 eV; 1 MeV=1 milione di eV. TORNA
- Si indica solo la fonte: Aston, Proc. Roy. Acc., 487 (1927) TORNA
- Vedasi il manuale di fisica nucleare
dell’Evans, The atomic nucleus, McGraw
- Hill Company INC (1955), cap. 3. I valori sono dati in termini di
difetto di massa, definito come m —
A, essendo A il numero di massa del nucleo e m la sua massa. Le unità adottate si riferiscono alla scala
dell’ossigeno 16, cioè, 16 uma =
massa dell’ossigeno 16; i valori sono dati in unità di 10-3 uma. Per
esempio, per ottenere la massa del protone nell’esperimento di Mattauch
(1940) bisognerà porre: m = (1 urna + 8.130 × 10-3 uma) = 1,008130 uma e così via. TORNA
- Vedi op. cit. in nota 7 pag.152. TORNA
- Già il Larmor aveva tentato di ridurre i corpi
a singolarità dell’etere : Aether
and Matter, Cambridge University Press, 1900. TORNA
- Vedi A. Einstein, Il significato della relatività, Ed. Einaudi, p. 37,
1955. TORNA
- Per maggiori dettagli sulla questione e per una
derivazione “covariante” si veda S. R. De Groot, The Maxwell Equations, North - Holland, 1969. TORNA
- Al posto dei vettori E e B,
Lorentz usava i vettori D e H,
molti altri autori usano i vettori E e H. Nel vuoto non c’è
sostanziale differenza tra le varie scelte; la differenza è fondamentale
nei mezzi ponderabili. Ma la confusione simbolica sta ad indicare la
confusione sui significati fisici che sempre si è avuta in materia, vedi a
p. 12 - 13 del riferimento citato nella precedente nota. TORNA
- Come fa il Dugas (vedi R. Dugas, Histoire de la Mécanique, Éd. du
Griffon, 1950), lo stesso Lorentz in una nota del suo fondamentale lavoro
sulla dinamica dell’elettrone, del 1905, conferma tale paternità. TORNA
- Voigt stabilisce molte delle proprietà a cui
obbedisce l’equazione d’onda classica nel lavoro Ueber das Doppler’sche Prmcip, Nachrichen der K. Gesder Wiss.
zur Gottingen, 10 Mar 1887. TORNA
- Vedi l’articolo di Notarrigo in questo
quaderno. TORNA
- Come esempi si vedano il Landau (già citato);
R. B. Leighton, Principles of Modern
Physics, McGraw - Hill, 1959; ecc., ecc. TORNA
- Vedi M. C. Somigliana, Rendiconti R. Acc. dei
Lincei, Vol. 31, 1922 TORNA
- Si veda: M. La
Rosa, Le concept de temps dans la
theorie d’Einstein, Scientia, Vol. XXXIV (1923). TORNA
- P.W. Bridgman,
op. cit., nota 7 a p. 163. TORNA
- A. A. Michelson
and E. Morley, Am. J. Sci., 34, 333 (1887). TORNA
- D. C. Miller, The Ether drift experiment and the
determination of the absolute motion of the earth, Rev. Modern
Physics, vol. 5,1933. TORNA
- Sembra che il Miller godesse di alta
considerazione come autorevole ed espertissimo sperimentatore, tant’è
vero che lo stesso Einstein, più volte, lo sollecitò a proseguire nei suoi
esperimenti. TORNA
- R. S. Shankland
et al., Rev. Modern Phy., Vol. 27, n.2 (1955), p. 167. TORNA
- W. M. Hicks, On the Michelson - Morley Experiment and the Drift of the
Ether, Phil. Magazine, Vol. 3, p. 9 (1902).
TORNA
- W. Sutherland, Relative Motion of Earth and Ether, Phy.
Mag., Vol. 45, p. 23 (1898). TORNA
- In Phy. Mag., T. IX, p .680. TORNA
- Vedi la I e la II memoria della R. Acc.
Dell’Ist. di Bologna, Tomo 6, 57. (1916), ripublicate nel Nuovo Cimento,
rispettivamente negli anni 1919 e 1921.
TORNA