REALE O FORMALE?
Salvatore Notarrigo
Il mio
amico Boscarino mi ha chiesto di contribuire con un mio articolo sull’argomento
che dà il titolo a questo numero dei Quaderni di Mondotre, dal punto di vista
di un fisico.
Ho avuto qualche remora per le seguenti
considerazioni:
1) Ho
già letto l’articolo di Boscarino qui pubblicato e gli estratti di Peano
assieme pubblicati e non mi sembra che ci sia nulla da aggiungere da qualsiasi
punto di vista.
2) Ho
già pubblicato su questi Quaderni1
qualcosa sull’argomento per parlare della concezione della scienza degli
antichi filosofi Italici e non mi piace scrivere sempre le stesse cose.
3) Interamente
d’accordo con la filosofia di tali antichi filosofi, per me la scienza è una e
indivisibile e deriva semplicemente dall’accordo tra le regole del nostro
linguaggio e la nostra esperienza. Mi riesce difficile distinguere il concetto
che io ho della fisica dal concetto che io ho della matematica, o quest’ultimo
da quello che io ho della logica, o il mio concetto di algebra dal mio concetto
di grammatica.
In un mio intervento ad un covegno su
Archimede notavo che nei discorsi dei fisici, Archirnede risultava un fisico,
in quelli dei matematici, risultava un matematico, e così via. Negli atti del
convegno2 scrivevo:
“Spesso gli
elogiatori di Archimede gli rendono un ben misero servizio riducendolo chi a ‘sommo
matematico’, chi a ‘grande ingegnere’, chi a ‘padre della fisica matematica’.
Credo che Archimede avrebbe
rifiutato cotali appellativi che non avrebbe nemmeno compreso, perché per lui
‘filosofia’, ‘matematica’, ‘fisica’, ‘ingegneria’ erano tutti sinonimi, come
nella tradizione di tutti i cosiddetti presocratici e sarebbe sicuramente
andato fuori dai gangheri nel sentirsi assimilare, per qualche verso, a Platone
o ad Aristotele, le cui dottrine erano la negazione stessa della sua filosofia.”
Tuttavia la storia del pensiero ci insegna che con il linguaggio si può parlare coerentemente anche del sesso degli angeli e non ci sono scienze in cui sia facile distinguere il reale dal formale o il formale dall’ideale.
Basta per questo consultare un qualsiasi
dizionario filosofico per accorgersi che nella storia della filosofia quelli
che in una certa epoca venivano classificati come “idealisti” in un’epoca
successiva venivano ad essere qualificati come “realisti” e viceversa.
Lo stesso è successo sui discorsi sulla
filosofia della matematica a proposito dell’alternativa “formalisti - costruttivisti”
ecc.
Potrebbe sembrare una questione puramente
nominalistica, riferentesi solo alla definizione dei termini. Ma si scopre che
è una questione molto più profonda che ha a che fare con la concezione del
mondo, con la metafisica e, in particolare, con l’ontologia dei vari filosofi o
di una particolare epoca o di una categoria sociologica di persone.
Così ho deciso di rimaneggiare in qualche
modo gli appunti che avevo preparato come preambolo per gli studenti del mio
corso di Fisica Superiore.
***
Nel leggere un qualsiasi testo di fisica noi
incontriamo delle proposizioni espresse con l’uso del linguaggio comune e delle
proposizioni espresse nella forma simbolica del linguaggio matematico.
Spesso i simboli possono essere tradotti con dei
termini che, se pur espressi con vocaboli della lingua comune, assumono dei
significati molto particolari che non vengono generalmente indicati nei comuni
dizionari della lingua corrente.
Per comprendere il significato preciso di
alcuni termini della fisica spesso occorre leggere e comprendere diversi libri
di fisica. Anzi, sul significato di alcuni termini, spesso, non si riesce a
trovare un accordo nemmeno tra gli stessi specialisti del particolare ramo a
cui il termine stesso si riferisce.
Alcune volte i simboli che compaiono nelle
formule della fisica non hanno un significato reale univocamente definito,
perché semplicemente stanno al posto di un qualsiasi individuo che obbedisca a
determinate relazioni formali, che interamente lo definiscono. E queste restano
sempre vere indipendentemente dal preciso significato reale del simbolo.
Un antico ideale di molti scienziati è sempre
stato quello di poter costruire un linguaggio scientifico tale che ogni
termine o proposizione potesse avere un unico significato, sempre definito in
modo non ambiguo, sia che si tratti di un “significato
reale” che di un “significato
formale”.
Un tale linguaggio secondo Leibniz dovrebbe
avere la forma di
“un calcolo
nuovo e mirabile, col quale sia possibile esprimere ogni nostro ragionamento e
che possa procedere come quello dell’aritmetica e dell’algebra. Con tale
calcolo si potrebbe sempre chiudere ogni controversia, a partire dai dati
iniziali. Di modo che, prendendo in mano una penna e bandendo ogni verbalismo,
i due disputanti possano dirsi l’un l’altro: calcoliamo, allo stesso modo di
come due aritmetici decidono di un errore di calcolo.”
In tale spirito chiediamoci qual è il
significato di “significato reale” e
di “significato formale”,
concetti che abbiamo sopra menzionato.
Ci accorgiamo subito che, intanto, dovremmo conoscere preventivamente il significato di ‘significato’. Tuttavia per saperlo occorrerebbe conoscere il significato del ‘significato’ di “significato”!
Constatiamo banalmente che, continuando per
questa via, otterremmo semplicemente un regresso all’infinito e non potremmo
mai venirne a capo. Infatti interi libri sono stati dedicati a tale problema,
senza alcun sensibile risultato.
Per risolvere un problema logicamente
irresolubile, come in particolare è il precedente, siamo costretti a fare, in
qualche punto, un’asserzione di ordine metafisico, cioè non verificabile
empiricamente, nè dimostrabile logicamente e che tuttavia abbia un significato
il quale, comunque, sia in grado di interrompere la catena infinita.
Ma, per il semplice fatto che tale asserzione
deve necessariamente essere di ordine metafisico, risulta chiaro che ognuno
potrà ritenersi libero di fare una sua particolare scelta. Si può dire,
infatti, che tutta la storia del pensiero è contrassegnata dalle varie risposte
che sono state date al nostro problema.
Dovremmo perciò concludere che il sogno di
Leibniz è veramente un ‘‘sogno’’?
In ogni caso, però, abbiamo capito una cosa
molto importante: per sapere il significato di un qualunque termine dobbiamo
necessariamente uscire fuori dai puri giochi di parole e appellarci alla
realtà. Ma che cos’è la “realtà”?
Anche qui i filosofi e gli scienziati, in
tutte le epoche della storia del pensiero, si sono sbizzarriti a darne le più
svariate definizioni.
Tuttavia dal passato ci è pervenuto un
modello mirabile di linguaggio scientifico, al quale tutti i grandi scienziati
del passato si sono sempre ispirati, e che certamente ha prodotto il sogno
leibniziano. Esso è rappresentato dagli “Elementi” di Euclide.
In tale libro si trova raccolta, in forma
lucida e coerente, la maggior parte di quelle conquiste del pensiero che in
gran parte erano già state ottenute nei secoli precedenti all’interno della
tradizione pitagorica. Il risveglio della scienza, dopo la lunga parentesi
medievale, si deve proprio alla riscoperta del testo di Euclide e dei testi di
Archimede, che è stato il suo più grande continuatore.
Sia Euclide che Archimede non ci hanno dato
risposte teoretiche ai problemi che prima abbiamo posto, in quanto sembra che
essi si siano limitati solo a dare degli “assiomi” e a dedurre dei “teoremi”
in determinate situazioni particolari.
Quindi, se vogliamo sapere quale risposta
essi abbiano potuto dare ai pregiudiziali problemi che abbiamo prima posto, non
ci resta che esaminare le operazioni che concretamente essi hanno compiuto.
Intanto osserviamo che essi usavano la lingua
comune dei loro tempi ma si nota, in modo inequivocabile, che essi la usavano
in un senso molto più preciso e molto più “formale” di quanto non facessero i
filosofi, gli storici, ecc., del loro tempo.
Qui, ancora una volta, ci siamo imbattuti di
nuovo nell’aggettivo “formale” ed è bene darne ora il suo significato. Ma, non
potendone dare una “definizione
nominale”, ci limiteremo a darne una “descrizione”.
Col termine “descrizione”, spesso detta anche “definizione reale”
intendererno un insieme di parole, corredate da specifici esempi concreti, le
quali abbiano un significato comunemente accettato, il più possibile privo di
ambiguità. Come esempio diamo qui di seguito la “descrizione” del termine “definizione
nominale”.
“Col termine
“definizione nominale” intenderemo una proposizione in cui compaia il segno =, dove a sinistra di = compaia un termine, del quale se ne vuole
conoscere il significato, e, a destra di = compaiano una serie di termini, di
cui se ne suppone noto il significato”.
Esempio:
pentagono = poligono con cinque lati.
Con la precedente “descrizione” abbiamo dato il significato di = e anche quello di “definizione nominale”, cioè: una “definizione nominale” ha la “forma”
(1) a=b ,
dove a, in modo generico, indica un qualunque
termine che si vuole definire; b, in
modo generico, indica il complesso di termini di significato noto che
definiscono il generico termine a,
ed il segno = è stato messo al posto del termine “significa”, cioè “a e b sono nomi diversi dello stesso
oggetto”, ovvero, equivalentemente, “a e b hanno lo stesso
significato”.
A questo punto non è più necessario sapere il
significato di significato. Il significato di una parola è quell’oggetto della
nostra mente, cioè quell’“idea”, che intendiamo evocare esprimendo quella
parola.
All’“idea” noi possiamo associare degli
oggetti che noi pensiamo come esistenti concretamente nello spazio e nel tempo
o, anche, oggetti astrattamente esistenti solo nella nostra mente.
Con la (1) abbiamo dato un particolare
esempio di una relazione “formale”, dove compaiono due lettere a e b
di significato indeterminato, comunemente ma impropriamente chiamate “variabili” ma dove anche compare il
segno al quale, invece, abbiamo dato un ben preciso significato “reale” (per
tale ragione spesso esso si dice una “costante”
e, nel caso particolare, una “costante
logica”) che esprime la
relazione di “identità logica”.
Anche noi, nel seguito, useremo il termine “variabile”, anche se esso e
improprio per il fatto che non esprime alcuna variabilità ma la semplice
convenzione che ai simboli a e b possiamo sempre sostituire due termini
qualunque, purché dotati di un unico significato. Essi servono solo per individuare
le relazioni “formali” esistenti fra generici termini, che, pur avendo
significati individuali diversi, condividono le stesse relazioni formali.
Facciamo ora altri esempi di relazioni
puramente “formali”, ma in un campo diverso da quello della “logica”. Li
prenderemo dal campo della “grammatica” .3
Consideriamo le due proposizioni seguenti:
(a) “l’uomo è animale razionale”,
(b) “uomo consta di quattro lettere”,
esse esprimono, rispettivamente, una
proprietà reale ed una proprietà formale di uomo.
L’una si riferisce all’ente,
o se si vuole all’idea che noi abbiamo di esso, l’altra alla parola, che semplicemente lo
denomina.
Anche la proposizione
(c) “uomo è sostantivo”
esprime una proprietà formale.
Un criterio per decidere sulla questione se
la proprietà sia reale o formale è quello di sostituire alla data parola una
parola equivalente, anche di altra lingua. Se al posto di uomo metto l’equivalente inglese man, la (a) resta vera, mentre la (b) risulta
falsa. Concludiamo che la prima è una proprietà reale e la seconda è formale.
Tuttavia, con un tale criterio, la (c) non
può essere decisa, ciò per il fatto che nelle lingue europee si ha la stessa
classificazione grammaticale del latino.
Ma è noto che vi sono lingue che non
distinguono le varie forme grammaticali (cioè: sostantivo, aggettivo, verbo,
ecc.).
Ma anche in latino e nelle altre lingue
neolatine vi sono diversi esempi in cui la distinzione, in quanto puramente
formale, si perde. P. es.:
Homo
homini lupus. (“lupus”
usualmente qualificato come sostantivo assume qui la funzione grammaticale di
verbo).
Ars longa, vita brevis (gli aggettivi “longa”
e “brevis” diventano verbi).
Pietro è buono, Pietro è poeta (l’aggettivo
“buono” ed il sostantivo “poeta” funzionano entrambi da aggettivi).
Si potrebbe costruire una lingua, ed il Peano
ne ha dato un esempio, in cui possono venire completamente eliminate le forme
grammaticali e che va nella direzione del sogno leibniziano.
Anche i simboli della matematica
costituiscono un esempio di lingua senza grammatica: la proposizione 2 + 3 = 5 si potrebbe tradurre in lingua
italiana con “la somma dei numeri due e tre fa il numero cinque”. Le parole
della traduzione hanno ora una grammatica, la quale tuttavia non aggiunge
niente alla più chiara e più breve forma simbolica.
Anche in matematica si hanno proprietà reali
e proprietà formali:
“![]() è frazione minore di 1”
è frazione minore di 1”
“![]() è frazione irriducibile”.
è frazione irriducibile”.
Ponendo nella prima ![]() al posto di
al posto di ![]() la proposizione resta
vera. Facendo la stessa sostituzione nella seconda, essa diventa falsa. Quindi,
la prima esprime una proprietà reale e la seconda una proprietà formale.
la proposizione resta
vera. Facendo la stessa sostituzione nella seconda, essa diventa falsa. Quindi,
la prima esprime una proprietà reale e la seconda una proprietà formale.
I precedenti esempi sono sufficienti per
comprendere il significato dei termini “reale” e “formale”, e i diversi sensi
contestuali di “formale”. Nel seguito, quando useremo il termine “formale”, lo
intenderemo sempre in senso “logico” e non “grammaticale”, ma è necessario
avvertire che nella maggior parte dei libri di logica moderni, pur usandosi i
simboli introdotti dal Peano, non si distingue più tra logico e grammaticale,
tornando a fare riferimento alla logica grammaticale di Aristotele, che il
Peano intendeva superare.
Nella lingua comune noi usiamo spesso delle
proposizioni della forma:
“Socrate è filosofo”
“Due è numero”.
Con esse vogliamo dire che gli “individui” Socrate e due appartengono, rispettivamente, alle “classi” filosofo e numero.
Secondo la forma grammaticale ‘Socrate’ e ‘due’, sono “soggetti”, ‘è’ è
“copula”, ‘filosofo’ e ‘numero’ sono “predicati”.
Tale classificazione grammaticale vale anche
per le seguenti proposizioni:
“Etna è Mongibello”
“mais è granturco”
“numero pari è multiplo di due”.
Ma, dal punto di vista della logica, esse non
esprimono la relazione tra un individuo e una classe ma, piuttosto, la
relazione di identità logica tra soggetto e predicato, quindi in questo caso
dovremmo scrivere
“Etna = Mongibello”
“mais = granturco”
“numero pari = multiplo di due”.
Ne viene che la forma grammaticale non solo
non ci dice niente sulle relazioni logiche ma addirittura le confonde. In un
linguaggio scientifico bisogna eliminare tali ambiguità e, allora, al posto
dell’unico termine ‘è’ ne dobbiamo introdurre più di uno per poter
esprimere, in modo non ambiguo, le diverse “relazioni
logiche”.
Peano ha introdotto il simbolo Î per indicare la relazione logica tra
individuo e classe, ed il simbolo = per indicare l’identità logica.4
Nella lingua comune il significato della
copula non si limita a questi due che abbiamo sopra menzionato. Infatti nella
proposizione:
“filosofo è uomo”,
si vuole dire che la “classe” ‘filosofo’
è una parte della “classe” ‘uomo’.
Peano introduce il simbolo É per
quest’altra relazione.5
E, ancora:
“qualcuno è filosofo”.
Qui si vuole dire che esistono individui che
appartengono alla classe “filosofo”, o, come spesso anche si dice, la classe
“filosofo” non è vuota.
Per quest’altro significato della copula
nessuna delle tre relazioni precedentemente introdotte si adatta. Useremo il
simbolo di Peano $, e la precedente relazione
si scriverà nel caso specifico
$ filosofo ,
o genericamente
$a ,
dove a è una classe.6
Vediamo alcune altre ambiguità della lingua
comune che è necessario togliere in un linguaggio scientifico.
Generalmente in italiano, si usa la
congiunzione ‘e’ per dire che per un determinato individuo si pretende che
abbia nello stesso tempo due proprietà, come nella proposizione “In Italia i
soldati sono di sesso maschile e di età superiore ai 21 anni”. Se tale
proposizione è vera ne segue che se qualcuno ha 15 anni o è di sesso femminile
non può essere un soldato.
Ma Supponiamo che salendo su di un autobus
incontriamo la scritta “Riduzione per militari e per minori di anni 6”, noi
sicuramente interpreteremmo la ‘e’ nel significato usuale della disgiunzione
‘o’, dal momento che è impossibile trovare un minore di anni 6 che sia anche
un soldato. Al posto della congiunzione ‘e’, nel primo dei due significati,
Peano usa il simbolo ∩, e, per il secondo significato, cioè nel più comune
significato di ‘o’, usa il simbolo U. Ma ancora si hanno delle ambiguità nell’uso
della disgiunzione ‘o’. P.es., nella proposizione “è necessario che venga uno
studente o un professore”, non è affatto chiaro se basti che venga uno
qualsiasi dei due o, eventualmente anche tutti e due, oppure se sia da pensare
che con la precedente affermazione si pretenda invece che la venuta dell’uno
debba escludere categoricamente la venuta dell’altro. Il primo significato si
suole dire “disgiunzione inclusiva”
ed il secondo, “disgiunzione esclusiva”.
Nel seguito converremo che il segno U debba intendersi solo nel primo
significato; non sarà necessario introdurre un segno speciale per il secondo
significato, perché, come vedremo, lo si potrà esprimere mediante la combinazione
di altri segni.
Un’altra comunissima ambiguità della lingua
italiana ha a che fare con la negazione; infatti, alle due proposizioni, “non e
venuto nessuno studente” e “non è venuto alcuno studente”, si suole dare lo
stesso significato, tuttavia si dice che “nessuno = non alcuno” e anche si dice
che due negazioni affermano! Peraltro, in molte frasi il “non” ha solo valore
pleonastico, per cui la sua presenza o assenza non altera per niente il
significato della frase.
Nel seguito per la negazione useremo il segno
~ .
Finora abbiamo introdotto sette segni
speciali per altrettante costanti logiche:
=, Î, É, $, ∩, U, ~ .
Tuttavia tutte queste costanti non sono “logicamente indipendenti”, nel senso
che alcune di esse possono essere legate alle altre per mezzo di opportune
definizioni nominali. In altre parole, possiamo, se vogliamo o se lo riteniamo
utile, sceglierne solo alcune per fungere da “termini primitivi” e considerare le altre come “termini derivati”,
cioè definiti a partire dai termini primitivi, mediante appropriate
asserzioni della forma (1).
Risulta irrilevante la scelta dei termini che
si vogliano assumere come primitivi, scelta che dipende dagli scopi. Spesso si
sceglie la via di minimizzare il numero dei termini primitivi, ma anche questo
si può fare in più modi.
Facciamo alcuni esempi:
Supponiamo di introdurre la definizione
(2) ![]()
Per il momento converremo che il segno ∩ debba stare sempre tra due
classi e che il risultato dell’operazione sia ancora una classe e converremo,
anche, che il segno ~ si applichi sempre ad una classe e produca la classe
complementare.
Quindi, la (2) significa che dobbiamo prima
trovare l’“intersezione” delle classi
a e b e dopo trovarne il “complemento”.
Possiamo compiere delle “operazioni fisiche elementari”, con carta e penna, che
modellizzino le precedenti operazioni logiche. Tali modelli si sogliono
chiamare “diagrammi di Venn”. Tali
diagrammi consistono nel disegnare, nel piano, opportune figure geometriche
chiuse, p. es., cerchi e intersezioni tra cerchi.
Con tali figure possiamo rappresentare le
varie classi. Ogni punto entro il perimetro di una delle figure rappresenta un
individuo della corrispondente classe. P. es.. la classe a∩b è rappresentata dall’area in
grigio nel seguente diagramma.

La classe ![]() sarà rappresentata da tutto il resto del piano, quando ne
venga esclusa la porzione in grigio.
sarà rappresentata da tutto il resto del piano, quando ne
venga esclusa la porzione in grigio.
Assumendo l’operatore “~” (detto spesso “operatore di Sheffer”) come termine primitivo si possono
definire nominalmente, come si verifica facilmente aiutandosi con i rispettivi
diagrammi di Venn, le costanti logiche ~, ∩, U con le seguenti definizioni
nominali:
(3) ![]() .
.
Con la (3) si definisce il “complemento” di una classe; per brevità
possiamo porre:
(4) ![]() .
.
Asseriamo come assioma la:
(5) ![]() .
.
Successivamente possiamo definire nominalmente l’“unione” tra
due classi con la:
(6) ![]() ,
,
e,
ancora, l’“intersezione” tra due classi con la:
(7) ![]() .
.
Questo risultato ci invita a sottintendere il segno ∩ con la seguente definizione
nominale:
(8) ![]() .
.
Con le precedenti definizioni abbiamo eliminato tre simboli mediante l’introduzione di un unico simbolo che funge da termine primitivo. Tuttavia è utile mantenere tutti e quattro i simboli, per rendere più brevi e più perspicue le formule, fermo restando che, quando si vuole, è sempre possibile sostituire, usando le definizioni nominali precedenti, tutti i termini derivati con l’unico termine primitivo ~, come già abbiamo fatto nella (7).
Possiamo anche eliminare dal novero dei
termini primitivi la costante logica É ponendo per definizione:
(9)
(a É b) = (ab = a).
Notiamo che l’operatore ~ (e conseguentemente anche
~, ∩, U) opera
su due classi e produce una classe. Mentre la relazione É opera tra due classi e produce una
proposizione, tuttavia anche la (9) è verificabile con operazioni fisiche
elementari costruendo l’opportuno diagramma di Venn.
Finora abbiamo incontrato quattro tipi di
proposizioni:
(10) x
Î a ,
(11) x
= y ,
(12) a
É b ,
(13) $a ,
la (10) lega un individuo ad una classe; la (11) lega tra loro due termini ed è irrilevante che essi siano individui, classi, proposizioni, o qualsiasi altro oggetto, anche al di fuori dei termini propri della logica, purchè abbiano un significato; la (12) lega tra loro due classi; la (13) afferma una particolare proprietà di una determinata classe.
Tuttavia notiamo che i termini della logica: “individuo”, “classe”,
“proposizione”, hanno significato puramente “formale” e
nessun significato “reale”. P. es.:
Socrate Î filosofo,
filosofo Î classe,
(Socrate Î filosofo) Î proposizione.
Nella prima “filosofo” compare come classe,
nella seconda come individuo, nella terza: la proposizione “Socrate Î filosofo” compare come individuo e
“proposizione” compare come classe.
Da questi esempi viene l’idea di abolire i
termini “individuo, classe, proposizione”,
con l’adottare la convenzione che i termini che figurano a sinistra di Î si debbano sempre intendere come “individui”, i termini che
figurano alla sua destra si debbano intendere come “classi” e gli oggetti della forma “x Î a”
siano le “proposizioni elementari”. Tuttavia per far questo dobbiamo prima
poter ridurre le proposizioni (11), (12), (13) alla forma elementare (10).
Allo scopo conviene introdurre alcune altre
costanti logiche.
Introduciamo l’operatore ι che, operando su di un termine qualsiasi y, lo
trasformi in una classe a= ιy,
tale che “solo” per l’oggetto al quale abbiamo dato il nome y abbia
senso scrivere y Î a.
Avremo:
(14) (y
Î ιy) = (y
= y)
ovvero
(15) (Î ι) = (=) .
Possiamo leggere ι come “identico” e ιy come la “la classe degli identici all’individuo y”
o anche, “il nome dell’individuo y” o
“l’idea di y”.
Una classe con un solo individuo della forma a = ιx la chiameremo un “elemento” (viene chiamata anche “idea”, “atomo”, “singleton”).
Possiamo, se vogliamo, eliminare formalmente il
segno =, mediante la (15), dal novero dei termini primitivi, introducendo ι
come termine primitivo, scrivendo:
(16) (=)Î ι (Î ι) .
Ma, qualunque scelta vogliamo fare, anche la
(11) si potrà sempre scrivere nella forma (10) con la:
(17) (x
= y) = (x Î ιy) .
Allo stesso modo possiamo introdurre
l’operatore á , il quale operando su di
una classe b produce un’altra classe áb , i
cui individui sono tutte le parti di b, cioè
le sottoclassi a di b e per le quali, perciò, si ha sempre a É b.
Potremo scrivere:
(18) (a É b) = (a Î áb)
,
cioe: a è parte di b = a Î (parte di b).
Ovvero:
(19) ( É ) = ( Î á ) .
E, quindi, anche la (12) si può scrivere
nella forma (10).
Per scrivere anche la (13) nella forma (10), si
può introdurre una nuova costante logica che “formalmente” si comporti come una
classe e che però e definita da una proprietà “assurda”, cioè autocontraddittoria, cioè tale che
di nessun individuo si possa asserire che abbia una tale proprietà, o classe
che dir si voglia, che possiamo chiamare il “nulla”,
potremmo indicarla con la lettera A, abbreviazione di Assurdo, ma conviene risparmiare le
lettere dell’alfabeto, da impiegare per le variabili o per le costanti
extralogiche, introducendo in sua vece il simbolo Ù.
Allora possiamo scrivere:
(20) ($a) = ~ (a = Ù) .
Nella (20) il segno ~ nega tutta la
proposizione a secondo membro della prima identità, ma si può convenire di
porlo a negare la relazione che vi compare con significato identico:
(21) (a ~ = Ù) = ~ (a = Ù) ;
per
la (15) possiamo anche scrivere:
(22) (a
~ = Ù) = (a ~Î ιÙ) .
È ovvio che i segni ~ e Î godono della proprietà
commutativa:
(23) (~Î) = (Î~) ,
e quindi
(24) (a
~Î ιÙ) = (a Î~ ιÙ) ,
che per la (4) si può scrivere:
(25) (a
Î~ ιÙ) = (a Î ![]() ) .
) .
Infine, per le identità da (20) a (25), anche
la (13) si può scrivere nella forma (10) con la:
(26) ($a) = (a Î ![]() )
)
E così, se abbreviamo con I il termine “individuo”, con C il termine “classe”, con P il
termine “proposizione”, consentendo
che i segni É e ∩ possano operare anche tra
proposizioni, col rispettivo significato di “implica”
e della congiunzione “e” possiamo
allora porre la convenzione:
(27) ((x Î a)
Î P) É ((x Î I)
∩ (a Î C ))
,
che possiamo leggere
“se la
scrittura ‘x Î a’ é una proposizione allora ‘x’ é un individuo ed ‘a’ è una classe.”
La (27) ci permette di non nominare più i
termini I, C, P, perchè la forma x
Î a ci
dice tutto sulla natura formale dei termini che vi compaiono.
Allo stesso modo possiamo
porre:
(28) ![]()
che ci permette di formare classi a partire da altre classi, senza
bisogno di asserire esplicitamente che un dato simbolo rappresenti una classe.
Per la convenzione (27), in base alla (17),
possiamo asserire che qualunque cosa sia y, ιy è una
classe:
(29) ιy Î C ;
e, in base alla (18), anche:
(30) (
a Î C ) É ( áa Î C ) .
Dalla (10) si vede che il
simbolo “x Δ si
può considerare come un operatore, con parametro x, che indichiamo con Îx , che
ad ogni classe a fa corrispondere la
proposizione elementare ax = x Î a. Possiamo
scrivere quindi:
(31) Îx = x Î ,
(32) ax
= Îx a = x Î a .
Si può definire l’operatore inverso 'x , che ad ogni proposizione
riguardante x faccia corrispondere la classe relativa, con la
definizione nominale:
(33) 'x ax = a .
Ovviamente si ha:
(34) Îx 'x ax = ax
,
(35) 'x Îx a = a .
Allo stesso modo, se
a = ι x
si può definire l’operatore inverso di ι con la:
(36) לּ a = לּ ι x = x
Si ha, ovviamente,
(37) ι
לּ a
= ι לּ ι x = ι x = a .
L’operatore 'x , si
può interpretare come il segno per la formazione di classi e la (33) si può leggere
“la classe degli individui x per cui vale la proposizione ax”.
L’operatore ι fa passare da un individuo al suo elemento, l’operatore inverso לּ fa passare da un elemento
al suo individuo. Notiamo che il dominio dell’operatore לּ è limitato agli elementi,
cioè a classi con un solo individuo, mentre il dominio di ι non ha
limitazioni, essendo che qualunque cosa può fungere da individuo di una
determinata proposizione.
Le costanti ~, ∩, U, ̃
si possono usare anche tra proposizioni con il significato, rispettivamente,
di “negazione, congiunzione, disgiunzione
inclusiva, esclusione della congiunzione” e, analogamente alle relazioni da
(2) a (9), si possono scrivere le:
(38) ![]() .
.
(39) ![]() .
.
(40) ![]() .
.
(41) ![]() .
.
(42) ![]() .
.
(43) 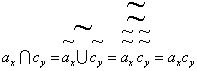 .
.
(44) ![]() .
.
(45) (ax É by) = (axby = ax) .
Analogamente alla (28) si può convenire che:
(46) 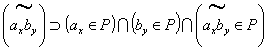 ,
,
la quale permette di formare “proposizioni
composte” a partire da “proposizioni
elementari” o da altre “proposizioni
composte”.
Se si vuole si può eliminare anche il segno Ù dai termini primitivi, per cui i
termini primitivi della logica si possono ridurre solamente a tre (p. es.
=, Î, ̃, ma, ovviamente, è
possibile scegliere, opportunamente, una terna diversa). Per far questo basta
porre:
(47) ![]() .
.
La sua classe complementare sarà:
(48) ![]() .
.
che è la classe “banale”,
della quale ogni cosa pensabile si
può considerare un suo individuo; essa si può chiamare anche il “tutto” o l’“essere”. Per cui le affermazioni x Î Ù e x Î Ú si possono semplicemente
leggere “x non è” e “x è”, rispettivamente.
Diceva Parmenide:
“Bisogna che
il dire e il pensare sia l’essere: è dato infatti essere,
mentre nulla non è”.
Senza pericolo di ambiguità, possiamo usare i
due simboli precedenti anche per le proposizioni, ponendo:
(49) Ù = $Ù ,
(50) ![]() ,
,
che possiamo chiamare, rispettivamente, la “contraddizione” e la “tautologia”,
quando riferite a proposizioni.
Quindi se p è una qualunque
proposizione, “p = Ù” si potrà leggere “p è una
contraddizione” o “p è assurda” o “p è necessariamente
falsa”, ecc. e l’asserzione “p = Ú” si potrà leggere “p è una tautologia” o
“p è banale” o “p è necessariamente vera”.
Se a è
una classe, le seguenti asserzioni:
(51) $ a = ( a ¹ Ù) ,
(52) ![]() ,
,
(53) ![]() ,
,
(54) ![]() ,
,
si possono leggere rispettivamente:
è possibile che vi siano degli individui che
hanno la proprietà a,
è possibile che vi siano degli individui che
non hanno la proprietà a,
è necessario che non vi siano individui che
abbiano la proprietà a,
è necessario che ogni individuo abbia la
proprietà a.
È noto che i logici medievali attribuivano
tali affermazioni ad una particolare estensione della logica che chiamavano
“logica modale”, ma come si vede non è per niente necessario instaurare alcuna
logica speciale, anche se oggi vi sono i moderni continuatori della logica
scolastica.7
***
Così come alcuni termini (cioè i “termini derivati”)
si possono definire a partire dai “termini
primitivi”, allo stesso modo, alcune proposizioni
(cioè i “teoremi”) si possono asserire a partire dalle “proposizioni primitive”,
le quali ultime vengono divise in “assiomi”
e “definizioni”.
Anche in questo caso è spesso possibile
scambiare il ruolo di assiomi, definizioni e teoremi, la scelta è irrilevante
purché si arrivi, alla fine, alle stesse proposizioni, mediante l’uso di
appropriate “regole deduttive”. Quindi
anche questi termini hanno solo valore “formale”. Un insieme di “assiomi, definizioni, teoremi e regole
deduttive” si dice un “sistema
deduttivo”. Due sistemi deduttivi che abbiano lo stesso insieme di
proposizioni asserite, anche se con diversa scelta degli assiomi e delle
definizioni, si dicono “equipollenti”.
Per il sistema deduttivo della “logica”, le regole deduttive possono essere molto semplici. Noi useremo le tre seguenti:
I) In ogni proposizione asserita si può
sostituire qualsiasi simbolo che rappresenti una “variabile” con un qualsiasi
altro simbolo di variabile, con la “condizione” che la stessa sostituzione
debba effettuarsi in tutti gli altri posti in cui la detta “variabile” compaia
col medesimo significato reale.
II) In ogni proposizione asserita se ‘a’ è un
simbolo o un qualsiasi gruppo di simboli, esso si può sostituire (anche senza
la “condizione” posta in I) con un qualsiasi altro simbolo o gruppo di simboli,
per esempio ‘b’, ma solo nel caso che nel sistema sia stata asserita la
proposizione ‘a . = . b’ (con . =
. indicheremo le identità logiche
esplicitamente asserite nel sistema, per distinguerle dalle identità interne ai due membri dell’identità
asserita).
III) Se
nel sistema compare l’asserzione ‘a = b’,
dove ‘a’ e ‘b’ sono simboli o gruppi di simboli, se ‘O’ è un operatore che ha
senso applicare ad ‘a’ o a ‘b’, allora anche la proposizione ‘Oa = Ob’ è
un’asserzione del sistema.
Con le tre regole precedenti, a partire dalle
“proposizioni primitive” del sistema (“definizioni”
o “assiomi”),
si possono “dedurre” tutte le
altre proposizioni del sistema (“teoremi”).
In questo sistema è proibito formare
proposizioni della forma a Î a. Tali
proposizioni porterebbero a delle contraddizioni, infatti, se sostituiamo Ù al posto della generica classe a otterremmo Ù Î Ù che sarebbe una contraddizione dal momento
che per definizione Ù non ha alcun individuo,
nemmeno se stesso. Se si esclude tale proposizione per il Ù allora resterebbe la possibilità di definire
delle classi che non contengono la classe stessa come individuo (“classi
aperte”) e quelle complementari che la contengono (“classi chiuse”) e si
arriverebbe al cosiddetto paradosso di Russell:8 formiamo la classe degli “aperti”: A .
= . 'a (a Ï a)
e quella dei “chiusi”: Ã . = . 'a (a Î a). Si ottiene: A Î A . = . A Î Ã, sia
che asseriamo che A è aperta, sia che
asseriamo che A è chiusa. Il
paradosso riposa sulla confusione tra proprietà formali e proprietà reali, cioè
non riconoscendo che il termine “classe” esprime solo una proprietà formale e
nessuna proprietà reale. È come affermare che “predicato è un predicato” o che
“soggetto è un soggetto”!
Quindi nel metalinguaggio si dovrebbe
asserire:
( a Î C ) É ((a Î a ) ÏP) ∩ ((a Î ã ) ÏP)
Ma in effetti bisognerebbe asserire una limitazione
più forte in modo da escludere la possibilità di formare classi in cui
compaiano insieme sia individui che classi formate con tali individui, tutti
considerati come individui dello stesso livello.
Non è per niente facile formulare in astratto
una tale condizione, tuttavia nei casi concreti della fisica, o di qualunque
altra scienza empirica, la cosa risulta sempre banale.
Tale ultima soluzione viene scartata dai
metamatematici moderni che vogliono fondare la teoria dei numeri senza fare
alcun riferimento alle concrete operazioni fisiche, come proposto da Dedekind e
da Cantor e come caldeggiato da Hilbert.
Modernamente, per superare le contraddizioni
di tali autori, dovute al fatto che trascuravano la distinzione, introdotta dal
Peano, tra le due relazioni Î e É, si accetta di escludere proposizioni della
forma x Î x, ma si postula la
legittimità di classi della forma a′ = a U ι a , che definisce il successore di un
“numero”, avendo identificato un singolo “numero” con un “insieme”. Per cui si ha
che per due numeri qualsiasi si può tranquillamente scrivere a Î b e a É b, cosicché,
alla fine, la classe dei numeri viene generata tutta intera dall’insieme vuoto
e si può ripetere la creazione dal nulla, cosa che prima era riservata solo a
Dio e, per di più, si ha che, contemporaneamente, si può avere x Î y e y Î x. È
impossibile dare un qualche significato reale a tali asserzioni.
***
Nelle notazioni precedenti abbiamo descritto
sinteticamente la “grammatica della logica” o, come equivalentemente si dice
l’“algebra della logica”, nel precedente articolo di Boscarino e
nell’Appendice di scritti di Peano è sintetizzata la “logica della grammatica”
che potremmo anche chiamare l’“algebra della grammatica”, in entrambi i casi si
tratta della “forma della forma”.
Tuttavia senza “forma” e senza l’analisi
formale di essa non si può parlare del reale.
Si scopre che, con l’uso di tale linguaggio
simbolico, si può ricostruire la fisica di quegli antichi scienziati, dei quali
ci è pervenuto qualche frammento del loro pensiero o, comunque, qualche
testimonianza riportata da scrittori posteriori.
È noto che sumeri ed egizi, fin da secoli
molto remoti (XVIII a. C.), possedevano notevoli cognizioni di aritmetica, di
geometria e di astronomia, ma le informazioni che si hanno sulla loro fisica
sono troppo scarne per poter concludere alcunché, anche se molti scrittori
posteriori ad Aristotele fanno risalire ad essi i principi della scienza degli
antichi popoli di lingua greca che abitavano la Ionia, la Sicilia e l’Italia
meridionale intorno al secolo VI a. C., laddove sono state gettate le basi
della nostra scienza.
Le informazioni che abbiamo su questi ultimi
sono anch’esse molto scarne e tuttavia ci permettono di formarci un quadro
abbastanza coerente del loro modo di intendere la scienza fisica.
Due tradizioni diverse si sono scontrate nel
passato, e continuano a confrontarsi insino ad oggi, in relazione ai postulati
metafisici, che bisogna pregiudizialmente assumere prima di iniziare lo studio
della natura.
Nella prima tradizione, che per brevità
chiameremo “empirista”, nata e sviluppatasi prevalentemente tra gli “ionici”,9 la realtà fisica viene identificata
con il dato dei sensi e tuttavia viene postulato un principio materiale unico che
pervade l’intero cosmo. Secondo tale concezione gli oggetti del mondo fisico
non sono altro che aggregazioni, più o meno dense, di un tale unico sostrato,
che per Talete era l’acqua, per Anassimene l’aria e per Anassimandro una
sostanza indefinita. Il movimento era spiegato come una serie di successive
condensazioni e rarefazioni di tale sostrato. Oggi chiameremmo tale concezione
una “teoria di campo”.
Nella seconda tradizione, che per brevità
chiameremo “razionalista”, nata e sviluppatasi prevalentemente tra gli italici,
la realtà sensibile è solo apparenza. La vera realtà coincide con la nostra
ricostruzione razionale del dato dei sensi, il quale è solo un caos sensoriale
da cui nessun principio si può trarre. Gli oggetti del mondo fisico non sono “complessi
di sensazioni” (questo termine si deve a Mach che era un ardente sostenitore
della concezione empirista della scienza fisica) ma sono definiti solo da
determinate proprietà, che prima d’ogni cosa devono soddisfare il principio di
non contraddizione. Se di un qualche individuo x noi affermiamo che ha
una data proprietà, diciamo a,
allora è proibito dire che esso non ce l’ha. Con i nostri simboli: se x
Î a allora
è impossibile affermare che x Î ã.
Questo porta i pitagorici a formulare la
teoria dei contrari e il conseguente principio di dicotomizzazione, il quale,
tuttavia, se applicato agli oggetti sensibili, come faceva Platone, porta a
conseguenze assurde.
Ma vediamo come si può formulare la teoria
degli “italici”, che porta necessariamente a quella che oggi chiameremmo una
“teoria di particelle”.
Dal momento che la vera realtà è una pura
ricostruzione razionale ne deriva che i termini primitivi del discorso
scientifico, li creiamo noi. Questo ci permette e, in un certo senso, ci
obbliga ad inventarli in modo che ogni termine possa avere un significato
univoco, per cui nel linguaggio scientifico non devono permettersi degli
slittamenti semantici e bisogna perciò evitare, finché possibile, i sinonimi e
gli omonimi, a meno che, allo scopo di non moltiplicare inutilmente i termini,
non ci sia alcun pericolo di provocare ambiguità.
In qualunque nostra proposizione noi,
esplicitamente o implicitamente, usiamo il termine “è”, voce del verbo “essere”, allora primariamente
dobbiamo chiarire il significato di questo termine e se scopriamo che, nella
lingua comune, esso sta per diversi significati bisognerà aggiustare
convenientemente il linguaggio scientifico per evitare i paradossi e le
contraddizioni.
E così Parmenide pretende che l’“essere” abbia il solo significato di
essere pensato astrattamente come logicamente necessario, indipendentemente da
qualunque particolare proprietà, e quindi può solo essere “limitato”, in quanto concluso in se, “immobile”, in quanto fisso nella
sua identità con se stesso, “omogeneo,
isotropo, e senza tempo” in
quanto, non avendo altre qualità in nessun modo i suoi elementi possono
differire tra loro; in una parola, esso è il “tutto” o, nella terminologia da noi prima introdotta, la “proprietà banale”, il Ú.
La proprietà complementare, il “non-essere”, sarà, per
conseguenza, l’“essere contraddittorio”,
il “nulla” e, perciò stesso, “impossibile ed inesprimibile” e cioè
la “proprietà assurda”, il Ù.10
Ne possiamo dedurre che, senza introdurre
altre proprietà, che siano diverse dall’essere e dal non-essere, il diagramma
delle inclusioni, che rappresenta il reticolo delle proprietà, deve essere
costituito solo dagli estremi di un segmento, agli estremi del quale possiamo
porre i punti Ú e Ù.
Per descrivere il mondo delle apparenze
bisognerà allora concepire altre proprietà, e quando ne avremo concepita una,
automaticamente con lo stesso atto di pensiero, ne avremo concepito anche
quella complementare. Infatti per i pitagorici sono le coppie di contrari che
generano tutta la realtà razionale (il logos)
e ordinata (il cosmos).
Quando diciamo “spazio fisico” o “materia”, tali
nomi non rappresentano enti sensibili, i quali ultimi non sono altro che
sensazioni informi e mutevoli, in dipendenza dalle nostre condizioni, anche
psichiche ed emotive, di osservazione; essi sono, piuttosto, dei principi
logici ordinatori, mediante i quali noi separiamo logicamente la realtà per
successive dicotomizzazioni.
Quindi, se introduciamo il termine “natura”, con esso intendiamo parlare di
una proprietà che vogliamo contrapporre a tutto il resto; come, p. es., il
mondo dei nostri pensieri o dei nostri sogni. E se diciamo che qualcosa esiste
in natura, intendiamo semplicemente dire che esiste nello spazio-tempo. E i
punti dello spazio-tempo possono essere “materia”
o “non materia = spazio vuoto”. Per cui, i punti dello
spazio vuoto esistono allo stesso modo dei punti materiali; poiché se dicessimo
che non esistono ci ridurremmo di nuovo ad un diagramma delle inclusioni con la
sola diade {Ú , Ù}.
Finché non introduciamo altre proprietà la
materia resterà indistinta e incapace di rendere la varietà e la complessità
delle nostre sensazioni. La prima proprietà che bisogna introdurre è la
proprietà dell’estensione, mediante il concetto di distanza tra due punti, di
area di una superficie, di volume di un corpo. Queste “grandezze”, indicizzate dai loro rapporti, cioè i “numeri”, sono la vera essenza
del mondo.
E, tuttavia, queste proprietà, noi non le
traiamo dai nostri sogni o dalle nostre fantasie, ma dalle concrete “operazioni fisiche” che compiamo. Ecco
una discriminante importantissima, il mondo reale è sì una nostra ricostruzione
logica ma essa viene astratta dalle operazioni concrete fisiche elementari.
Gli elementi sono “operazioni logiche” che rispecchiano (cioè stanno in
corrispondenza biunivoca con) le “operazioni
fisiche” e quindi non sono fantasmi. È vero che noi possiamo parlare con
coerenza formale del mondo iperuraneo o del sesso degli angeli, ma non è di
questo che si occupa la fisica, anche se noi, per poter fare riferimento
all’empirico, dobbiamo ipostatizzare le particolari proprietà e attribuire ad
esse un’“essenza” , fermo
restando che il dato dei sensi è mera “apparenza”.
Per cui, gli “enti”, siano essi sensibili o immaginari, non
possono costituire gli “elementi”;
gli “enti”, al contrario, non sono altro che il
risultato ultimo di “relazioni logiche”,
e di “rapporti” tra grandezze (λόγος)
che sono simboleggiati dai “numeri”.
La natura, cioè il mondo fisico, è
caratterizzato dalla proprietà dell’estensione che dicotomizza l’“essere
parmenideo” in due classi non nulle: idee di oggetti che hanno estensione e
idee di oggetti che non hanno estensione, “essere fisico” ed “essere mentale”.
A sua volta l’essere fisico si dicotomizza in “materia” e “vuoto”.11
La fisica di Archimede è un chiaro esempio di
tale paradigma.
Secondo i filologi sembra che le prime opere
di Archimede fossero state quelle che riguardavano la fisica; da esse sono
nate, successivamente, quelle matematiche, ma sempre rivolte alla soluzione di
determinati problemi concreti, anche se di natura squisitamente teorica. I due
ordini di problemi non erano mai scissi nella sua mente come, chiaramente,
emerge dal suo “Metodo Meccanico” per
la soluzione di problemi di calcolo di superfici e di volumi di determinate
figure; metodo che prelude, in modo di già maturo e consapevole, al calcolo
integro-differenziale, anzi, secondo il Peano, la differenza con il calcolo
moderno, è solo una questione puramente linguistica e non concettuale.
Si può dire che, per quanto riguarda la statica e la cinematica, niente è stato aggiunto, nei tempi
moderni, alle grandi scoperte di Archimede, se non un linguaggio simbolico più
funzionale; che, per altro, non è molto recepito nei libri di testo della
nostra scuola, se non in una forma parziale e alquanto distorta.
Ad Archimede si rifaranno i fondatori della
fisica moderna, con in testa Galilei e Newton, dopo la lunga parentesi della
pseudoscienza platonico-aristotelica.
Esaminiamo ora l’evoluzione del paradigma
opposto, cioè quello degli ionici; paradigma che, alla fine, sfocerà in due
paradigmi diversi che, pur avendo qualcosa in comune, che li distingue dal paradigma
che da Pitagora va a Democrito e ai sofisti, hanno, d’altra parte, elementi
fortemente divergenti tra loro.
L’elemento in comune è rappresentato dalla
netta separazione tra scienza teorica, o “scienza” tout court (essa viene oggi
qualificata, invece, come “metafisica”)
e arti meccaniche, che oggi si tende a qualificare come “scienze” (al
plurale). Il punto di contrasto, tra i due paradigmi, sta nell’oggetto
principale di indagine. Contrasto che porta ad una netta divergenza sul ruolo
che bisogna assegnare alla matematica.
Così, per Platone, la scienza consiste
nell’indagine dell’animo umano dove, scimmiottando i pitagorici, dei quali
Platone si dichiarava il vero continuatore, in contrapposto a Democrito e ai
sofisti (i quali, d’altra parte, anch’essi sostenevano di essere pitagorici),
si illudeva di astrarre un mondo ideale “realmente”
esistente ma di assoluta perfezione; solo a questo mondo poteva essere
applicata la matematica, scienza pura e incontaminata per eccellenza, e sarebbe
stato delittuoso applicarla ad argomenti di meccanica, come si permettevano di
fare alcuni suoi amici pitagorici, che pure ammirava e che ricercava, allo
scopo di apprendere la matematica (ma sembra che il risultato non sia stato
molto proficuo12).
Giustamente Aristotele criticava questo presunto pitagorismo, e anche se per costui i pitagorici erano criticabilissimi, tra la teoria platonica e quella pitagorica, mostrava che avrebbe preferito quest’ultima, naturalmente se fosse stato costretto a scegliere.
Quindi il problema della relazione tra mondo del pensiero e mondo dei
sensi veniva risolto da Platone negando il problema: si lasci il secondo ai
meccanici e occupiamoci del mondo iperuraneo dove solamente possono esistere i
numeri ideali e perfetti, le figure geometriche perfette, gli animi perfetti e
le repubbliche perfette; e se volete una repubblica terrena, quasi perfetta,
affidatela ai filosofi. Mi pare di poter dire che questo genere di platonismo è
molto influente nella nostra cultura scientifica, particolarmente nei settori
della matematica e anche della fisica teorica, dove, però, si divide il campo
con il paradigma aristotelico e tali due atteggiamenti, spesso, convivono nella
stessa persona.
Nel paradigma aristotelico, pur convenendosi
con Platone che la scienza è cosa ben diversa dalla meccanica, pur convenendosi
che la matematica non è utile allo studio della fisica, in quanto gli oggetti
della matematica sono perfetti e quelli della fisica non lo sono, anche perché
sono in movimento (qui, Aristotele fa eccezione per l’astronomia, per il
semplice fatto che in essa predomina, a suo parere, la perfezione che è
rappresentata dal moto circolare, proprio delle sfere celesti), tuttavia la
fisica in quanto scienza, al pari delle altre scienze empiriche, si deve
occupare solo di classificare i fenomeni; gli strumenti per tale tassonomia
vengono forniti dalla metafisica con l’ausilio della sua logica, che altro non
è che l’analisi grammaticale, alla quale viene aggiunta la chiave universale
del sillogismo.13
Sbagliano quindi, per Aristotele, i
pitagorici a usare numeri e grandezze per ricostruire il mondo, anche se numeri
e grandezze, a differenza di quanto pensava Platone, sono molto utili per le
arti applicate, da lui poste in un gradino intermedio tra gli interessi del
filosofo e quelli del manovale. Un pò di questa metafisica sembra emergere
dalle moderne logiche quantistiche, da certe interpretazioni “operazionaliste” della fisica moderna e
dalle reinterpretazioni moderne della “fisica
classica”.
Da queste brevi considerazioni sulla scienza
degli antichi ricaviamo alcune importanti conclusioni:
1) La cosiddetta ‘realtà sensibile’ non è la
“Realtà” ma pura “Apparenza”, illusione creata dai nostri sensi, come ben
diceva Parmenide.
2) La “Realtà” è la ricostruzione razionale della realtà sensibile mediante le regole “formali” della logica, costruite mediante una coerente “Astrazione” dalle nostre operazioni fisiche elementari ricostruibili sulla carta con strumenti elementari come riga e compasso, ecc.
3) Dal momento che la realtà sensibile è
troppo complessa e mutevole da istante a istante, come riconosceva Eraclito, la
sua ricostruzione razionale può avvenire solo mediante un processo di
“Idealizzazione” mediante l’invenzione di opportune “idee” o “elementi” o
“atomi” cuciti insieme in un “Reticolo” matematico di inclusioni logiche. Solo
tale ricostruzione soddisfa la nostra “Ragione”, ma naturalmente non ci dà
nessuna emozione.
4) Per ricostruire nella nostra “Memoria” le
emozioni della nostra esperienza passata (oggi bisogna includere le
“esperienze virtuali” create con mezzi informatici!) bisogna ricorrere alla
“Poesia” che, in quanto tale, si affranca dalle regole della grammatica e anche
della logica ma anch’essa ha la sua algebra che opera sugli “elementi” della
fantasia e del sentimento.
5) Chi confonde la Forma con la Realtà non
può fare né scienza né poesia, ma solamente chiacchiere inutili.
NOTE
1.
S. Notarrigo, Il linquaggio
scientifico dei Presocratici analizzato con l’ideografia di Peano, in Ripensando Peano e la sua scuola, Quaderni
di Mondotre, suppl. ai N. 4 – 5,
ottobre 1989. TORNA
2.
S.
Notarrigo, Archimede e la fisica, Atti del convegno Archimede-Mito, Tradizione, Scienza,
Siracusa – Catania, 9 - 12 ottobre 1989, a cura di C. Dollo, Ed. Olschki,
Firenze, 1992, pag. 381. TORNA
3.
Le
precedenti e seguenti distinzioni ed esempi si devono al grande matematico
italiano Giuseppe Peano, che in modo insuperabile ha condotto a termine il
sogno di Leibniz al quale prima abbiamo accennato. TORNA
4.
Oggi
per quest’ultima relazione vengono impiegati diversi simboli, come =, º, «, Û, ciò si fa allo scopo di distinguere
l’identità logica da altre forme di equivalenza; ma spesso molti autori usano
scambiare il significato dei simboli, nel senso che alcuni usano = per
l’identità logica e º per un’equivalenza generica
e altri fanno il viceversa e così via. Naturalmente non c’è niente di male nel
far questo, dal momento che i vari segni non significano niente per se stessi,
ma significano solo per le nostre convenzioni linguistiche. Tuttavia sarebbe
estremamente utile una convenzione internazionale. Noi, seguendo Peano, useremo
lo stesso simbolo per i due significati. Il significato appropriato emergerà
sempre chiaramente dal contesto. TORNA
5.
Notiamo
che oggi quasi tutti usano, invece, i simboli Ì o Í . Noi seguiremo la scelta di Peano, per le
ragioni che emergeranno in seguito. TORNA
6.
Notiamo,
tuttavia, che i logici moderni, seguendo Russell, operano con il simbolo $ sull’individuo invece che sulla classe e
scrivono $ x a(x) che leggono
“esiste un individuo x e x ha il predicato a”. Ma noi
preferiamo seguire Peano perché, in realtà, in questo caso, non si fa nessuna
affermazione su di un individuo, ma soltanto su di una classe: infatti,
proviamo a porre x = Socrate e a = filosofo, ne verrebbe che:
“esiste un individuo Socrate e Socrate ha il predicato filosofo”. La
proposizione si trasforma in due asserzioni, di cui una esistenziale, al di
fuori della portata della logica, e l’altra qualificativa, che è lontana
dall’affermazione puramente logica con la quale si voleva semplicemente dire
che non è assurdo il pensare che vi siano individui che possano essere
filosofi. Questo semplice cambio di scrittura, apparentemente banale, ha
provocato infinite discussioni accademiche sul significato di “esistenza” e ha
fatto nascere altri rami della logica (?!), chiamate “logiche libere”, cioè
prive di quello che viene chiamato “quantificatore esistenziale”, $ x, riferito all’“individuo” x:
nei fatti si tratta solo di vacui formalismi pseudogrammaticali. TORNA
7.
Anche
il simbolo ![]() si fa operare, dai
seguaci di Russell, sugli individui invece che sulle classi: essi introducono
il “quantificatore universale”, ", e scrivono ~ $ x ã (x)= " x a(x) , che leggono
“per ogni individuo x, x ha il predicato a”. TORNA
si fa operare, dai
seguaci di Russell, sugli individui invece che sulle classi: essi introducono
il “quantificatore universale”, ", e scrivono ~ $ x ã (x)= " x a(x) , che leggono
“per ogni individuo x, x ha il predicato a”. TORNA
8.
Russell
fu condatto a tale paradosso nel fallito tentativo di conciliare la
dimostrazione di Cantor circa l’impossibilità che esista un numero cardinale
massimo con la sua personale ipotesi, successivamente abbandonata, che la
classe di tutti i termini debba necessariamente avere il massimo numero
possibile di individui. TORNA
9.
Con
il termine “ionici” intenderemo quella scuola di pensiero che si fa nascere con
Talete e nella quale Diogene Laerzio, indipendentemente dalla provenienza
geografica dei singoli pensatori, pone anche Platone ed Aristotele. Allo stesso
modo, con il temine “italici” intenderemo sia i pitagorici che la scuola di
Elea: fra gli italici Diogene Laerzio pone anche i pensatori della scuola degli
atomisti, compresi Democrito ed Epicuro.
TORNA
10.
Dai
frammenti di Parmenide: “…bisogna che il dire e il pensare sia l’essere: è
dato infatti essere mentre nulla non è…allontanati da coloro che nulla sanno e
vanno errando, gente dalla doppia testa: perché è l’incapacità che nel loro
petto dirige l’errante mente: ed essi vengono trascinati insieme sordi e
ciechi, istupiditi, gente che non sa decidersi, da cui l’essere e il non essere
sono ritenuti identici, per cui di tutte le cose reversibile è il cammino.”. TORNA
11.
Simplicio
riporta una citazione di Aristotele in cui si legge: “Democrito ritiene che
la materia di ciò che è eterno consiste in piccole sostanze infinite di numero;
e suppone che queste siano contenute in altro spazio (cioè diverso da quello
occupato dalla materia stessa), infinito per grandezza; e chiama lo spazio coi
nomi di “vuoto” e di “niente”(=non-ente) e di “infinito”, mentre dà a ciascuna
delle sostanze il nome di “ente” e di “solido” e di “essere”. Egli reputa che
le sostanze siano così piccole da
sfuggire ai nostri sensi: esse si muovono nel vuoto …e si incontrano legandosi
nel contatto reciproco per un certo tempo, egli dà la causa ai collegamenti e
alle capacità di adesione degli atomi.. ed essi si tengono attaccati gli uni
agli altri e rimangono in contatto solo fino a quando, col sopraggiungere di
qualche azione esterna, una necessità più forte non li scuota violentemente e
li disperda in varie direzioni”. TORNA
12.
“Alcuni autori attribuiscono a Platone degli studi sugli irrazionali
(Baltzer, Elem. d. Mathem. a. 1885 p. 100; Encyclop. P. 49). Invero nei
dialoghi di questo filosofo trovansi qua e là dei termini matematici, ma
riuniti in modo così incerto da farli ritenere come parole difficili con cui un
interlocutore cerca confondere l’avversario: all’incirca come nei giornali
politici del giorno d’oggi sta scritto incommensurabile invece di grandissimo.
Il passo più volte citato, nella Πολιτεία VIII 546 è considerato dai commentatori
Jowett and Campbell, Oxford a. 1894, come un riddle. Al più da un passo del Θ
ε α ìτ ή τ ο ς 143 E, si può dedurre ![]() , e ciò parmi la cosa più importante contenuta in quelle
opere su questo soggetto”, tratto da: G. Peano, Opere scelte, vol.
III, Ed. Cremonese, Roma, 1958, p. 249.
TORNA
, e ciò parmi la cosa più importante contenuta in quelle
opere su questo soggetto”, tratto da: G. Peano, Opere scelte, vol.
III, Ed. Cremonese, Roma, 1958, p. 249.
TORNA
13.
“È noto che la Logica scolastica non è di sensibile utilità nelle
dimostrazioni matematiche: poiché in queste mai si menzionano le
classificazioni e le regole del sillogismo…”, ibidem, II, p. 80 e nel Dizionario di
Matematica: “Logica matematica è la scienza che tratta delle
forme di ragionamento che si incontrano nelle varie teorie matematiche
riducendole a formule simili alle algebriche. Essa ha a comune alla logica
d’Aristotele il solo sillogismo. Le classificazioni dei vari modi di
sillogismi, quando sono esatte, hanno in matematica poca importanza. Nelle
scienze matematiche si incontrano numerose forme di ragionamento irreduttibili
a sillogismi.”, tratto da: ibidem, II, p. 379. TORNA